Ciò che segue è la digitalizzazione dell’opera scritta dal Canonico DOMENICO DE PALMA
Tale operazione di digitalizzazione, volta a una più semplice e duratura consultazione del testo, è stata fortemente voluta dalla FONDAZIONE “LA PICARELLA – FAMIGLIA PATELLA E CARLO RICCHETTI”, della cui cura e realizzazione è stato incaricato PETITTI ANTONIO. La digitalizzazione consta di una fedele e quanto più accurata versione dell’originale cartaceo del 1890 e rieditato nel 1983.
NOTA PER IL LETTORE
La Civica Amministrazione di Castelluccio Valmaggiore, dimostrando un profondo senso di responsabilità storica, ha patrocinato la ristampa delle: “Notizie Storiche intorno al Comune e al Clero di Castelluccio Valmaggiore” del Canonico Domenico De Palma, perché la conoscenza dell’opera – che nel passato è stata limitata ad un ristretto gruppo di persone per le pochissime copie esistenti – diventasse patrimonio culturale di tutta la cittadinanza. Il volume è stato arricchito di documentazione fotografica, del Sig. Aldo Genovese; sui luoghi descritti dall’autore.
Si auspica che la presente edizione dell’Opera, che si colloca nell’ambito delle correnti storiografiche più progressiste, che mirano alla rivalutazione dei “valori popolari”, dia un cospicuo contributo alla riscoperta e all’acquisizione delle nostre radici culturali, la cui valenza formativa è indiscussa in un processo di crescita umana e sociale.
Castelluccio VM, 24 giugno 83 festività di S. Giovanni Battista
Dott. Giovanni Campanaro
NOTIZIE STORICHE INTORNO AL COMUNE ED AL CLERO DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
RACCOLTE ED ILLUSTRATE
DAL CANONICO DOMENICO DE PALMA
LETTORI CARISSIMI
Nel pubblicare per le stampe questo piccolo lavoro di storia patria, emancipandomi dalla quasi generale costumanza, ho creduto di non farlo precedere da pomposa dedica a persona di merito. Naturalmente avrebbe potuto sorgere sospetto che, per al povertà della materia, e per la disadorna dicitura, avessi avessi preteso raccomandarlo alla pubblica benevolenza, ornato di mendicate vesti. Non era giusto che i valentuomini che si fossero prestati alla mia offerta, sacrificato avessero qualche poco del loro decoro, a mio peculiare profitto ed onore. Ognuno sostener deve la responsabilità delle proprie idee, dei propri atti; ed io non declino la mia, ed accetto anticipatamente, con riconoscenza, la critica ragionata che, in qualunque modo e tempo, mi verrà fatta.
Solo, miei cari lettori, bisogna prevenirvi, per implorare la vostra indulgenza, che nel raccogliere queste notizie, mi avea in animo di preparare semplicemente poco materiale, pei giovani amanti di questi studi, senza intendimento di renderle di pubblica ragione; le ho scritte perciò alla buona, senza ricercatezza di stile, e sfoggio di erudizione. Gli amici però mi impongono, con benigna insistenza, di pubblicarle. Mi arrendo, in considerazione che un manoscritto facilmente può disperdersi come vuolsi sia avvenuto ad altro simile, preparato dal Rev. Arciprete Ricchetti.
Per lasciare libero capo al naturale svolgimento e connessione de’ fatti, in varie parti, ho prescelto attenermi attenermi più all’ordine delle materie, che all’ordine cronologico. Se mi fossi diversamente regolato, la tessitura avrebbe presentato difetti molti e non lievi, per la scarsezza di eventi storici continuati. Del resto stento a credere che tale ordinamento porti imbarazzo e confusione, trattandosi di un’opera ristretta in limiti appena comportabili
Pienamente son convinto aver fatto ben poco; mi rimane però il desiderio e la speranza che altri faccia quel molto che a me non fu dato compiere, per manco di forze e di tempo. Questo compito la partia lo attende dalla generazione che sorge rigogliosa sotto il vessillo del progresso civile e letterario. A nulla gioverebbe un governo libero, se non avesse il potere e la virtù di sforzare l’attività intellettuale della gioventù, da cui dipende l’onore, ed il futuro destino della nazione.
Il lavoro ha pochi pregi e moltissimi difetti, pur tuttavolta ho fiducia che i miei concittandini lo gradiscano, come atestato dell’amoroso mio culto verso la patria.
Castelluccio Valmaggiore.
Domenico Can. De Palma
INTRODUZIONE
Cur somno inerti deseram Patriae decus? Fedro Lib. III Prologo.
Difficile est proprie comunia dicere. Orazio Epist. A Pisoni.
Opera ben ardua e malagevole si è il rintracciare l’origine de’ comuni che, per grafica postura e niuna importanza politica o militare, furono creduti dagli antichi storiografi ben poco degni di speciale menzione e d’interesse. Ma l’amore di patria è santo; e nell’epoca presente non v’ ha città, non villaggio o borgata che non cerchi disseppellire la sua primitiva fondazione, e dar vita, per così dire, alle aride ossa de’ primi abitatori, descrivendone, per quanto possibile, i costumi, l’indole, el virtù ed i vizi.
Questo lavoro, se offre molti e seri ostacoli, non deve però reputarsi impossibile, qualora voglia farsi con pazienza e discernimento. Pel buio che copre i secoli passati, se non vi avrà la reale, si otterrà almeno, e con molta probabilità, la quasi certezza.
Tal modo di narrare, respinto respinto da positivisti, che per ogni fatto, per ogni detto richieggono atti autentici e debitamente registrati, soddisferà gli altri non disposti a seguire la teoria di questa rigida scuola.
La narrazione storica non è, né può essere un parto puro dell’immaginazione, ma acquisterà certo peso ed importanza grandissima, quante volte da un fatto ammesso e ritenuto da tutti, per una serie di argomentazioni, si iungerà a precisarne altri omessi, o non chiaramente narrati. La ragione perciò, che è la suprema illuminatrice delle umane azioni, deve campeggiare negli eventi storici, come nelle altre materie scientifiche e letterarie. Qualunque narrazione, ancorchè di lieve conto, come la presente, redatta senza filosofici principi, non potendo sostenere l’austero esame delle leggi critiche, risulterà vuota di interesse e noiosa.
La maggior parte de’ piccoli comuni della nostra Italia, specialmente quelli fondati nei primi secoli del medio evo, si trovano privi di dati precisi cronologici, che chiaramente ne additino l’epoca, come, e da chi furono edificati e popolati.
Erano tempi di ignoranza: la forza brutale dei barbari invasori imperava nella maggior parte della penisola Italiana; e quella che ubbidiva ancora alla civile Costantinopoli, lasciata a se stessa da un governo insipiente, ed insufficiente a farsi ben rispettare, cercava vivere ignorata nell’oscurità.
In quei tempi fortunosi, i pacifici cittadini, gli uomini dediti al lavoro de’ campi, ed alla pastorizia, non chiedevano di mettersi in mostra, ma occultarsi peregrinando ne’ monti, ed in contrade meno frequentate; paghi di poter nascondere, in quelle balze, il tugurio e la gleba, da cui ritraevano il necessario alla grama di loro vita.
Per maggiore i popoli, anche di una stessa regione, non si trovavano tra loro uniti da vincoli e patti sociali. Mancava un governo forte e stabile per poterli affratellare; anzi se ne temea l’unione.
Ognuno vivea a se, limitando la sfera delle proprie sollecitudini al tenimento che volevasi custodire e proteggere.
I pochi scrittori di storie patrie di quei tempi non aspiravano che ad illustrare le grandi città, lieti di poterne descrivere le lotte spietate, che ambiziosi dominatori combattevano per contestarne il possesso; il valore de’ cittadini nella pugna, la pertinacia nelle ribellioni, molte fiate senza scopo prefisso e speranza sicura. Appagata la loro vanità, non s’interessavano de’ piccoli comuni che si trovavano fuori la linea d’azione, comunque, non poche volte, e nei grandi bisogni, da essi ritrassero le braccia e le derrate, per sostenere l’indecorosa lotta.
Non è in poter mio, né basta il solo buon volere per passare a rassegna tutti gli eventi, concatenarli a’ fatti generali, illustrando uomini e cose che riguardano questo comune. Mancano gli elementi necessari per una narrazione particolareggiata. Impossibilitato a redigere una cronaca regolare, mi limiterò ad alcuni cenni generali , ed a concatenare con ordine storico, per quanto il comporta la tessitura, le poche notizie particolari che, con grave stento e fatica, ho potuto raccogliere e precisare.
Son certo che le disseppellite notizie non verranno ad illustrare interamente il comune de’ miei natali, ma almeno gli daranno quel poco di vita che gli spetta nel consorzio civile, e quel posto che merita nella storia. Ad esempio mio, altri più versati nella materia per studi speciali potranno estendersi a più minute particolarità, e , svolgendo altri fatti, ridurre in miglior forma questa incompleta narrazione.
I
Castelluccio Valmaggiore poggia sopra il dorso di un colle che fa parte delle ultime propagini de’ sub-appennini Appuli, e si gode da esso lo stupendo panorama di gran parte della Puglia. Esposto a levante ed a mezzogiorno per due lati, ha clima puro e temperato, non partecipando né dell’aria grave della limitrofa pianura, né dell’elastica dei soprastanti monti. Pel rimanente, è addossato a’ detti monti, che elevandosi a gradi a gradi, formano la variante alla su amena posizione, e propizio e confortabile ne rendono il soggiorno.
La campagna trovasi scompartita da colline, vallate, e piccole pianure. Queste ultime per un lembo, tra oriente e settentrione, si confondono con quelle della Puglia.
Il suolo, comunque per natura non troppo ferace, con discreta cultura, produce in ottima quantità i principali generi di alimentazione. I vini, prima almeno che la crittograma avesse devastati gli estesi ed ubertosi vigneti, erano in provincia e fuori ricercatissimi. Presentemente la scarsezza del prodotto, produce lo scadimento del genere.
Sono rimasti principali prodotti dell’agricoltura gli olii di ulivi, ed il grano tenero detto carosella che non sofforno concorrenza, benché la cultura si trovi ancora nello stato primitivo, non sussidiata dal razionale conforto della scienza.
Produce benanche granone e civaje di ogni specie. Lo stesso può ritenersi ella frutta sì estive che invernali, di suisito gusto, e di gradevole aspetto.
Provveduto di pascoli che, per dissodazioni fatalmente inopportune, vanno di giorno in giorno restringendosi, alleva animali da servire all’industria ed al macello, e può ben dirsi: basta a se stesso.
Bisogna confessare però che, alla qualità de’ prodotti, non sempre risponde la quantità. Anzi son ben rare le annate veramente ubertose, per effetto della scarsezza di opportune piogge, e per la veemenza dei dominanti venti Libeccio e Ponente; che il popolo impropriamente chiama Favonio e Scirocco. Questo naturale squilibrio atmosferico, che ha luogo per la forte differenza che passa tra la temperatura de’ monti, e quella della pianura pugliese, svestita di ombre e fitta vegetazione, viene aggravato dal montano disboscamento. Fatto doloroso che accresce la forza del vento, e diminuisce sempre più la probabilità delle piogge, a danno de’ poveri agricoltori, che spesso rimangono delusi nelle concepite speranze, con jattura de’ consumati capitali, e colla perdita delle durate fatiche.
II
L’antico fabbricato del comune, dalla configurazione del suolo sul quale venne posto, presentava la forma di un triangolo isoscele; tutto chiuso non da regolari mura, ma dalle stesse abitazioni.
Avea tre porte, una ad oriente, altra ad occidente della base del triangolo, che è di prospetto a mezzogiorno, e la terza all’angolo superiore, o vertice del triangolo. In quest’ultimo punto che, per le dominanti vicine alture, era il lato debole, ed il più vulnerabile del paese, fu edificato il castello.
Si fa osservare: che le abitazioni di cinta non presentavano regolarità alcuna di allineamento; ma addentellato di costruzioni con sporgenze più o meno rimarchevoli, senza ordine e simmetria prestabilita. Dippiù: molte stradicciuole interne aveano comunicazioni speciali con l’esterno.
Tali sbocchi si vedeano, ed anche oggi se ne osservano alcuni, murati con fabbriche aggiunte, che a prim’occhio facilmente si ravvisano.
Questi fatti dimostrano ad evidenza, e la chiusura da servire di fortificazione, non fu contemporanea, ma posteriore all’edificazione del comune.
Del castello; la torre che ora soltanto ne rimane, è di forma rotonda; tutta fabbricata in pietra viva, nello zoccolo lavorata d’intaglio. Lo spessore delle mura nella parte superioreè di circa due metri e mezzo; maggiore nell’inferiore. La sua solida costruzione, specialmente per la bontà del cemento, è pegno sicuro che, per molti e molti anni, sfiderà l’opera distruttrice del tempo.
L’enunciata torre vien composta di due piani interamente ultimati, e di un terzo solamente iniziato. È notevole, che essa non ha porta d’accesso. Si entrava pel piano superiore, dove si osserva la saracinesca con ponte levatojo, che andava ad appoggiare nel fabbricato adjacente, destinato a caserma per la guarnigione. Dal piano superiore si ascende al terzo piano incompleto, per una scalea in pietra, praticate nella grossezza del muro: per discendere poi all’inferiore o terreno, non si vede altro che una botola, e perpendicolarmente alla medesima un anello di ferro assicurato ala volta. Questo fatto eloquentemente dimostra che tal locale servir dovesse a rinchiudervi i prigionieri, o i militi del presidio in punizione, i quali si faceano discendere con apposite pulegge, ed altri congegni meccanici, in uso per la calata ne’ pozzi, Per le luce e la circolazione dell’aria, non avea questa muda, che piccoli spiragli, in forma di feritoje, molto alti dal suolo che, per la grossezza de’ muri, appena appena ne somministravano la quantità bastevole al mantenimento della vita.
III
L’attuale popolazione del comune, riportandomi all’ultimo censimento de’ 31 dicembre 1881, è di 3031 anime, ed è ben difficile che possa in prosieguo avere, oltre al naturale, altro notevole accrescimento. Circondato da tutti i lati ed a poca distanza, da altri cinque comuni, non possiede che un tenimento bastantemente limitato, appena dell’estensione di ettari 2370, compresi gl’ improduttivi ed incolti terreni montani. Quindi, come paese eminentemente agricolo, non potendo estendere maggiormente la sua attività, un’agglomerato superiore e sproporzionato di popolazione, gli sarebbe di pregiudizio e ruina grandissima.
IV
Quale sia stata la prima origine di Catelluccio, che il biografo di Mon. Cavalieri appellava <<seminario di famiglie assai riguardevoli, passate in Troja, Foggia ed altrove a farvi ben distinta figura!>> (1) e che presentemente occupa un posto non ispregevole in Capitanata, per comodità di vita, per attaccamento all’ordine, per istruzione, e civili maniere di operare, l’oscurità più profonda nasconde il vero nel fitto del suo velo. Al silenzio della storia si unisce la scarsezza de’ documenti, e la mancanza d’ iscrizioni. Fa meraviglia come un edifizio di qualche importanza, qual è il Castello, non tenga una lapide con la data storica della fondazione. Forse rattrovavasi nell’adjacente casamento che, per quanto appare, essere dovea di non piccola dimensione ed importanza come prima opera di difesa, come quartiere per i difensori, e come magazzino per le vettovaglie. Crollato, distrutto, e convertito posteriormente in chiesa parrocchiale, per la mutata condizione dei tempi e del governo, ha perduto con l’antica configurazione, il gran benefizio di una data storica certa e precisa.
(1) Giovanni Rossi Arciprete di Contursi. Vita di Mons. Cavalieri Vescovo di Troja – Lib. II, Cap. II, p. !09 .
V
A stabilire l’epoca, se non della vera, almeno della legale origine di Castelluccio, non fa d’uopo però anatomizzare, per così dire, tutti gli storici lavori del medio evo: il risultato sarebbe lo stesso, con poche divergenze più apparenti che reali. Basterà fermarci a qualcuno, e se ne vedrà scaturire l’evidenza. Per questo lavoro ho creduto prescegliere, e prendere a guida la storia delle Repubbliche Italiane de’ secoli di mezzo, per Simondo Sismondi; e ad essa mi ci fermo. Autore certamente accetto a tutti per imparzialità, esattezza, e studio profondo e accurato della materia.
Il prelodato storico, dopo aver descritta la batteglia di Besentello in Galabria, e con quale astuzia l’Imperatore Ottone II scampò prima della morte, e poi dalla taglia di riscatto, soggiunge: <<Benchè i greci si lasciarono uscire di mano sì importante preda, non perdettero però i frutti di tanta vittoria. Durante il regno di Ottone II, e la minorità di Ottone III, dilatarono in Italia i confini del loro impero. Contemporaneamente fabbricarono in Puglia la città di Troja e molti Castelli, onde rimanere coperti da nuovi attacchi (1). >>
Sulle prime è da notarsi che Castelluccio, addossato maggiormente a’ monti, è sito ad occidente di Troja, dal quale non dista che circa sette chilometri. I due comuni, di prospetto l’uno all’altro, vengono semplicemente separati da una gran valle, detta Valmaggiore. Qualifica adottata in prosieguo a distinguere il castello di cui si cerca ira l’origine. Posto questo fatto topografico si ravvisa con chiarezza il fine, per cui i greci credettero necessario fortificare questo punto strategico, che or si appella Castelluccio; ed in pari tempo spiega completamente la narrazione dello storico.
Che sia così, procediamo oltre alla disamina. Dal documento citato, e da altri moltissimi che se ne potrebbero produrre, è dunque storicamente certo che i greci, oltre Troja, che vollero rendere baluardo principale de’ loro possedimenti in Puglia, edificarono molti castelli nelle vicinanze.
Una minuta ricerca, che il più dubbioso voglia fare su questa contrada, mena a stabilire che giammai ve ne furono altri, se non Firenzuola, Dragonara, Civitate, Tertiveri, Biccari, Catelluccio, e qualche altro di minor conto. Tutti disposti in linea semicircolare intorno a Troja, con la curva a settentrione. Disposizione giovevolissima ad ostacolare qualunque esercito nemico, che agli Appennini, fosse disceso a’ danni di Troja, proteggendo ne’ lati pericolosi con opere fortificate. La sottomissione di queste piazze, rendea solamente possibile la conquista dell’intera Puglia.
Non mi fo a discutere degli altri castelli, parlo di Castelluccio, e ad esso mi restringo.
Si estenedea veramente la linea fortificata fino a questa nostra località? Il fine giustifica gli atti.
Chiunque, ancorché profano alla strategia militare, come chi scrive, voglia dare un semplice sguardo su questa contrada, scorge facilmente l’importanza grandissima che avea questa posizione, specialmente per la difesa di Troja. Importanza che non potea alla perspicacia dei greci sfuggire, ed è presumibile che ne profittassero fortificandola. Né poteano essi , senza venir meno al loro ideale, diversamente operare, trovandosi questa località vicinissima alla città, che volevasi proteggere, ed alla strada Benevento – Crepacore, per la quale poteano le nemiche schiere discendere, per oppugnarla.
Da questo castello, in preferenza degli altri, trovandosi ben presidiato, potea solamente Troja attendere pronto e valido soccorso. Il comandante di questo presidio, richiamando a se le milizie de’ vicini castelli, Biccari Tertiveri i poche ore avrebbe formato rispettabile armata da fronteggiare, o almeno molestare il fianco sinistro del nemico, dando agio a’ militi de’ presidi più lontani di estendersi al lato destro, per indi, obbligare l’oste avverso, che campeggiava per l’assedio, a prestamente ritirarsi, se non volea esporsi a totale disfatta e ruina.
(1) Sismondi Cap. IV – Lupus Porotospana Chron. Barense. Tom. V, p. 40.
Se questa difesa non poté attuarsi nel 1021, contro l’esercito Tedesco, che, percorrendo questa strada, assedio e rese Toja, avvenne perché la forza numerica delle milizie greche, era ben piccola, e tutti questi castelli, sapientemente edificati, rimasero fabbriche inutili, trovandosi essi, per impotenza o avarizia de’ greci, non presidiati, ma appena custoditi da pochi invalidi, incapaci di alcuna azione e resistenza.
Da questo fatto chiarissimo, può ritenersi per certo che, Castelluccio, sia uno de’ castelli cennati, ma non nominati dallo storico.
In fine, a maggiormente corroborare la prova diretta dell’origine di questo comune, mi riporto all’autorità di Leone Ostiese, il quale ritiene che i greci edificarono Troja, Dragonara et reliquia municipia quae vulgo Capitanata dicuntur (1).
Se dunque Castelluccio rattrovasi in provincia di Capitanata, devesi ammettere per certo edificato, o almeno fortificato da’ greci.
Da tale principio ne sorge per necessaria conseguenza, che l’epoca della edificazione devesi fissare, non più tardi degli ultimi venti anni del secolo X, perché edificato, secondo Sismondi, durante il regno di Ottone II che morì nel 983, e la minorità di Ottone III che giovanissimo cessò di vivere nel 1002.
(1) Leone Ostiese. Cap. 40.
VI
So benissimo, che altri rispettabili storici, riportano Troja e vicini castelli edificati nel 1019, dal Catapano greco Bubagano, o Rosalio Bugiano, chiamato da Guglielmo Pugliese Bagiano (1). Comunque la variante sull’epoca della edificazione non è di notevolissima importanza, pure pure per onore dello storico preso a guida, non regge ad una sana critica. È mai presumibile che molte castella, con città d’importanza, Troja, Tertiveri, Dragonara – e specialmente Troja, la più ragguardevole per postura, presidiata, come si narra, da dodicimila uomini con potente cavalleria, richiesta dalla tattica militare di quel tempo, fossero tutte, e completamente munite di solide mura, di torri, baluardi, e quant’altro la scienza militare addimandava, per essere alla portata di resistere lungamente ad un potente esercito, da cui potevano essere minacciate, possibile, dico che sì gran lavoro fosse ultimato nel tempo brevissimo di due anni?
Anzi Giannone, parlando della espugnazione di Troja del 1021, dice <<Città che i greci in quest’anno medesimo aveano edificata>> (1).
Che resistenza poteano offrire queste improvisate fortificazioni all’esercito alemanno, capitanato dallo stesso Imperatore Errico II? Pure Troja, che fu la sola delle fortificazioni disposte alle falde dei sub-appennini oppugnta, e stretta di assedio nel 1021, resistette energicamente per più mesi.
Cadde, ma con onore.
Né qui ha termine il mio ragionamento. Vediamo; era o pur no nella capacità de’ greci di quell’epoca, fare questi prodigi, che appena son possibili nel secolo presente, che dispone di altri mezzi, e di altre fortezze? I greci esausto di uomini e di denaro, per la guerra che sostenevano con i Pugliesi Melo e Datto, sorretti da’ Normanni Drengot, non poteano rivolgere tutta la loro attività a quest’opera, comunque la credessero d’importanza gravissima.
Dal detto perciò si rileva chiaramente, che il Catapano Bugiano, non poté dar principio, ma solo completare le fortificazioni incominciate negli ultimi venti anni dek precedente secolo: e per la ristrettezza del tempo, limitò l’opera sia alla sola Troja, lasciando incomplete, siccome si trovano, quelle di Castellucio Biccari, ed altre, e come tuttora si veggono.
Mi conforta in questa idea di Giovanni Rossi asseverando aver ritrovato e letto nello Archivio Capitolare di Troja alcuni atti di donazione, che portavano la data del 1000, quindi soggiunge: <<La data 1019, della fondazione della città, deve intendersi l’anno in cui poté dirsi perfezionata, non incominciata>> (1).
È ben certo che i Pugliesi e Normanni, con reiterate istanze, imploravano soccorso ed assistenza all’Imperatore di Germani Errico II, che promettea ma indugiava, sperando forse profittare del vicendevole indebolimento de’ contendenti per dettare sua legge. La totale disfatta dell’esercito collegato a Canne nel 1019, le premurose richieste del Sommo Pontefice Benedetto VIII, che temea perdere Roma e l’Italia tutta, col dilatasi e rafforzarsi del domino greco, spinsero l’Imperatore a togliere gl’ indugi , passando per le Alpi con numeroso e forte esercito. I preparativi imperiali non potevano sfuggire a’ greci, che si affrettarono a rafforzare l’estremo baluardo del loro dominio nel continente pugliese, ultimando le opere di difesa di Troja; probabilmente senza neanche perfezionarle, come, per tradizione, si ritiene dagli abitanti della nominata Città.
VII
A raffermare l’animo de’ dubbiosi che, dopo le surriferite prove, mettessero ancora in forse se Castelluccio fosse o pur nò compreso nel numero de’ castelli edificati da’ greci, mi fo lecito richiedere: da chi dunque è stato fondato? È certamente un antico Castello; oltre il nome, vi è l’esistenza di fatto, e sarebbe stravaganza impugnarla e sconoscerla, senza far onta alla ragione ed al buon senso: vediamolo con argomenti di eliminazioni.
Volevo supporre opera Romana, è assurdo. Non trovandosi questa località nella via che percorrevano le legioni romane, né questo punto isolato offrir potea ostacoli seri per la difesa, od offesa. I luoghi de’ combattimenti de’ romani in Puglia sono ben noti, e bellamente descritti, né si possono equivocare con Castelluccio.
Invasori i qusta contrada, a tempo più o meno lungo, oltre i Greci, che per moltissimi anni ne ebbero il dominio, furono i Tedeschi; ed essi poca importanza mettevano alla conservazione dei queste province, lontanissime dalla Germania, tanto vero che nel 1021, Errico II limitossi alla sola presa di Troja, né pensò ad innalzare fortezze.
Avea vendicata l’onta della disfatta di Besentello, e sodisfatte le premure del Sommo Pontefice;
pago del risultato, cogliendo a pretesto l’epidemica infermità che facea strage di sue genti, ritirossi, senza compiere e consolidare l’incominciata conquista. I Greci ripresero, senza contrasto, nel 1023, tutto quello che era stato loro tolto; e lo ritennero fino al 1042, quando da’ Normanni furono definitivamente depressi e discacciati, per non più farvi ritorno.
Seguirono gli avventurieri Normanni. Essi fattisi signori di queste contrade, pensarono solo a saccheggiare, non a costruire castella, sì per braveria, che per difetto di denaro; è a tutti noto che la sola Aversa fu da essi fabbricata e fortificata; se non dalle fondamenta, almeno in parte grandissima, riducendo il piccolo ed antico castello, che in dono e in ricompensa essi aveano ricevuti da Sergio Duca di Napoli, in città fortificata o ben munita, da servir loro qual novella patria.
Presupporre il castello, di cui si cerca l’origine, edificata in epoca a noi più vicina, durante cioè il dominio Baronale del secolo XV, è maggiormente inverosimile. Dopo l’invenzione delle armi da fuoco, siffatte fortezze sarebbero state di niun valore; e la struttura stessa indica chiaramente che non venne costruita per resistere a queste armi.
Pria di procedere oltre mi è doveroso dichiarare che, nei primi tre argomenti di esclusione, parlando del Castello, vi comprenda l’intero Comune; per quest’ultimo, consimile estensione sarebbe strana, perché non può esservi dominio su cosa inesistente; ma Castelluccio esisteva, tanto che fu uno de’ tre comuni che costituirono la Baronia di Valmaggiore. La proposizione quindi non rimane più ne’ termini logici, e da generale dell’intero abitato, addiviene particolare della ola torre. Mi sarei astenuto dal dire tutto ciò, se ragioni speciali, che qui è meglio non mettere in mostra, non mi avessero imposto il contrario. Il ragionamento però, anche ristretto in questi termini, è sempre degno di qualche considerazione, per rimuovere totalmente gli erronei sospetti, e togliere ogni dubbiezza al vero, che ho impreso a dimostrare.
A suggellareil già detto , si fa in primo luogo osservare che i Baroni di Castelluccio, possedendo altrove feudi di importanza maggiore, non vi dimorarono giammai; né si ebbero in questo comune un palazzo veramente signorile; ma una casaccia, da servire più da magazzino e stalla, che per abitazione. Dippiù, è a tutti noto essere nel sistema baronale, fortificare la propria casa, per premunirsi da qualunque ingiuria, e per raffrenare i tumultuosi moti de’ vassalli, non già l’opposto, fortificare cioè il comune, lasciando la propria dimora esposta all’audacia de’ malcontenti. Ciò premesso, e da quello che anche oggidì si vede, la Torre formava parte del sistema generale delle fortificazioni del paese, né trovavasi congiunta alla casa Baronale, da servire al Feudatario per ultimo rifugio, negli estremi bisogni. Divenne, lo ammetto, proprietà baronale, ma per sovrana concessione, trovandosi, nel diploma, chiaramente espresso Cum Turribus et palatiis.
In ultimo, se, nel costituirsi la Baronia, questo comune portava già il nome di Castellucio, piccolo castello, è fuor dubbio che al nome ne rispondesse il fatto.
Se dunque Castelluccio non fu edificato o fortificato da’ Romani, da’ Tedeschi, da’ Normanni, né nel tempo del dominio baronale, bisognerebbe appartenere alla scuola Perronista, per non riconoscere che veramente si ebbe origine da’ Greci, nell’epoca e circostanze dallo storico descritte.
VIII
In questo che ho svolto, mi credo aver messo precipuamente in chiaro l’epoca delle fortificazioni; non già della prima fortificazione del comune. La mente non si presta a credere che città e paesi, potessero sorgere, come il castello di Armida. Le popolazioni non s’improvvisano con un atto energico di volontà; han bisogno dell’opera del tempo per costruirsi in numero competente, meno quando l’agglomerato operasi con l’immigrazione. Ora, dova mai poteano i Greci raccozzare numero si grande di famiglie, da popolare molte Città e Castella, senza depauperare altri comuni, in quel tempo, non esuberanti di vita?
Nè serio ostacolo al mio ragionamento, deve reputarsi l’opinione di Leone Ostiense, di avere cioè il Catapano Greco, dopo l’edificazione di Troja, Dragonara, et reliqua municipia quae vulgo Capitanata diciuntur, chiamati, da’ vicini comuni, gli abitatori a popolarli, (ex circumpositis terris habitatores convocans, deinceps habitare, constiuit) (1), giacché concorso sì grande e straordinario di famiglie, da popolare una intera provincia, è pressochè impossibile; e son portato a credere che quelle poche, che risposero alla chiamata, bastarono appena appena a rafforzare i centri, che si volevano rendere di importanza maggiore. Insomma siccome è falso che i comuni tutti di Capitanata fossero edificati dal Catapano Bagiano, mentre è noto che molti già esistevano, così non è vero il modo di popolarli.
In chi poi nasce il sospetto che numero maggiore di famiglie ne venisse dalla Grecia, fatto non enunciato dagli storici, non è difficile disingannarlo. Siffatte immigrazioni lasciano, quasi sempre, le tracce della primitiva origine, specialmente nella lingua. In Sicilia, in Calabria, e nella stessa Puglia, la colonie Albanesi, conservano tuttavia il primitivo idioma. E nelle nostre vicinanze, i comuni di Faeto e Celle, popolati da Provenzali proseguono a parlare, dopo sei secoli, la lingua madre, sebbene corrotta.
Dal già detto devesi conchiudere che i Greci non edificarono, ma semplicemente fortificarono o comuni esistenti, dando, a quelli che non l’avevano, un nome, e col nome l’esistenza legale.
Non è improbabile che Castelluccio, pria di ricevere tal nome, portasse quello di Capraja, giacché fino a tempi nostri, con questo nomignolo, veniva solamente distinto da altri omonimi.
L’origine quindi di questo comune, come ancora di qualche altro nelle vicinanze, non esclusa Troja, a quanto sembra, rimontar deve ad epoca assai più remota, e forse collegarsi alla distruzione di Ecana, che vuolsi avvenuta nel secolo VII, per opera dell’imperatore Costante II.
I cittadini sfuggiti al massacro, doveano certamente fissarsi in qualche luogo; ed è da supporsi che gl’infelici agricoltori, privi di mezzi sufficienti a sostenersi nelle città vicine, avessero trasportato i Dei Penati fra questi monti, per vivere nella quiete col frutto del lavoro. Le osservazioni sulla configurazione primitiva del comune, esposte nel N. 11, largamente confermano il presente ragionamento.
(1) Leo Ost. Lib. II, Cap. 40 e 50


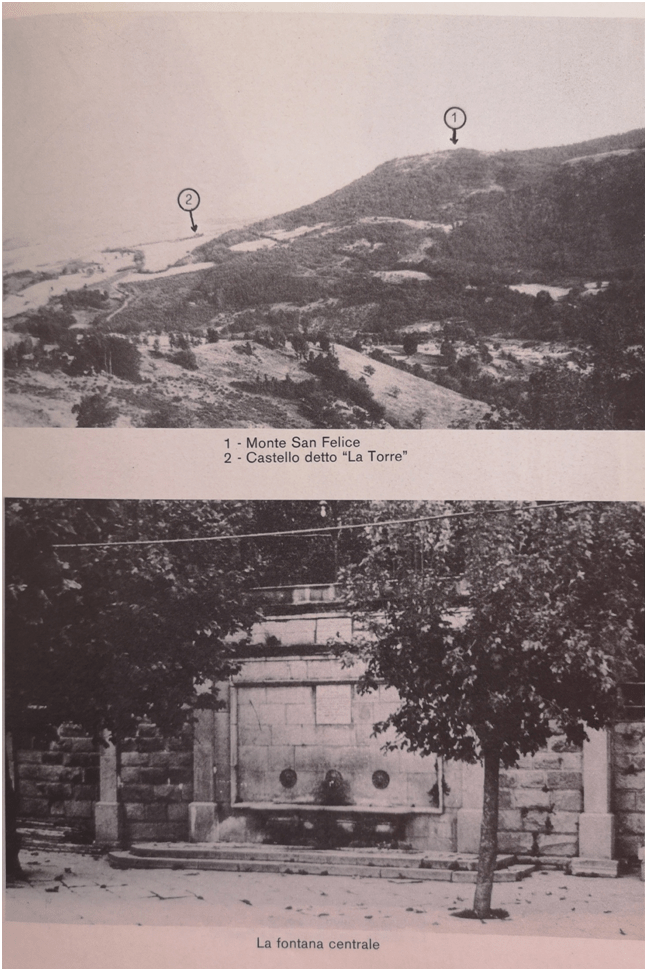

IX
Provata con logica evidenza l’origine, e l’epoca legale, se non della fondazione, almeno della fortificazione di Castelluccio, ne viene per naturale conseguenza che facea parte de’ possedimenti dell’Impero Greco nella regione di Puglia.
Non è punto facile determinare con precisione la sua costituzione giudiziaria, politica, ed amministrativa.
I possedimenti Greci in Italia, dopo la conquista de’ Longobardi, si trovarono divisi in due parti.
La Sicilia con le Calabrie e Puglie, venivano governate da un Patrizio residente in Siracusa.
Napoli con le altre terre poste a settentrione della medesima, dipendevano, almeno apparentemente, dall’Esacrato di Ravenna. Le leggi perciò che imperavano in queste provincie, erano quelle stesse dell’impero, specialmente le giustinianee. Avveniva però molto fiate, che i Governatori arrogavansi tale e tanta autorità dispotica, da giudicare più a loro talento, che a norma della legge scritta.
Per questo arbitrio precipuamente il greco governo fu reputato giustamente infausto a’ popoli soggetti. L’esposta primitiva divisione a notevole mutazione soggiacque in prosieguo, nella regione Pugliese. La strepitosa vittoria do Besentello, innanzi menzionata, consolidò maggiormente il dominio Greco in queste province; e gl’imperatori Basilio e Costantino ne seppero profittare per dilatare i confini dell’impero, invadendo parte dei limitrofi principati di Benevento, Salerno, e Capua. Anzi, se più ardimentosi si fossero dimostrati nel proseguire la guerra, si sarebbero spinti, dice Giannone (1) fin sopra Roma, e facilmente l’avrebbero occupata. Non bisogna sconoscere, però, che la prudenza loro dettava a non essere audaci. Ben conoscevano che, la riportata vittoria dovea ascriversi non al valore delle milizie proprie, ma a quelle Saracene. Sapeano ceh in Germani si anelava la riscossa, né conveniva maggiormente irritare gli animi di quella forte nazione. Vedevano giornalmente che i Saraceni, loro ausiliarii contro il Tedesco, riscalcitravano a rimanere in tale precaria situazione; aspirando anche essi al dominio: né sapevano e volevano modificare la loro indole rapace e sanguinaria. Quelli specialmente, che si erano asserragliati sul Gargano non tralasciavano occasione di scorrere e scompigliare la Puglia, disdoro e dispetto del diritto e prestigio Imperiale. A questi pericoli, per se gravissimi, univasi l’animo sempre ostile de’ sudditi, che mal soffrivano le turpissime espoliazioni dei governatori Imperiali. Dovettero perciò contentasi del poco, per non compromettere il molto.
Tuttavia non potendo conquistare, pensarono a consolidare. A tal fine, per imporre freno e temenza a’ malcontenti sudditi, crearono novello magistrato, con giurisdizione estesissima, da risedere in Bari. Magistrato che nell’anno 999 chiamarono Catapano.
La costituzione politica de’ nostri comuni, in quel tempo, comunque dipendenti da un governo assoluto e monarchico, tenea forma repubblicana. Il governo di Costantinopoli poco curavasi dei principii che reggevano i popoli, qualora le gravose imposte venissero rigorosamente riscosse.
L’ordinamento amministrativo, seguendo la costituzione politica, era quello degli antichi popoli iberi, o a dir meglio, con l’istorico Leo: <<ciascuna comunità era ordinata a modo della costituzione municipale romana, o piuttosto non ne aveano che la forma>> (1).
È innegabile che l’esposto ordinamento imperasse nelle grandi città. Pei piccoli comuni nulla si conosce di positivo e preciso della storia. Non pertanto, mancando una formale e stabile legislazione sociale è da supporsi che, per lo spirito d’imitazione, che sempre domina ne’ popoli, avessero prescelta l’istessa forma amministrativa: né credo poteano diversamente operare.
Ciò premesso, chiaramente ne deriva che Castellucio avesse molta libertà, amareggiata dai gravissimi ed arbitrari tributi che i Governatori sapeano estorcere con la forza, per appagare le imperiali esigenze, i propri comodi, ed i bisogni quotidiani di questi possedimenti.
La conquista della Puglia per Normanni nel 1042, modificò in parte la politica costituzione, e da repubblicana democratica, addivenne repubblicana militare oligarchica (2)
(1) Leo Storia d’Italia Lib. IV. Cap. II, p.176 – (2) Sismondi Cap.IV, p.82-LeoneOst. L II,e67 edaltri
X
Discacciati i greci, i normanni ripartirono il conquistato in dodici contee, che assegnarono a ciascuno de’ dodici capi dell’esercito. Non tutti gli storici sono ben di accordo sulle Città capitali delle contee. Checchè ne dicano gli apologisti di Troja, pare certo che essa non fu capitale di alcuna Contea (1). Melfi rimase capitale comune, e Guglielmo Braccio di ferro ne fu eletto proclamato Duce supremo.
Ben poco però i Conti si sottometteano agli ordini ed ai voleri del medesimo, l’impero del quale restringevasi al comando militare in caso di comune pericolo, non al reggimento speciale delle Contee. Ognuno operava a suo talento: né il capo supremo potea mostrarsi rigoroso, ancorché ricevuta ne avesse autorità <<Vivevano, dice Sismondi, con i soli prodotti del saccheggio, e non essendo ligati da veruna convenzione, piuttosto che la guerra, esercitavano il latroneccio, alla testa dei loro satelliti. I conventi, le chiese, e quegli stessi luoghi santi, che erano stai pocanzi l’oggetto de’ loro pellegrinaggi, non isfuggivano alle loro rapine>> (2),
Questo deplorevole stato, nonché la minaccevole attitudine di occupare benanche il Ducato du Benevento, che l’Imperatore Errico III, avea concesso al papato in ricambio della chiesa di Bamberga, imponea a tutti temenza, e scosse anche l’animo del S. Pontefice Leone IX, decidendolo alla guerra. Rimasto prigioniero nell’infausta battaglia di Civitella, o Civitate, come dice Malaterra, a’ 18 Giugno 1053, per ottenere la libertà dovette il S. Padre concedere al fortunato invasore la pace; e con la pace, forse, l’investitura del conquistato e conquistabile in Sicilia e Puglia, come feudo di S. Chiesa. Ho detto forse, perché tale investitura, ritenuta per fermo dagli antichi scrittori, ora, da’ moderni, vien messa in dubbio, con argomenti che qui sarebbe fuori luogo riportare e discutere.
(1) Sismondi – Leo Ost. Ed altri – luogo sopra citato – (2) Sismondi Lib. IV.
XI
L’esercito normanno, oltre i capi supremi, ai quali vennero assegnate le dodici contee, ne annoverava altri di ordine inferiore; e questi scontenti che nella eseguita partizione nulla aveano ottenuto, si credettero in diritto di provvedere da sea’ proprii interessi, oppressando comuni più lontani, non compresi, o dimenticai nela ripartizione generale. A tal destino soggiacque Castelluccio. E certo, che l’infelice comune, nel principio del duodecimo secolo, trovavasi ancora sotto la signoria di un certo Guglielmo Altavilla, omonimo o discendente di quell’Altavilla creato nel 1043 capo de’ normanni.
Questo vero si fa manifesto, e rimane largamente provato da alcuni strumenti di restituzione, stipulati in favore dell’Abbadia di S. Nicola di Troja, da esso Altavilla, qualificandosi signore di Castelluzzo. (1) V’ ha dippiù: in una antica cronaca manoscritta di troja si legge <<Episcopus Trojanus obsedit Castullutium, (1115) illunque coepit et combussit, coepitque in eo Guillelmum Altavilla cum omnibus suis, pro cruelitate quam faciebant paregrinis Hyerosolimitanis (2)>>. Vescovo di Troja, in quel tempo, era Guglielmo II della stirpe ducale normanna.
Il chiarissimo De Meo, nell’esporre il summenzionato fatto del sacco e fuoco dato a Castelluccio, dice << il Vescovo di Troja, Guglielmo II, come da storia manoscritta di Troja; assediò, prese, e bruciò Castelluccio Valmaggiore che se gli era ribellato>> (3).
In buona pace del rispettabile analista, la qualifica ribellione non ha fondamento storico, né regge alla critica. Il documento, al quale si rapporta, è precisamente quello da me sopra citato; in esso non si fa parola di ribellione, ma si indica una causale ben diversa, con forma chiara e precisa; il giudizio quindi non discendendo dalle premesse, deve qualificarsi erroneo. È poi una supposizione sfornita di prova che Castelluccio in quel tempo dipendesse dal Vescovado di Troja, mentre ritengo che non vi appartenesse, e cercherò metterlo in chiaro in proseguio.
Insisto su questo argomento non per attenuare la colpa, de’ nostri progenitori, che anzi ne aggravo la portata; ma per accertare il fatto storico, sceverando il falso dal vero. Le ribellioni, molte fiate, sono scusabili; le rapine e crudeltà giammai.
Ma qui, una buona volta, fa d’uopo pure si esca dalle sinistre interpretazioni, per dar luogo alla verità. Non lice giammai dar colpa a chi non spetta. Il popolo di Castelluccio non partecipava, in modo alcuno, alle inique opere menzionate dalla cronaca di Troja, le quali vanivano tutte ordinate dal signorotto normanno che, col diritto della forza tiranneggiava i cittadini, e poi eseguite, dentro e fuori l’abitato, da’ feroci suoi satelliti, reclutati chi sa dove, tra la feccia de’ ribaldi. L’osservazione non procede da mia benigna interpretazione, ma dai termini stessi del documento citato. Coepitque in eo Guillelmum Altavilla cum omnibus suis, pro crudelitate quam faciebant peregrinis Hyerosolimitanis. Quindi non la popolazione, come da alcuni inconsideratamente si è ventilato, ma quei predoni perpetravano le ingiuste aggressioni. Il comune innocente ne ricevette il materiale danno, delle bruciate e crollate abitazioni; ma fortunatamente ne ebbe largo compenso, liberandosi dal despota, che l’opprimeva e disonorava.
(1) Stefanelli Memorie storiche di Troja cap. III, p. 121 – (2) Stefanelli Cap. III, p. 90 – (3) De Meo Annali del Regno di Napoli, vol. 9 pag. 79
XII
Per ridare luce maggiore al sopra narrato fatto, che particolarmente si appartiene alla storia di Castelluccio, debbo premettere che, ad occidente del comune, e propriamente ad un chilometro circa dall’abitato, dove il torrente Freddo innestasi con l’altro di maggiore importanza, chiamato Celone (che serpeggiando per la vallate discende in Puglia, e va a riversarsi nel mare Adriatico) eravi anticamente un piccolo cenobio, fondato da Religiosi, di cui ignorasi l’ordine e la regola primitiva. È probabile che fossero Benedettini come quelli di Troja ed Orsara ed altri disseminati in questi monti; ma comunque sia, è positivo che essi aveano a missione tutelare e difendere la vita dei pellegrini di Terra Santa che, per deficienza di strade regolari, erano necessitati a transitare per questi luoghi. Il cenobio trovavasi dedicato a S. Nicola.
Nel punto ove venne edificato il Conventino, la gran valle, si restringe a guisa di un imbuto a collo torto, e pei boschi che religiosi ne ombreggiavano i lati, il transito riusciva di grave rischio e pericolo. Con sapienza perciò i Religiosi l’aveano prescelto per esercitarvi la filantropica missione. Poscia, per maggior comodo del cenobio, furono edificate alcune cellette in un poggio di prospetto sito tra mezzogiorno e ponente della casa principale, da servire a dimore estiva dei Religiosi, attesochè, per le acque stagnanti de’ due torrenti, che nocivi miasmi esalavano in quella stagione, la primitiva dimora addiveniva pregiudizievole alla vita.
Vero la fine del secolo XIII le menzionate cellette succursali vennero prescelte da alcuni Provenzali di Carlo d’Angiò, fissandovi loro dimora e colonia. E nel dar vita al novello comune, lasciarono a questo il nome di Celle, che tuttora rimane.
Non è facile accertare per qual motivo, nel 1115, i Religiosi avessero cessato di custodire quel punto interessante alla sicurezza del transito. È probabile che, le vittorie e depredazioni dei normanni, ne rendessero impossibile il soggiorno. I Conti, occupati in continue guerre, né poteano, né solevano provvedere alla vita de’ cittadini, al mantenimento dell’ordine, ed alla sicurezza delle strade, i perversi quindi ne approfittavano. I Vescovi poi, specialmente quando credeano manomesso il prestigio religioso, il culto divino e la pubblica morale, si arrogavano il diritto di esserne vendicatori. Fu questa appunto la cagione che spinse il Vescovo di Troja, battagliere come tutti i normanni, a dar sacco e fuoco a Castelluccio; commettendo crudeltà ed ingiustizie pari a quelle che si volevano punire. Gli efferati costumi si quell’epoca possono solamente mitigare, ed in parte scusare la crudeltà dell’atto, perpetrato a ruina di tante innocenti vittime.
XIII
L’esposto e dilucidato fatto da luogo a nuovi ordini d’investigazioni, che conviene non tralasciare senza esame. Primamente: essendosi fatto parola del Cenobio, sorgono spontanee le dimande; che ne fu di esso? ; a qual destino soggiacque? In secondo luogo: l’intervento del Vescovo di Troja che , con la forza, venne a punire chi della forza abusava, porge occasione a discutere ed investigare ponderatamente la legalità dell’atto; e, senza amore o avversione di parte, accertare se Castelluccio, in quei giorni, dipendesse o pur no, da esso, in ordine allo spirituale, ossia se si trovasse compreso nella circoscrizione Diocesana di Troja.
È ben difficile dipanare l’arruffata matassa. Cercherò, come meglio posso, sciogliere il nodo, senza la spada di Alessandro, ritenendo provato come certo, ed il dubbio come soggetto ad ulteriore investigazione e disamina, e spero che da altri sarà messo in evidente luce.
XIV
In ordine al primo dubbio: volendosi tener per fermo che i Religiosi, prima ancora del 1115, avessero cessato di abitare il cenobio, pare siavi successo lungo abbandono, ed interruzione di servizio. Almeno niuna cronaca, per quanto è a mia conoscenza, ne fa motto, durante il tempo che imperarono i normanni. Risorse a novella vita nel 1228, quando il Sommo Pontefice Gregorio IX, chiamò dalla Spagna i cavalieri di Calatrava, concedendo loro, con l’Abbadia di Orsara, anche quella di Castelluccio e Pontalbaneto. Emerge chiaro dal Diploma di Carlo d’Angiò del 1274 (1).
La permanenza de’ Cavalieri di Calatrava in Italia fu di brevissima durata. Nel 1294 furono richiamati nella Spagna, per opporsi alla invasione degli Arabi. Nel dipartirsi concedettero in Commenda ad vitam al Cardinale Gaetano le Abbadie di Brindisi, Foggia, Troja, nonché quella di Orsara, con Castelluccio e Pontalbaneto, che venivano denominate simul adnexis.
Elevato il Cardinal Gaetano al soglio pontificio, in Gennaio 1295, col nome di Bonifacio VIII, la commenda venne ceduta a Filippo, Arcivescovo di Trani, che ne ebbe la investitura dal Re Carlo II. Turbato nel possesso, dovè ricorrere all’istesso Re, che ordinò al Giustiziere di Capitanata di sostenere i diritti del Prelato sulle Abbadie di Orsara, Pontealbaneto, Castelluccio, e Monte Calvello (2). Morto nell’istesso anno l’Arcivescovo di Trani, la Commenda ritornò a Bonifacio VIII, che ne dispose a suo piacimento. Nel 1305 si possedea dal Cardinale di S. Maria in Comedin, sostenuto nel possesso dall’istesso Re Carlo (3). Il diritto sull’Abbadia nel 1322 si esercitava direttamente dalla Chiesa; come da Diploma di Carlo III figlio e vicario di Roberto (4).
Posteriormente il Re di Napoli ne avocò a se il diritto di collazzione. Non so, né è possibile metterlo in chiaro, se ciò avvenne in usurpazione, concessione Pontificia, o per cessione de’ Cavalieri residenti nella Spagna, a’ quali realmente spettava la facoltà di disporne. La concessione della Commenda fu nondimeno temporanea, limitata cioè alla vita dell’investito: ed il ritorno a’ primi Signori dovea verificarsi appena deceduto l’Arcivescovo di Trani, giusta la clausola di concessione apposta dal S. Pontefice Bonifacio VIII – Volumus quod te cedente vel decedente, praedicta omnia, ad praefatam domum libere revertantur. Pure Bonifacio ed i successori ne disposero, fino a che il Sovrano ne rivendicò il diritto alla Corona.
Il primo monarca che incominciò ad avvalersi di tal nuova prerogativa si fu Re Roberto, conferendola a Leopardo de Fulcineo, col nome di Rettore. Morto il primo investito, dall’istesso Re fu nominato Lorenzo Pulderico. Mortuo nuper, dice il Diploma, Leopardo de Fulcineo Rectore Ecclesiae S. Angeli de castro Ursariae, cum duabus aliis Ecclesiis castrorum Castellutii et Pontalbaneto simul adnexis etc. – ad collationem nostram pleno et speciali jure spectantes, cum omnibus juribus tibi conferimus (5). Tal atto di Sovrana autorità venne fortemente contestato dal Vesovo di Troja. I diritti della Corona, come benanche quelli della Ecclesiastica potestà, non si trovavano in quei tempi ben definiti, né con bonario accordo assicurati; se vedeano bene spesso in penoso antagonismo. Il Re, nel conferire la Rettoria, con chiara e precisa forma ne afferma il suo dritto con le parole, pleno et speciali jure. Pur tuttavia Monsig. Frezza Vescoco di Troja non volle riconoscerlo, sostendendo con fermezza appartenere alla sua sede Vescovile. Per tal fine, ne porse ricorso al Sommo Pontefice Clemente VI in Avignone che pronunciò in favore del diritto vescovile.
(1) Diploma esistente nel Grande archivio di Napoli. Reg. 1274, L.B. fol. 265 a.t. – Silvio Torelli – Ordini Equestri, Tom. 1, p,508 – Bernardo Giustiniani Cavalieri di Calatrava, Cap. 27. – (2) Ughellio Italia Sacra – Arcivescovi – Diploma nel Grande Archivio, Reg. 1295, L.B, Fol.118 – (3) Nel Grande Archivio di Napoli 1303, L.B. fol.144 – (4) Idem L.A. fol. 18 a t. 1322 – (5) Idem L.A. fol. 80, 1341 e 42
Il Re Roberto, e successori non tennero alcun conto della decisione Pontificia, e proseguirono a conferirla a chi meglio credettero; tanto vero che la Regina Giovanna I nel 1376 ne investì Cesare Brancaccio. Ebbe finalmente termine tale attrito, quasi dopo altri 100 anni, quando nel 1464 Ferdinando d’Aragona la concedette definitivamente al Vescovado di Troja (1).
Su cotesto conflitto giurisdizionale non oso pronunciarmi a favore del Monarca, o del Vescovo. S’ignorano le vere e positive ragioni sostenute da’ contendenti: né, per la delicatezza della materia, il giudizio è facile e di lieve conto. Lo facciano pure gli altri, se lo credono; a me, per non gratificare i lettori con strane teoriche, basta la semplice esposizione de’ fatti.
Dopo la partenza de’ Cavalieri, i Commendatori poco o nulla curarono la manutenzione del Conventino, che rimasto in abbandono, cadde in ruina. La cappella però fu lungamente mantenuta dalla nostra popolazione; tanto che nel 1629 posevi nuova campana con la scritta – Divi Nicolai ad Dei gloriam et honoremer et concursum ad augustam divotionem populi semper 1629. Ma anche per essa si approssimava l’ora fatale. Denudati e messi a coltura i terreni de’ soprastanti monti, il torrente Freddo addivenne oltremodo impetuoso; e travolgendo nelle tumultuose sue piene terra e massi di pietra, in breve tempo, completamente distrusse l’ultimo ricordo del religioso e filantropico monumento. La campana salvata e trasportata in paese, fu posta sulla Cappella di S. Caterina, ed ora, per circostanze che si svolgeranno in prosiegno, è passata alla chiesa di S. Maria.
(1) Grande Arch. 1464, fol. 83. – Fo notare che quasi tutte le notizie dell’Abbadia, le ho prese ad imprestito da una elaborata memoria Giudiziaria, redatta dal sig. De Stefano di Orsara, stampata in difesa del Clero di quel comune.
XV
A nostri giorni suol ripetersi troppo di frequente, ed alle volte anche fino alla nausea, fa d’uopo in ogni cosa esser logici. Applichiamo anche noi questo savio principio al nostro argomento per accertare se Castelluccio appartenesse ne’ primi tempi, alla Trojana diocesi.
Provata, nel numero V la simultanea e comune origine di Castelluccio con Troja, ne viene per naturale conseguenza, essere la dipendenza dell’uno dall’altro, pressoché impossibile. Il dominio materiale, se non mi difetta il senno, credo possa quasi sempre acquistarsi con la prepotenza numerica, con l’astuzia, con altri mezzi di forza brutale, o pure venire per legale concessione. Il diritto poi a sede vescovile non può ottenersi che con la sola creazione in Titulum, secondo le prescrizioni dei S. Canoni. La memoria ed i fasti di Ecana, ed anche il posto elevato di primo baluardo della Puglia, al quale trovavasi innalzato, davano a Troja la certezza del Vescovado, specialmente in quei tempi, che ogni città si avea il suo Vescovo; ma non poteano i Trojani da se stessi proclamare la prerogativa, e tanto meno costituire la Diocesi. Dopo una interruzione di molti secoli, una nuova città edificata, neanche sulle ruine della prima, razionalmente non potea conservare gli antichi privilegi. Bisognava una nuova Bolla Pontificia. E questa, pare, sia venuta nel 1028 dal S. Pontefice Giovanni XIX o XX (1). È da ritenersi quindi che Troja stessa, prima del 1028, dipendesse, per lo spirituale, da altro potere ecclesiastico ben costituito; ed è possibile che si trovasse sottoposta al Vescovado di Siponto (2).
So che i Trojani respingono qualunque ipotesi e ragionamento. Non volendo attentare alla gloria altrui, vera o falsa, lascio a’ medesimi pensare e credere come vogliono; e rimenando il discorso al mio argomento, ritengo che Castellluccio per molto tempo fè parte della giurisdizione spirituale dell’Abbate nullius di Orsara; solo potere ecclesiastico riconosciuto in queste vicinanze. Sarei lietissimo se il mio convincimento mi venisse dimostrato erroneo; ma ammesso il principio, non mi è lecito sfuggirne la conseguenza. A sostenere il mio assunto non fa d’uopo di molto ragionamento, giacché, oltre la tradizione che, al dir di Walter Scot, parla ove manca la storia, me ne somministrano validissimo argomento le Pontificie Bolle di Pasquale II del 1100, al Vescovo Uberto; e di Alessandro III del 1179. I detti pontifici nel circoscrivere la Diocesi di Troja, non nominarono Orsara e Castelluccio; e, forse, non vennero nominati neanche in quella di Clemente IV del 1266. Ho messo quest’ultima in dubbio, giacché non mi è stato possibile riscontrarla.
Per somiglianza, ed affinità di nomi è piaciuto a qualcuno far credere che Pasquale II, facendo parola di Monte Majuro Villa avesse designato Castelluccio Valmaggiore. Errore non perdonabile a storici locali. Monte Majuro è in tenimento di Orsara, e può darsi , che in detta epoca, fosse una borgata: ma non è da equivocarsi con Castelluccio, che avea il suo nome speciale. Per maggiore chiarezza si riproducono qui, le testuali parole della nominata Bolla di Pasquale II.
Montem Majurum Villa quae dicitur in S. Laurentii, et quidquid in posterum juste et canonice ad Ecclesiae possessionis proprietatem, largiente Domino, poteritis adipisci. Episcopali vero jure regenda in perpetum ad disponendum sancimus, ipsam Civitate Trojanam, eet in ea S. Nicolai Monasterium; cum Ecclesiis ad id pertinentibus, S. Crucem de Portula, et Felicem, Castellionem, Castellum novum, Biccarum cum Abadia, S. Petri in Burgo cum Ecclesiis ad id partinentibus, Ecclesiam S. Viti, Fabricam S. Mariae de Forcis, S. Petrum de Montella, S. Iustam (3).
Al già detto potrei aggiungere altro, riproducendo il decreto di Carlo III Vicario di Roberto, col quale veniva ordinato al Giustiziere di Capitanata, sostenere la Chiesa Romana nell’esercizio de’ diritti spirituali sopra Orsara, Castelluccio e Pontabaneto. Mi sorge però sospetto se, questo fatto, ha rapporto alla giurisdizione Vescovile sugl’ interi comuni, o all’Abbaziale, come è più nturale, sulle chiese de’ Cavalieri di Calatrava. Dubbio che non mi è facile sciogliere, come non mi è dato stabilire, in quale epoca, il comune di Castelluccio passò effettivamente alla Diocesi di Troja, alla quale attualmente si onora di appartenere
(1) Ughellio – Italia sacra – Vescovi di Troja – (2) Vedi Dizionario Corografico d’Italia, compilato per province Napolitane, dal Cav. Ferdinando De Luca e Raffaele Mastriani – Milano 1852 – (3) Riportata da Ughellio – Italia sacra – Vescovi di Troja
XVI
Fa duopo ora rannodare le fila della narrazione principale, interrotta al N° XII.
In questo basso mondo tutto è precario e mutabile; il tempo travolgendo Regni ed Imperi ne’ vorticosi suoi abissi, ogni cosa trasforma e rinnova.
Anche la numerosa stirpe maschile normanna, che col semplice valore, seppe fondare un Regno, fu dannata alla morte nel 1194. Per solo retaggio lasciò unificate le provincie dell’Italia meridionale, formando il Reame, che fu detto delle Due Sicilie (1). Reame che in prosieguo dovea rappresentare parte importante nei destini dell’intera penisola Italiana.
Oltrepasserei il limite segnato ad un semplice cenno storico di un piccolo comune, che non vi poté contribuire, se presumessi descriverne le cause, le vicende, le circostanze, ed il sangue versato, per far passare il Regno da’ Normanni agli Svevi, e da questi agli Angioini. Ma non posso dispensarmi dall’enunciare che l’ultimo passaggio fu di pregiudizio gravissimo, non alla sole città, ma benanche a’ piccoli comuni, come Castelluccio.
Carlo I° D’Angiò non contentossi distribuire a’ suoi Duci e Cavalieri, le Baronie e Contee del conquistato Regno: non dimenticando neanche quei Signori che l’aveano servito col tradimento.
Dovea stollare tutti i famelici suoi seguaci; e moltiplicò impieghi e tributi. Lo stuolo di quelle arpie, sparpagliato in tutti i comuni, discese alle più nefande durezze, e tiranniche oppressioni <<A tutti gl’ impieghi, dice Sismondi, dell’antica amministrazione, avea aggiunti tutti l’ impieghi corrispondenti che egli conosceva in Francia, di modo che, il numero de’ pubblici uffiziali, era più che raddoppiato. Albagiosi, prosiegue l’istorico, per la nuova loro dignità, ignorando, come il loro padrone, la lingua del paese, sprezzando i costumi nazionali, questi plebei diventati possenti, scorrevano le provincie e le spogliavano. Ovunque pretendevano di essere accolti come vincitori, ovunque manifestavano il più alto disprezzo per la nazione suddita. I loro viaggi estenuavano i popoli, e la loro dimora diventava anche più ruinosa>> (2).
A questa ben triste ed invereconda espoliazione, che cordoglio amarissimo costò anche a’ nemici della decaduta famiglia Sveva, dové rassegnasi Castelluccio. Anzi ne ricevé pregiudizio maggiore, per le due colonie provenziali che vennero a stabilirsi nelle sue vicinanze, formando i due comuni di Faeto e Celle. Distanti essi, in linea retta, dal nostro i lprimo poco più di tre chilometri, ed il secondo circa due, necessariamente i coloni provenzali dovettero insignorirsi de’ nostri boschi
e de’ nostri campi. Per tal fatto l’azione de’ nostri contadini ne’ lavori agricoli e industriali, crescendo col volgere degli anni la popolazione, è rimasta strozzata nel suo sviluppo.
È però vero che Casteluccio conservò su queste colonie diritti e privilegi moltissimi, anzi un vero jus di alto dominio, assoggettandole a servitù anche indecorose; come quella di venire, nei giorni festivi, a spazzare le strade del nostro comune. Servitù durata fino al principio del corrente secolo, quando emancipati completamente, furono francati dall’obbligo del servaggio. La diversità della lingua, delle abitudini, ed il loro pertinace costume di avventurieri, non rendevano però la vicinanza piacevole, e la servitù gradita.
Con questa cruda affermazione non s’intende offendere l’amor proprio degli attuali abitatori di quei comuni. Anche Roma, l’inclita Roma, la caput mundi si ebbe per fondatori ladri e banditi; o come un professore li ha ultimamente chiamati <<briganti disciplinati>>. Il vero merito è figlio delle proprie opere, non di precedenti grandezze, e d’illustri natali. Nec generi, sed virtuti gloriam (3).
(1) Il Monarca che incominciò ad appellarsi Re delle Due Sicilie fu Alfonso I D’Aragona – (2) Sismondi, Cap. 21 – (3) Fedro, Libro II Epilogo
XVII
Le tiranniche ed inique tasse, imposte da Re Carlo agl’ infelici sudditi, producevano continui ed incessanti clamori, e con questi si diffondea il malcontento.
La rivoluzione di Sicilia, ed il pericolo di vederla estesa alle province continentali, commossero il Principe di Salerno, Luogotenente del Regno, in assenza del padre, e che dopo regnò col nome di Carlo II, e lo spinsero a mitigare gli esasperati animi con opportune e larghe concessioni. Radunò a tal uopo in Calabria numerosa assemblea di Prelati, Baroni, e delegati municipali, per sentire i reclami, e provvedervi con saltuari rimedii. <<In una numerosa assemblea, dice l’istorico Leo, di Prelati, Baroni, e deputati delle Città, nel 1283 fu conceduta una specie di Magna Carta, affine di unire, per quanto era possibile, con un legame morale i sudditi della famiglia Angioina, e fu potissima cagione che la rivoluzione di Sicilia non si estendesse anche in Calabria. Queste leggi, emanate nelle pianure di S. Martino, furono addimandate Constitutiones Illustris D. Caroli II Principis Palermitani>> (1).
Con esse furono assicurati al Clero e Baroni privilegi moltissimi. Per gli altri sudditi, oltre al condono degli arretrati, fu convenuto <<non dovessero altri balzelli pagare da quelli in fuora erano stati imposti da Guglielmo II>> né il Re in prosieguo potea chiedere collette, prestazioni, od altro, non comprese nelle Costituzioni precedenti.
Quest’ultimo patto convenzionale e di grazia, non ebbe mai intero effetto. Ne’ commentarii di Napodano, dice Giannone, si legge avvenire spesso <<che in ciascun mese sei collette si esigevano, scorticando, gli Uffici Regì, i poveri Regnicoli usque ad sacculum et peram, et tegularum avulsionem >> (2).
Spetta alla storia generale discutere il fatto, a me basta averlo cennato, per mostrare la nequizia de’ tempi.
Ammessa e ritenuta per vera la durezza di tale inadempimento a’ patti convenuti, pure, trovandosi Castelluccio non ancora soggetto a dominio Baronale, ne ebbe almeno giovamento ne’ balzelli principali; e fu sempre un bene, un sollievo pei poveri ed infelici abitanti.
(1) Leo Storia d’Italia del medio evo. Lib. IX, v.2 p.148 – (2) Giannone Lib. XX Cap. IX Parag. II.
XVIII
Con tal reggimento si visse, se non bene, almeno rassegnati, fino alla morte della Regina Giovanna II, avvenuta a’ 2 febbraio 1435,
L’incostanza e la volubilità di animo di questa donna, col moltiplicare i pretendenti alla successione, mise il reame in grave sconvolgimento; e sparse il seme della discordia tra Francia, e Spagna che, per lungo tempo, funestarono queste Province con guerra crudelissima, ed accrebbero la miseria de’ popoli.
Per l’estensione della discendenza di Carlo I d’Angiò, il Regno di Napoli trovossi diviso in tre fazioni. La prima, più numerosa, proclamava a sovrano l’erede testamentario Renato d’Angiò.
La seconda, sostenuta da varii e potenti Baroni del Regno, seguiva l’erede adottivo Alfonso d’Aragona. La terza favoreggiava la pretesa del Papa Eugenio IV, che, con Breve datato in Firenze a 1° Maggio 1435, ordinava al patriarca di Alessandria Giovanni Vitelleschi, di governare il Reame, come feudo ricaduto alla S. Sede, per mancata posterità di Carlo I d’Angiò.
I Napoletani, al partito angioino affezionatissimi, se niun riguardo si ebbero per gli ordini di Eugenio, non poterono in simil modo spregiare l’Aragonese, che preparavasi a sostenere sue ragioni con gli eserciti. E la guerra addivenne inevitabile, e disastrosa a’ popoli dell’infelice Reame.
Sventura volle che Renato trovavasi prigioniero del Duca di Borgogna in Francia, né potea personalmente provvedere a’ bisogni della guerra.
I sedici Baroni, nominati dalla defunta Regina per Consiglio della Reggenza, ben compresero la difficoltà del mandato loro affidato. Né lo amore al partito Angioino velò la serenità del loro giudizio, per non riconoscere la superiorità del potente competitore, che monarca di più Reami, disponeva di maggior copia di uomini, e di denari. Non però venne meno la loro devozione. <<Chiamarono, dice Giannone, Giacomo Caldora, uno de’ condottieri più rinomati del tempo, al quale diedero denari perché assoldasse genti; soldarono ancora Antonio Pontudera con mille cavalli, e Micheletto da Costignola con altrettanti, per respingere gl’ insulti di Alfonso: ed in tal guisa, quelli mesi che corsero tra la morte della Regina, fino alla venuta della Regina Isabella, moglie e vicaria di Renato, fu governato il Regno>> (1). Per soprabbondare in prudenza si raccomandarono ancora al Duca di Milano Filippo M.a Visconte <<il quale sollecitò i Genovesi, che in quel tempo si trovavano sottoposti alla sua signoria, che accorsero alla città di Gaeta già assediata da Alfonso, né sopportassero che il miglior porto del mar Tirreno venisse in potere de’ Catalani loro nemici>> (2). I Genovesi accolsero l’invito del Duca; ma per le discordie, e le mene dell’opposto partito, ceh agognava al potere in città, l’armamento della flotta venne ritardato. «Con tutto ciò la flotta fu infine allestita; e Biagio d’Aneroto, illustre uomo di mare, eletto a capitanarla, spiegò le vele.
La flotta era composta di tredici vascelli, e tre galere, avendo a bordo duemila e quattrocento soldati. Quella dell’Aragonese era di quattordici vascelli e undici galere, con seimila soldati scelti tra tutto l’esercito» (3).
Le ostilità ebbero ben presto cominciamento. Il primo successo coronò, in gran parte, i voti dei Napoletani. La gloriosa battaglia navale del 5 agosto 1435, combattuta nelle acque di Ponza, ebbe fine con la prigionia, del Re Alfonso, di due suoi fratelli, e di gran numero di Baroni Napoletani suoi aderenti. Non fu salva che una sola nave Aragonese: le altre, prese, o affondate.
(1) Giannone L. XXV. Cap. VII – (2) Giannone ivi – (3) Sismondi Cap. 67 tom. II, p.23 Ed. Lug. 1838
Questa prima battaglia avrebbe messo fine alla guerra, senza magnanimità, o a dir meglio, il tradimento del Duca di Milano che, da protettore di Renato, gli addivene contrario; liberando, senza riscatto o condizioni, il Re ed i numerosi prigionieri, frutto di sanguinosa vittoria, non sua, ma della valorosa flotta Genovese.
Con la libertà l’Aragonese ottenne anche l’appoggio e la protezione del Duca; e la guerra ricominciò più cruda ed ostinata. Le sorti però rimasero lungamente incerte, non potendo niuno dei competitori gloriarsi di decisivi vantaggi.
Tosto che Renato, ad intercessione del S. Pontefice, si ebbe la libertà nel 1438, sollecitamente si mosse ala volta di Napoli per mettersi a capo dell’esercito, sperando, con l’attività e la bravura, ottenere vantaggi tali, da rinfrancare il morale dell’esercito e de’ suoi partigiani.
Sebbene riconquistato avesse gli Abruzzi con qualche gloria, pure la sua causa non prosperava, anzi di giorno in giorno andava sempre di più declinando.
Quando il suo cuore non ancora trovavasi totalmente sopraffatto dallo sconforto, vennegli un impreveduto colpo che, in gran parte, scosse la sua energia e la sua fede nel finale successo. Ai 15 ottobre, o siccome crede Sismondi a’ 18 ottobre 1439, Giacomo Caldora o Caudola, come lo appella lo istorico testè citato, (1) il prode e valente Capitano che servito l’avea con devozione e fedeltà, fu rapito a’ vivi da morte subitanea. A colmo del gravissimo infortunio, il figlio Antonio, che prese il comando delle milizie, non mosrtavasi, come il padre, tenacemente attaccato al partito Angioino.
Fu sotto i colpi funesti di sì crudele sventura che Renato, tormentato da tristi presentimenti, e da penosa incertezza, a propiziarsi il novello Capitano Antonio Caudola o Caldora arrecò a Castelluccio pregiudizio gravissimo. Dopo aver confiramto il Caudola nel Ducato di Bari, ed in tutti i beni, cariche, ed onori paterni, l’infelice Monarca diè di mano ad altre libertà, sperando così di tenerlo avvinto al carro della sua fortuna. Credeva insomma che, se non per amore, ed avea ben ragione di dubitarne, volesse almeno per gratitudine fedelmente servirlo.
A questo fine, ed in tali circostanze, Renato costituì la Baronia di Valmaggiore, investendone colui che solo potea sostenerlo nel proseguimento della guerra. E Castelluccio, dopo più di 450 anni, da libero Comune, con prammatica di questo Re sventurato, passò con Faeto e Celle sotto la mala Signoria Baronale, che tiranneggiò le misere popolazioni, fino al principio del XIX secolo.
Il novello Barone, col Regio Camerario, delegato speciale del Governo, si recarono in Castelluccio per la presa di possesso, e formazione dei capitoli, o convenzione con i vassalli.
Di essi ne trascrivo il solo principio, come interessante alla dimostrazione del fatto.
Capitula facta et reformata in Castro Castellutii Vallis majoris, per Camerarium videlicet Joannem Marciani, et Universitatem ejusdem castri Castellutii, ac confirmata per magnificum et exellentem Dominum donnum Antonium Caudolam ducem Bari, ac armorum magnificum Capitaneum. Regnate Inclito et Serenissimo Domino nostro Renato. Dei Gratia Iherusalem et Siciliae Rege etc.
Anno Domino M. quatricentesimo quatrigesimo, mense Februarii die quinto decimo. (2)
Tralasciando gli articoli tutti de’ detti capitoli, che presentemente non offrono importanza ed interesse alcuno, credo utile far solo notare che essi altro non erano che un complesso di diritti e dovrei, tra Barone e vassalli; privilegi ed immunità in designate circostanze; regola nell’esercizio de’ diritti civili, commerciali e sociali; penalità e multe nelle contravvenzioni, e qualcuno di pura ostentazione. Insomma un piccolo codice convenzionaleda servire di norma agl’interessati, nel disimpegno de’ rispettivi diritti e doveri.
Il magnanimo Re, con quest’atto di benevolenza, non raggiunse lo scopo. È a tutti noto, né giova qui diffusamente rammentarlo, che il Caldora o Caudola, nel seguente anno 1441, passò, con l’intera compagnia da lui capitanata, ad ingrossare le schiere del Re Aragonese. Nè ardisco pronunciare un grave giudizio storico, se la sua diserzione fu o pur no un vero tradimento. Noto solo la conseguenza dell’abbandono, la perdita cioè della Baronia. «L’oggetto essenziale di un feudo, dice Hallam, era un contratto di vicendevole appoggio e fedeltà. Se il feudatario mancava di fede, gli venivano tolte le terre, che ritornavano all’antico padrone» (3).
(1) Sismondi Cap.70 – N.B. Insisto su questo cognome, perché esso interessa alla storia di Castellucio – (2) Documento di pergamena, esistente nell’archivio della Segreteria del Comune fol. 1 – (3) Hallam l’Europa nel Medioevo – Sistema Feudale cap.V
Frattanto, perduto questo potente appoggio, Renato trovossi in condizione assai difficile. Scarso di milizie proprie, e privo di mezzi pecuniarii per assoldare compagnie di ventura, fu costretto dopo non molto, a chiudersi in Napoli, dove prestamente venne rigorosamente assediato. L’avversa sorte non lo avvilì giammai, e dal popolo fu ammirato e con zelo servito. «Si accetto, dice Sismondi, erasi reso ai Napoletani, e di sì buon cuore partecipava degli stenti comuni, che il popolo non movea alcuna lagnanza, e sopportava per amor suo i più grandi patimenti» (1).
Il tradimento del muratore Aniello che introdusse in Città gli Aragonesi per un vecchi acquedotto, a’ 2 giugno 1442, abbreviò l’eroismo de’ Napoletani, e distrusse l’ultima speranza del Re Angioino.
La Città, saccheggiata per alcune ore, venne militarmente occupata. Renato, imbarcatosi su nave Genovese, lasciò il Regno. Verso la fine di quello stesso anno «per non prolungare inutilmente i mali di un popolo, che gli avea mostrato amore e fedeltà» mandò ordine a’ suoi luogotenenti, di consegnare al fortunato vincitore le fortezze che teneano ancora per lui (2).
Il re Alfonso, raffermata la sua autorità, sollecitamente diè mano alla pacificazione del Reame. Ed al riordinamento delle amministrazioni.
Il trionfo dell’Aragonese fu un bene, o un male per la Monarchia Napolitana? Il giudizio non è facile. In questo, come in altri simili mutamenti, si giudica sempre secondo il proprio convincimento e la propria affezione. Ciascuno de’ competitori avea delle buone qualità, ma, se non erro, queste onoravano pi la persona che il savio reggimento del Regno. L’unico e certo vantaggio, che si ottenne col trionfo dell’Aragonese, fu il ristabilimento della monarchia nella sua integrità, con la riunione della Sicilia, che trovavasi disgiunta da Napoli, fin da’ famosi Vespri Sicilinai, nel 1282 riunione che sventuratamente però durò appena, quanto la sua vita. Addivenne realmente definitiva nel 1734 per la conquista di Carlo Borbone.
(1) Sismondi cap. 70. – (2) Sismondi ivi.
XIX
Son portato a credere che il nuovo Re, non riconcedette al Caudola la Baronia di Valmaggiore, e che essa, poco tempo dopo, fu provvisoriamente data alla contessa di Celano, che la ritenne, con questo titolo, fino al 1463, quando definitivamente, e con nuova investitura, dal Re Ferdinando I successore di Alfonso, venne concessa a D. Antonio d’Aragona da Piccolominibus, ed alla Contessa di Celano sua consorte. Per altro non mi fermo al solo mio convincimento. Il documento sopra citato, Capitoli Baronali, ne somministra sicura ed evidente testimonianza. Documento al quale, in preferenza di altri meno certi, mi riporterò in prosieguo, e che formerà la base del mio ragionamento, nel descrivere la progressiva successione de’ Signori della Baronia.
In data de’ 24 agosto 1458, trovasi inserita, nei summenzionati capitoli, dimanda dell’Università di Castelluccio alla Exellentia Madama Covella Contesss di Celano, affinché confirmasse i precedenti capitoli e di fatto vi appose il suo placet (1). Tuttavia è certo benanche che il Re Ferdinando, con nuovo diploma, concedette al suo genero Piccolomini la Baronia in parola.
Nel grande Archivio di Napoli non è facile rinvenire il registro del 1463; nel principio del corrente secolo esisteva però copia del Diploma, estratto dagl’ interessati a’ 20 febbraio 1484. Di più, nel primo repertorio delle province d Bari e Capitanata, trovasi scritto «La Castella di Castelluccio, Celle, e Faito si dicono la Baronia di Valmaggiore, le quali furono inter alia nel 1463 concesse, insieme al contado do Celano, per Re Ferrante, ed Antonio de Piccolominibus de Aragona, suo genero, in remunerazione de’ suoi servizii, come largamente si narra in tractatu dicti Celani. » Il novello signore riconfirmò i capitoli a’ 29 maggio 1465, segnandosi Antonius de Aragona Piccolominibus, Dux Amalfi et Comes Celanus, manu propria (2).
Molti frequenti passaggi subì la Baronia in prosieguo. Al primo Feudatario subentrò D. Giovan Battista de Piccolominibus, Marchese di Illicito (ora Deliceto) che la ritenne in qualità di utile signore. I capitoli furono confirmati a’ 19 agosto 1507 (3).
Dal Marchese di Deliceto, l’utile dominio pervenne a Giacomo Recco, che confirmò tutte le concessioni fatte dal Duca d’Amalfi, e dal Marchese di Deliceto, a 11 settembre 1519 (4).
Nel 1561 la Baronia ritornò al Marchese di Deliceto che, nel seguente anno, la cedette a Marco Antonio Pepi di Napoli; i capitoli vennero confirmati a’ 3 settembre 1562 (5).
Nel 1567 la Baronia fu venduta a D. Emilia Carafa Contesse di Airoli e Biccari per ducati 17.000, cioè Lire Italiane 72.250. La prefata Contessa confirmò i capitoli a’ 21 aprile dell’istesso anno, (6) e richiese dal Vicerè Duca di Alba, la Terra di Castelluccio Valmaggiore, per sua camera riservata; e l’ottenne a’ 31 dicembre 1569. (7) Nè essa però, né i successori si avvalsero mai di tal privilegio.
Ad Emilia Carafa successe nel 1576 Ferdinando Caracciolo Conte di Airoli e Biccari, che la trasmise a’ suoi eredi. Questa famiglia tenne più lungamente in suo dominio la Baronia.
L’ultimo discendente Caracciolo Barone Carlo morì senza eredi maschi nel 1709. Ereditò la sorella Antonia, maritata a Giambattista De Capua Principe della Riccia. I conjugi De Capua-Caracciolo la tramandarono a’ figli.
Nel 1792 D. Bartolomeo II De Capua, cessò di vivere senza parole. Pria di morire avea già donato il burgensatico della Baronia a D. Francesco Vincenzo Sanseverino Duca della Saponara. I diritti feudali furono devoluti al Real Fisco, che li conservò fino all’abolizione della Feudalità.
(1) Capitoli fol. 16 – (2) Capitoli fol. 19 a t. – (3) Cap. fol. 20 – (4) Cap. fol. 30 – (5) Cap. fol. 46 a t. – (6) Capitoli fol. 48 – (7) Documento esistente nel Grande Archivio
La divisione de’ beni feudali da’ burgensatici, dopo minuto e ponderato lavoro, fu eseguita a’ 22 gennaio 1795, dal Consultore Cardillo, e D. Nicola Vivenzio di Napoli.
In mezzo al tramestìo di concessioni, vendite, emissioni, ho creduto più corretto segnare l’epoca della conferma de’ Capitoli e presa di possesso. Con questi atti, il Barone, venendo di fatto ad essere riconosciuto da’ vassalli, si ha la data certa del reale dominio.
Le cause che fecero passare, da uno in altro Signore, la Baronia si appartengono alla storia di quelle famiglie, e sarebbe ozioso ed imprudente farne qui speciale menzione; specialmente che dette cause, prospere o avverse, non valsero a modificare la durezza del servaggio.
XX
Durante il regime feudale, l’amministrazione della giustizia Baronale trovavasi affidata e concentrata nelle mani di un solo magistrato, detto Capitanio; eletto dal Barone fino al 1792, indi dal Re. In Castelluccio, capoluogo della Baronia, tenea residenza il detto magistrato. Quivi erano le corti, le carceri, e gli uffici tutti di giustizia.
Secondo le capitolazioni, così dette vecchie e nuove, formate con l’approvazione del Governo, il Camerlingo, o amministrazione civile di Castelluccio, per concessione e privilegio, in ogni anno
da’ 21 a’ 28 giugno, cioè tre giorni prima della festività del protettore del comune S. Giovanni Battista, e quattro giorni dopo, esercitava tutti i poteri del Capitanio sui tre comuni della Baronia e rispettivi tenimenti, sì nelle cause civili, che nelle criminali, e miste.
Sul principio, pare, che la giurisdizione del Capitanio non fosse così lata. Il diritto a giudicare nelle cause criminali, suprema regalìa della Corona, non fu concesso che a pochi e grandi Baroni dal Re Roberto d’Angiò (1). Posteriormente fu venduto a tutti da Alfonso I d’Aragona. «Quello, dice Giannone, di che non si ebbero molto a lodare i secoli seguenti, fu d’aver Alfonso conceduto a’ Baroni, il mero e misto imperio. Avendo questo Principe, per la sua sterminata libertà,resi esausti tutti gli altri fonti, cominciò ad essere profuso anche delle supreme regalie, che non doveano a verun patto divellersi dalla Corona» (2).
Ne’ capitoli primitivi della Baronia, non trovasi menzionata la giurisdizione criminale: posteriormente vedesi cennata, ed a’ tempi di Piccolominibus Marchese di Deliceto, venne chiaramente espressa. Né è da credersi che la giurisdizionale prerogativa, delegata ad tempus al nostro Camerlingo, fosse semplice onorificenza, senza poterne esercitare le attribuzioni per deficienza di giudicabili! Anzi, per costante tradizione, è certo il contrario; ed in molti anni il concorso ne era grandissimo, tanto che, a contenere la moltitudine, non bastando il locale destinato, i giudizii si trattavano in luoghi aperti. Il motivo di sì estraordinario concorso apparirà naturale, qualora voglia considerarsi che, al Camerlingo, non giovando la severità ed il fiscalismo degli agenti Baronali, per necessità il suo pronunciato veniva ad essere improntato di maggiore indulgenza. I vassalli giudicabili, perciò, facendo a fidanza della mitezza della pena, escogitavano tutti i mezzi, metteano in opera tutti i ripieghi, si avvalevano di tutte le circostanze, per ritardare od affrettare il corso delle loro cause, per vederle trattate o discusse durante il tempo che, il prelodato magistrato temporaneo amministrava la giustizia.
Oltre questo privilegio, il Camerlingo, godeva l’altro di surrogare il Capitanio che mancava, o rattrovavasi in circostanze da non poter esercitare il suo ufficio. Privilegio che gli venne accordato da Giambattista de’ Piccolominibus Marchese di Deliceto, e confirmato da’ posteriori Baroni (3).
Fin da’ primi anni della Baronia, per accrescere lustro e concorso alla festività del protettore del comune di S. Giovanni Battista, a’ 24 giugno, fu istituita la fiera di animali, con franchigia da tutti i balzelli soliti a riscuotersi da’ Baroni nelle comprevendite di simil genere.
(1) Angelo di Costanzo, Storia di Napoli, Lib. VI – (2) Giannone, Lib. XXVI. Cap. VII – (3) Capitoli, N. 77
XXI
L’elevazione de’ tre comuni a Baronia avvenne in epoca di progredita civiltà, perciò né le prammatiche, né le capitolazioni conteneano diritti ignominosi; e sul principio, neanche tasse soverchiamente onerose e vessatorie: tanto che, le popolazioni si sottomisero, se non con piacere, almeno senza grave opposizione e contrasto. Sventuratamente la primitiva mitezza non ebbe lunga durata. Per effetto delle avvenute cessioni e comprevendite, la Baronia addivenne oggetto di commercio, e di speculazioni turpissime. I possessori, per rifarsi in breve tempo del prezzo pagato, cercavano sfruttare, con mezzi anche illeciti ed arbitrari, tutte le risorse de’ Comuni. Di fatto, con subdoli ritrovati, pria estesero la mano usurpatrice sui beni de’ demanii Comunali; indi sulle fatiche de’ miseri agricoltori, fino a pretendere da essi un tumulo e mezzo di grano od orzo per ogni versura seminata, anche su terreni particolari.
Devoluta allo Stato la Baronia, i vassalli de’ tre comuni non s’illusero con vana speranza di vedere migliorata la oro condizione per generosità del Governo: né per un solo istante concepirono l’audace di resistere agli agenti del Real Fisco, come alle volte, si erano arbitrati con gli esattori Baronali. Ben compresero che licenziandosi in tal guisa avrebbero maggiormente compromessa l’infelice loro condizione, ed amareggiato l’ultimo tozzo di pane che rimaneva in casa per sostentare la grama vita della famiglia.
Fu duopo perciò ricorrere a’ mezzi legali di giustizia.
L’indole di questo lavoro non permette addentrarmi in una minuta esposizione di tutti gl’ insistenti reclami presentati; né mi è dato descrivere le singole vicende della causa, a cui i tre comuni furono necessitati sobbarcarsi; mi limiterò a’ fatti di maggiore importanza, e d’interesse speciale.
Non trovando i vassalli miglior via per assicurare il trionfo della giustizia, con la difesa dei propri interessi , si affrettarono nel 1793 a presentare al Real Trono la prima ragionata domanda contro otto capi di gravezze, che i Baroni loro aveano arbitrariamente imposte. A questi, riesaminati i primitivi obblighi con maggiore studio , poco dopo se ne aggiunsero altri tre. I reclami, con Real carta de’ 7 maggio dello stesso anno, furono rimessi alla Regia Camera per le provvidenza di giustizia. I tempi però no si presentavano ad una pronta riparazione. Il cielo di Europa era tutto fosco e carico di elettricità. La bufera che in Francia imperversava ferocissima, avendo raggiunta nel 93 il suo apogèo, minacciava scatenarsi da per ogni dove , per abbattere e rovesciare le antiche istituzioni, e le mal ferme Monarchie. Re Ferdinando, dedito più a’ piaceri, che alle cure del Regno, no si riscosse che all’ultima ora; ed usando ed abusando del potere supremo, stremò il Regno di uomini e denari. Espediente inutile e ruinoso, che invece di attenuare i mali, ne aggravò la portata.
Nei grandi pericoli, e negli estremi bisogni, fatalmente la mente rimane sì ottenebrata da smarrire la retta via: ed il Re, dice Colletta, davvero la perdette. Invece di una politica savia, assennata ed energica, prescelse la scaltrezza, e la doppiezza, or per la pace, ed or per la guerra. Secondato da timidi consiglieri, non seppe né mantenere la neutralità che, codardemente, soggiunse l’istesso storico, tante volte avea promesso alla Francia, né farsi realmente temere. Politica, che ,emtre mandava in ruina lo Stato, non giovava alla causa del Trono, ed all’onore della dinastia: e fu costretto ad emigrare dal Regno.
In tale stato di generale confusione e di calamità, pretendere giustizia era arroganza: ed i tre comuni proseguirono ad essere dissanguati dagli agenti fiscali.
I momentanei insuccessi della Francia, e le famose gesta brigantesche del Cardinale Ruffo accrebbero l’ardire del Re e de’ Ministri. La fortuna loro fu anche questa volta benigna. Per la pace di Amiens il Re potè ritornare in Napoli, dove si ebbe, e lo Coletta, accoglienza non uffiziale, ma cordiale. Il popolo non partecipava alla sconfinata libertà repubblicana , e malvedeva l’occupazione Francese. I tre comuni della Baronia profittarono di tale sosta, rinnovando i reclami, e ne ottennero qualche beneficio. Con decreto de’ 12 luglio 1803, otto delle undici gravezze furono abolite, come ingiuste: le altre tre vennero sottoposte a termine.
I gravami rimandati a nuovo esame con questa formula, erano:
1°) Che gli utili Signori della Baronia aveano usurpati i territorii detti Montagna di S. Vit, Piano del Conte, Vallenova, Prazeta, e Vado del Visco.
2°) Che il terraggio di un tomolo e mezzo di grano od orzo, per ogni versura seminata, anche in terreni di particolare spettanza, era abusivo.
3°) Che si erano ridotti, per comodo ed utile della Camera Baronale, quasi tutti i beni demaniali appartenenti alle Università vassalle.
Per le sopraggiunte nuove complicazioni politiche, in cui anche l’Italia venne travolta, non fu possibile ultimare la causa, che videsi rimandata a miglior tempo.
Le sofferte sventure non valsero a fa rinsavire i Reggitoridel nostro Stato. Rivissero, per poca pace, le antiche aspirazioni e le inconsulte doppiezze. I grandi trionfi promessi dal Generale Mack, fecero perdere alla corte interamente il pudore, e rompere novellamente i patti.
Le truppe napoletane ebbero ordine di passare la frontiera, per attaccare i Francesi nello stato Pontificio. Vollero la guerra, e l’ebbero fatale, ignominiosa. Re Ferdinando umiliato dovè riprendere la via dell’esilio. I Francesi, per la seconda volta, entrarono in Napoli: e con la solita arroganza trattarono il Regno da paese conquistato, opprimendolo con tali espoliazioni e rapine, da contendere il primato a’ popoli barbari.
Il misero Reame, sfinito già dalla fame, povertà, discordie, tremuoti e giudizii feroci della Giunta di Stato, per maggiore sventura ebbesi la guerra; e dopo la guerra imperversò il brigantaggio, che ridusse i popoli dalla disperazione.
A disacerbare il cordoglio de’ poveri coloni della Baronia, lo sgravio delle otto piccole grvezze non bastava. Ad essi, delle tre rimaste a giudicare, la seconda del terraggio era di capitale interesse, come prestazione eccessiva, indoverosa, e del tutto impropria: ma dovettero rassegnarsi, per ottenere soddisfazione, ed attendere che si venisse formando un governo che funzionasse regolarmente, e che volesse ingraziarsi la benevolenza de’ sudditi, con atti di giustizia ed umanità.
Incominciato il Regno de’ Napoleonidi, le Università de’ tre comuni, ripresentarono le istanze.
Il Re Gioacchino Murat, interessandosi della giustizia de’ reclamanti, in data de’ 16 ottobre 1809, pel terraggio decretò in loro favore. «Considerando, dice la Reale disposizione, che la presunzione della legge è tutta favorevole alla libertà dei fondi, e che i possessori non debbano essere obbligati a mostrare un diritto che la legge in loro suppone. Avviene che, ove al Regio Demanio non riesce di mostrare un titolo legale che accorda tereggiare in tutto il tenimento, expedit che si astenga di tormentare quei ammiseriti coloni (1).
Formata, poco dopo, la suprema commissione feudale, la causa venne portata avanti a quel tribunale, che a’ 27 febbraio 1810, definitivamente pronunciò in favore de’ comuni, sopprimendo tutte le gravezze.
Da quest’epoca solamente Castelluccio, Faeto, e Celle addivennero veri e reali padroni della loro proprietà, e del frutto de’ propri sudori.
(1) Documento esistente negli atti della causa
XXII
Le tenebre dell’ignoranza assai tardi vennero a diradarsi da questa contrada. Salvo poche eccezioni, come D. Andrea Parente Protonotario Apostolico, nominato arciprete del comune da Monsignor Astalli a’ 4 novembre 1635, per lunghissimo tratto di tempo mancarono uomini eminenti.
Spettava al secolo XVIII di far sorgere l’aurora del letterario risorgimento.
Sventura che non potette essere prima scongiurata. «Le condizioni letterarie, dice Hallam, si distendono nel popolo a misura dell’educazione, della libera circolazione de’ libri, del benessere della società, e dei vantaggi e distinzioni che ottengono i letterati» (1).
In quei tempi che precedettero il secolo decimottavo, miserevole era lo stato economico di questa popolazione, come delle altre vicine. I cittadini, dal duro lavoro de’ campi , ritraevano appena il necessario alla vita. Oppressi da tasse inique pel malgoverno Baronale, e privi di commercio, per assoluta mancanza di strade, non potevano certamente dedicarsi allo studio. Aggiungi il difetto di mezzi, perché del poche derrate superflue, ed il prodotto delle piccole industrie, o non si vendevano, o a vilissimo prezzo venivano barattate. Né facile, e di poco conto riusciva l’acquisto de’ libri, per le moltissime restrizioni imposte alla stampa da’ Governi: mentre esse si trovava già introdotta in Italia fin dal 1463. In questo stato di generale deperimento, era mai possibile che i padri di famiglia, pur avendola a cuore, potessero seriamente pensare all’educazione letteraria de’ figli?
Ma l’umanità cammina, e la locomotiva del progresso dovea sorpassare tutte le barriere, superare ogni ostacolo, e penetrare in tutti i luoghi. Per ostinarsi a non riconoscere questo fatto provvidenziale, bisogna chiudere gli occhi alla luce evidente della realtà.
Pochi, in sul principio, furono quelli che allo studio poterono attendere, come D. Domenico Pompa, già Arciprete di Terranova, richiamato alla patria Arcipretura da Mons. Facolli nel 1746. Sacerdote bastantemente dotto nella scienza sacra e profana, e D. Giuseppe Arciprete Paolella. Anche il ceto secolare ebbe gli apostoli della scienza: D. Casimiro Tango, D. Vincenzo de Palma ed altri.
Dato però l’impulso, e via via che volgevano gli anni, il numero venne sempre più ad aumentarsi, fino a costituire, nel corrente secolo, quella luminosa pleiade di uomini preclari, che consacrano vita ed ingegno al culto di severi studii, ed al decoro e prosperità della patria. Difficile non poco mi riuscirebbe enumerare tutti gli uomini eminenti, che morti, or la patria rimpiange; bastami sol ricordare alcuni che, con maggior diritto, attendono al tributo della mia gratitudine, e riconoscenza.
Il medico D. Giuseppe Tango, cultore esimio di scienze fisiche. Ora son vecchio, ma mi ricorre ancora con compiacenza alla memoria quando quest’uomo dotto, rigido come uno spartano, ed affabile e gentile come una dama, conduceva me ed altri giovinetti coetanei miei, nel suo gabinetto da studio, e mostrandoci le sue macchine fisiche, ci sottoponeva a piccole scosse elettriche, e spiegandoci, in chiara forma, alcuni fenomeni comprendibili alla nostra età, ci confortava a coltivare col progredire degli studii, questo interessante ramo dello scibile umano. Giova ancora tramandare a’ posteri che, per opera di questo filantropo venne nel paese introdotta e promossa, ne’ primi anni del corrente secolo, la coltivazione dell’ultimissima radice tuberculosa, la patata, della famiglia delle solanacee, per ignoranza e pregiudizio degli agricoltori europei ostinatamente spregiata e negletta. I due ecclesiastici: il canonico D. Giuseppe Contini, allievo del dottissimo Mons. Javarone, e l’Arciprete D. Michele Ricchetti, entrambi con attitudine scientifica e didattica non comune, conquistarono rinomanza ed onori, come professori e sacerdoti.
Il dottor fisico D. Giuseppe de Palma che, agli esimi meriti dell’arte salutare, univa l’altro, non minore, di gran filosofo. I numerosi scritti lasciati ne fanno larga testimonianza.
(1) Hallam: L’Europa nel medio evo, cap. IX. Condizioni della società
Il Commendatore D. Desiato Janigro, giureconsulto profondo, che, dopo aver operosamente percorso i gradi tutti della magistratura, fu presidente di sezione nel Consigli di Stato: e nel sopravvenirgli l’ultimo fato, fu trovato Presidente di Sezione nella Cassazione di Napoli, esercitando sempre i suoi ufficii con molta dottrina e coscienza.
In ultimo: il cavaliere D. Giuseppe Paolella; nelle civili e amministrative leggi versatissimo, che con esemplare costanza, da Sindaco, da Consigliere e Deputato Provinciale, nonché da Regio delegato straordinario, per l’amministrazione Municipale di Foggia, immolò comodi, interessi di famiglia, e l’intera sua vita, sull’ara della patria, rinunciando sempre, generosamente, a tute le indennità ed emolumenti che gli si doveano. Operoso, ma moderato, propugnò sempre la giustizia, l’ordine, la pace, il razionale progresso, ed il pubblico bene.
Non mi fo a tessere la biografia de’ medesimi, degni di altro ingegno, di altra penna. Bastami averli rammentati: e mi conforta la speranza che i numerosi giovani del comune, che ora attendono agli studi nelle Università e nei Licei del Regno, specchiandosi a questi esempii, ne vogliano emulare la virtù ed il sapere.
XXIII
Ne’ più ciechi tempi d’ignoranza, ed in mezzo alla generale prostrazione, fra tutti gli ordini di cittadini, il Clero solamente mantennesi, quasi costantemente, ad onorevole livello. Non dico che tutti i sacerdoti si trovassero dotati di sufficiente coltura intellettuale, anzi ritengo che appena ne aveano la rudimentale; ma attesa la circostanza che la società scorgeasi immersa nella più profonda ignoranza, pur bastava al disimpegno del proprio ministero. Né poteasi pretendere dippiù da Ecclesiastici di un piccolo comune, mentre i parroci della stessa città vescovile, Troja, verso la fine del secolo XVII, non sapeano scrivere: lo dichiarano essi medesimi a Mons. Cavalieri. (1)
Questo fatto fu pel nostro Clero provvidenziale, perché trovavasi ad esso affidata la grave e difficile missione di reggere nello spirituale e religioso culto tre comuni, Castelluccio, Faeto e Celle.
Qui cade in acconcio ricordare, con maggiore chiarezza, i diritti del nostro Clero sulle Chiese de’ due vicini comuni.
Non può mettersi in dubbio, che le colonie Provenzali non aveano parrocchie autonome, ma faceano parte di quella di Castelluccio, il cui Clero Ricettizio, nella qualità di comparroco, annualmente sceglieva dal proprio seno due Partecipanti, che destinava colà come Rettori, per l’amministrazione de’ sacramenti, e servizio del culto religioso.
Questo primitivo diritto giurisdizionale, bastantemente lato, si mantenne inalterato col sopravvenire del domino Feudale; né i Broni poteano menomarlo o accrescerlo senza offendere l’autorità Ecclesiastica Diocesana, vigile custode del proprio diritto, e della propria indipendenza. In prosieguo però i Vescovi lo vennero restringendo quasi a semplice prerogativa di nomina, e finalmente l’abolirono del tutto con la separazione delle Parrocchie.
L’ultimo fatto avvenne per opera del Cardinale de Pisa Scipione Rebiba, amministratore perpetuo della Diocesi di Troja. L’eminente Porporato, con l’assentimento del S. Pontefice, con Bolla datata in Roma a’ 21 gennaio 1566 venne ad ordinare il perpetuo dismembramento e separazione delle Rettorie di Faeto e Celle dalla parrocchia di Castelluccio, elevando, anche quelle chiese, a Parrocchie autonome, sotto il titolo di SS. Salvatore quella di Faeto, e di S. Caterina quella di Celle.
L’esecuzione ed osservanza a tali ordini, venne affidata all’istesso Cardinale a suo nipote Prospero Rebiba Vescovo di Troja, che a’ 26 maggio del seguente anno 1567, comunicando agl’ interessati il summenzionato provvedimento di Roma, lo confortava di sua speciale Bolla, ove si legge:
Omnia in ea contea (nella Bolla del Cardinale) confirmamus etc. et consensum nostrum praestamus i dismembratione, et nova erectione ad Parochiales Ecclesias dictarumterrarum Faiti et Cellae; salvis semper juribus et obedentia debitis et debentis, de jure et consuetudine (1).
Gli acuisti secolari dritti al Clero di Castelluccio, su quelle due Chiese, non poteano interamente disconoscersi, senza offendere la giustizia; ed il Cardinale de Pisa, unito di autorità Apostolica, delegò al Vescovo di permutarli, lasciando alla prudenza e discrezione del medesimo la misura e le modalità del compenso di riconoscimento. A tal fine soggiunge: «Decernentes tamen supra provisionem, in dicta Bulla per Ill.mum Dominum Cardinalem et administratorem, patruum nostrum secundum carnem, factam, quod Recotr qui pro tempore fuerit Fajeti, singulis annis, recognoscat, in mense Augusti, Archipresbiterum Castellutii, in tumulis vigitiquinque frumenti, ad mensuram Neapolitanam nunc currentem. Et Rector Cellae, singulis annis in perpetuum, recognoscat, in mense Augusti, praedictum Archipresbterum Castellutii, in ducato uno. Quos tumulos vigintiquinque frumenti, et Ducatum unum, Archipresbiter pro tempore, dividere habeat inter servientes in Divinis in Ecclesia S. Ioannis Battistae Castellutii, juxta consuetuinem dictae Ecclesiae.
Quest’annua prestazione di riconoscimento per quanto mi costa, non si è ottenuta giammai; ed il Clero nostro, proseguendo nella sua opera generosa, non ha voluto avvalersi de’ mezzi legali per riscuoterla.
XXIV
Vero ed unico scopo della separazione delle Parrocchie fu quello di opporre al torrente dell’errore un argine più resistente. Si temea che quei popoli, ricadendo nell’eresia, ismarrissero completamente la cattolica fede. A scongiurare il pericolo si credè utile farli amministrare, con braccio più forte, da sacerdoti rivestiti di maggiore autorità. Tristi erano i tempi, e la rivoluzione protestante, promossa da Lutero nel principio di quel secolo, cercava far proseliti in ogni parte. I piccoli comuni, perché rozzi ed ingenui, erano più suscettibili alla seduzione, e, perché in essi la vigilanza era minore, venivano a preferenza scelti per la diffusione delle nuove dottrine, che in Faeto e Celle col fatto si propagarono.
Asserisce Giannone che anche Castelluccio ne fosse infetto; «Castelluccio, Faito e Celle in terra di Basilicata erano già state contaminate (1)». Dalla enunciata Bolla Rebiba, e dagli altri atti della Vescovile Curia di Troja, non risulta vera l’asserzione per Castelluccio. Solamente quei due comuni, con altri di Calabria, furono denunciati all’Inquisitore Generale Cardinale Alessandrino, che poco dopo, elevato al sommo Pontificato, prese il nome di Pio V, il quale commise ad alcuni Regligiosi di rianimare, nei detti luoghi, la depressa fede, e ricondurre all’ovile le smarrite pecorelle. Il frutto poco o nulla corrispondea alle fatiche de’ missionarii, ed il Cardinale Inquisitore dovè rivolgersi al Vice-Re Duca di Acalà, che, col timore seppe ridurre alla credenza i seguaci della Luterana dottrina. I propagatori furono puniti, i novelli convertiti forzati alla abjura, e gli abitanti di quei comuni, almeno apparentemente, ritornarono alla cattolica credenza. «Qui, dice la Bolla del Cardinale, in haeresim ante labem prolapsi fuerant, benedicente Domino ad fidem Catholicam reversi sint, ac propterea majore et diligentiore cura, quam hactenus usum fuerint indigere videatur».
Facile srtada, se non erro, trovò lo errore Luterano in quei comuni, a motivo che i provenzali giammai aveano serbata una fede puramente ortodossa casttolica. «Monsignor Cavalieri, osserva Giovanni Rossi, sentiva gravissimo dispiacimento, che in un luoghetto della Diocesi, nei secoli passati, vi fosse allignata rea semenza, come ei chiamava l’eresia, di errori portativi dai Fondatori Provenzali (2)». Quali errori, venissero importati da’ fondatori provenzali, l’autore non lo dice; pare però si trattasse di quelli de’ Valdesi, setta fondata da Pietro Valdo nel 1170, e che aveano qualche analogia di principii con quelli di Lutero. Mi conferma in tale idea Cesare Cantù che chiama Valdesi Luterani i propagatori della nuova dottrina, che vennero in questi luoghi a diffonderla (3).
Se bisogna prestar fede al biografo del Cavalieri, neanche con l’opera salutare e santa de’ Missionari, e del Governo, si raggiunse l’intento, né l’energico provvedimento de’ due Rebiba, con la separazione delle Parrocchie, produsse il completo ravvedimento de’ traviati; giacché, se non l’eresia Luterana, almeno i primitivi errori proseguirono a serpeggiare in quelle popolazioni; e la Santa sede dovè, dopo qualche tempo, inviarvi il Cardinale Bellarmino. «Due luoghi sono della Diocesi di antiche popolazioni di Provenzali che vi portarono degli errori, in guisa che dalla Santa Sede vi fu mandato poi il piissimo e dottissimo Cardinale Bellarmino (4)».
(1) Giannone Lib. XXXII Cap. V § II – (2) Vita di Mons. Cavalieri Lib. III Cap. VIII § 311 – (3) Cesare Cantù p.351 – Giannore Lib. XXXII cap. V §11, si ritiene per certo che i Provenzali, specialmente quelli che abitavano i monti che congiungono le Alpi con i Pirenei, professassero la credenza dei Valdesi
(4) Vita di Mons. Cavalieri Lib. II Cap. IV. p.127
Ed altrove, narra il biografo, che il Cavalieri, durante la sua lunga vita pastorale, vegliò con paterno affetto su i due comuni, temendo sempre che ritornassero agli antichi errori. Nè credo ci sia alcuno che possa dubitare dell’esattezza delle surriferite notizie, avendole l’autore raccolte da documenti originali, che si trovavano, in quell’epoca, nell’Archivio Diocesano. Credo dovessero, per l’onore de’ due Sacerdoti, Rettori di quelle chiese in quel funesto periodo di tempo di sovvertimento religioso, far bene osservare che essi né furono puniti, né furono rimossi. Fatto che chiaramente dimostra, non potersene ai medesimi addebitare la colpa: anzi pare che da essi ne fosse reclamato il sollecito provvedimento: ed in guiderdone, come si ritiene, ne ebbero dal Cardinale Rebiba la nomina di Parroci titolari ed inamovibili.
XXV
Dal già esposto, pria di procedere oltre, viene naturale il quesito: i diritti di Castelluccio sui due comuni Provenzali, sì nel civile ed amministrativo, che nell’Ecclesiastico, erano diritti legali, ottenuti cioè per regolare concessione, o arbitrarie usurpazioni, fondate sul semplice bisogno di quelle popolazioni, o in fine audace e dispotica decisione dei Baroni, Signori di questi comuni?
La mancanza di documenti rende la quistione non chiara, almeno non le dà quell’evidenza che la delicatezza della materia richiederebbe. Ma chiunque movendo dagl’incancellabili fatti generali, discende all’esame particolare, senza sforzo giungerà al principio logico della loro origine. Esaminiamo a parte a parte il quesito, prima pel civile, indi per l’Ecclesiastico, e la veerità, qual luce meridiana, s’imporrà alla mente de’ dubbiosi, a dispetto delle parvenze sofistiche.
Pur volendo non tener conto della costante tradizione locale, che fino a noi ha trasmesso , che i due comuni Provenzali fossero fin dalla loro origine sottoposti all’amministrazione di Castelluccio, mi fo ad osservare che i Re Angioini, dai quali i detti comuni ottennero l’esistenza, assicurato il Trono alla propria dinastia, impresero efficacemnte a continuare l’opera iniziata da Federico II, riordinando con rigorose costituzioni lo Stato, le Province, i Comuni (1). I due Re Carlo I e Carlo II, con numerosi capitoli provvisero all’esercizio ordinato, comunque oppressivo, della giustizia, ed alla regolare osservanza del giure amministrativo.
La fondazione quindi de’ due borghi si effettuò in epoca non di anarchia, ma sotto un Governo che volea affermare la sua autorità, e provvedere al prestigio della novella dinastia con la retta amministrazione, non solo de’ vecchi, ma anche dei nuovi comuni, che sorgevano sotto l’immediata protezione del suo vessillo.
Ammesso e ritenuto tale storico principio, è da vedersi se quei comuni fossero o pur no, in quei primi giorni di vita , nella capacità di reggersi da per se stessi.
È a tutti ben noto che i novelli comuni Provenzali si vennero formando:
1) con militi del disciolto esercito invasore, a’quali tornava conto rimanersene in queste contrade, per godere della fortuna del loro Duce.
2) con ristrettissimo numero di famiglie ligate a’ primi in parentela od amicizia, emigrate da quelle lontane regioni, per assidersi al glorioso simposio imbandito dal vittorioso compatriota, con le misere spoglie del conquistato Reame; non occuparsi certamente di giure amministrativo, ma del modo di procacciarsi benessere, e maggiori comodi di vita; scopo precipuo del loro esodo.
Dal detto appare manifesto che gl’immigrati Provenzali, non erano persone doviziose, letterate, ed esperte nel reggime amministrativo; ma poveri agricoltori ed artigiani, reclutati negli ultimi gradini della scala sociale. Senza pane, senza tetto, doveano provvedere a tutto con febbrile solerzia, per non perire di stenti e privazioni in questi monti. Per dippiù: ignoranti della lingua, delle leggi e costumi della novella patria, anche volendo, si vedeano inabili ad amministrarsi con le nostre leggi, non conformi certamente a quelle già lasciate i Provenza: il Governo, conscio di tale impotenza, potea, senza smarrire il sano concetto governativo, lasciarli in balia di se stessi?
È da supporsi quindi che, i detti comuni fossero legalmente aggregati a Casteluccio, comune vicino e stabilmente ordinato. Questo vero, dopo l’elasso di tanti secoli, se non è facile comprovarlo con documenti, che pure dovrebbero esservi nell’archivio dello Stato, lo detta la ragione ed il buon senso, ed è puerile oppugnarlo. Castelluccio, dopo aver dotato con gran parte del suo tenimento i due nascenti comuni, non potea declinare l’onorifica ma penosa missione di amministrarli.
Aggregazioni di simil natura non costituivano pericolose eccezioni, ma regola di sano governo. Anche oggidì, che il progresso ha fatto tanti prodigi nella scienza sociale, sonovi ancora in Italia da 400 e più comuni aggregati a maggiori centri. Ho detto innanzi: ristrettissimo numero di famiglie popolarono quei comuni, non per passione o esagerazione, ma altresì come affermazione positiva del vero. Il che si argomenta facilmente dal fatto che, nel 1802, dopo circa cinque secoli di esistenza, Faeto noverava 92, e Celle 72 famiglie; emerge del pubblico strumento, stipulato per la divisione del piano del conte; difesa dichiarata promiscua a’ tre comuni della Baronia, da dividersi per famiglia, giusta gli ordini delle Autorità superiori.
Assunto poi ben più difficile sarebbe il sostenere come ad alcuni è piaciuto divagarsi, obbligandomi a questa minuta disamina, che da molti verrà giudicata oziosa, come è effettivamente, che la dipendenza cioè da’ due comuni da Castelluccio fosse atto arbitrario della Baronale autorità. Oltre che il supposto urta col dimostrato, è a tutti manifesto, essere nell’interesse de’ Baroni di separare non unire, giusta il pervulgato assioma Divide et impera. Nè la speciosa idea trova riscontro nelle Prammatiche di concessioni, che si tacciono; né nelle Capitolazioni che ne somministrano prova contraria. E per vero: mi trovo aver già detto, che i Capitoli furono concordati e sottoscritti dal Barone, ed Università di Castelluccio. Per qual motivo non v’intervennero le Università di Faeto e Celle? Non è forse perché quei comuni, non avevano legale rappresentanza e Castelluccio, al quale si trovavano già aggregati, ne tutelava gli speciali interessi? In contrario essi non si sarebbero creduti legati alla fatta convenzione, pel noto principio di diritto Res inter alios acta tertio nocere non potest. Ma lo furono; tanto vero che in fine della convenzione trovasi chiaramente espresso. Per hominum Castri Castellutii Faitis et Cellarum utilitatem et cautelam. L’Università di Castelluccio, firmando dunque i Capitoli per l’utilità e cautela propria, e di Faeto e Celle, è fuor di dubbio che ne abbia tenuta la rappresentanza, l’amministrazione e la tutela. Nè può supporsi che ciò fosse avvenuto per speciale delegazione, non trovandosi tal atto né inserito, né citato nella convenzione. Resta perciò dimostrato che Castelluccio no usurpò, ma si ebbe fin dal principio, legale mandato a reggere quei comuni, e generosamente ne disimpegnò l’uffizio, senza profitto ed utilità alcuna, pur sapendo di coglierne in prosieguo l’amaro frutto, che costantemente il beneficio ottiene: l’ingratitudine.
XXVI
Per l’Ecclesiastico, più facile ne addiviene la dimostrazione del legale ufficio, e le ragioni appariscono di più chiara luce rivestite. Convengono i canonisti tutti, a dispetto della dottrina di Giansenisti, altro non essere l’uffizio Parrocchiale, che l’emanazione della potestà di ordine di Vescovi. Fino al secolo X, salvo poche eccezioni, non vi furono Parroci. Il Vescovo ne esercitava l’uffizio in tutta la Diocesi. Esso amministrava i sacramenti a’ presenti nella Chiesa Matrice, e delegava ad tempus i Presbiteri, ed in certi casi anche i Diaconi, per le altre Chiese di sua giurisdizione. Dopo il mille solamente incominciarono a vedersi semplici Sacerdoti amministrare i Sacramenti ne’ comuni jure proprio, sempre però sotto la dipendenza del Vescovo, dal quale venivano nominati stabilmente (1).
Dal permesso principale ne sorge, che ove mai il Clero di Castelluccio da se, o per autorità dei Baroni avesse usurpata, in quei comuni, la cura Parrocchiale, avrebbe arrecata all’autorità ecclesiastica Vescovile ingiuria gravissima, menomando i diritti del Superiore. E quel Vescovo sarebbesi pazientemente rassegnato a subire restrizione della propria prerogativa? È stranezza solamente immaginarlo. Cotesto io ragionamento parrà più vero, ove voglia considerarsi che usurpazioni di simil natura, se mai avvenissero, non avrebbero che durata brevissima, ancorchè un Clero potente fosse l’usurpatore. Ma il diritto del meschino nostro clero durò circa 300 anni, senza che mai fosse ostacolato o messo in dubbio da’ Vescovi Diocesani, che scrupolosamente lo rispettarono. Il vero si è, che le due Colonie Provenzali, come dal non poter costituire comune, furono dal potere civile al nostro aggregate, così, impossibilitate a formar parrocchia, vennero dalla autorità ecclesiastica alla nostra sottomesse. Il clero ricettizio nostro, coadjuatore del Parroco per antichissima istituzione o consuetudine, non potendo collettivamente esercitare in quelle chiese i proprii doveri, annualmente ne delegava le attribuzioni a determinati partecipanti. Pratica conforme a’ principii di giure Ecclesiastico. «Che se: dice Salzano, attesa l’ampiezza della Parrocchia o per altri motivi, non basterà il Parroco a sostenerne la cura, può commettere le sue veci ad un Vicario»(1). Per tal motivo i Sacerdoti ivi destinati, non portavano il nome di parroci, ma il modesto titolo di rettori.
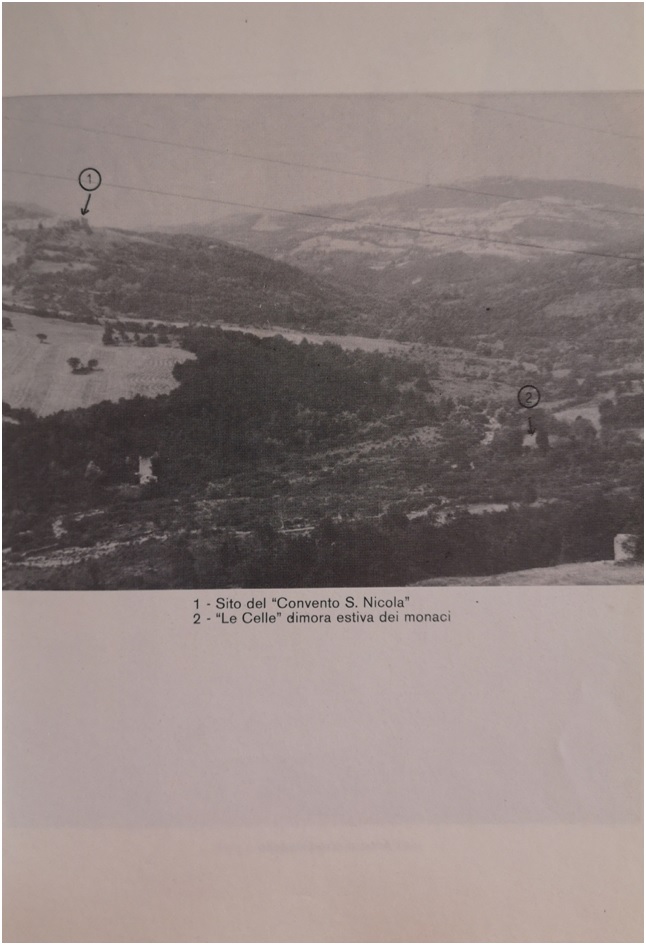

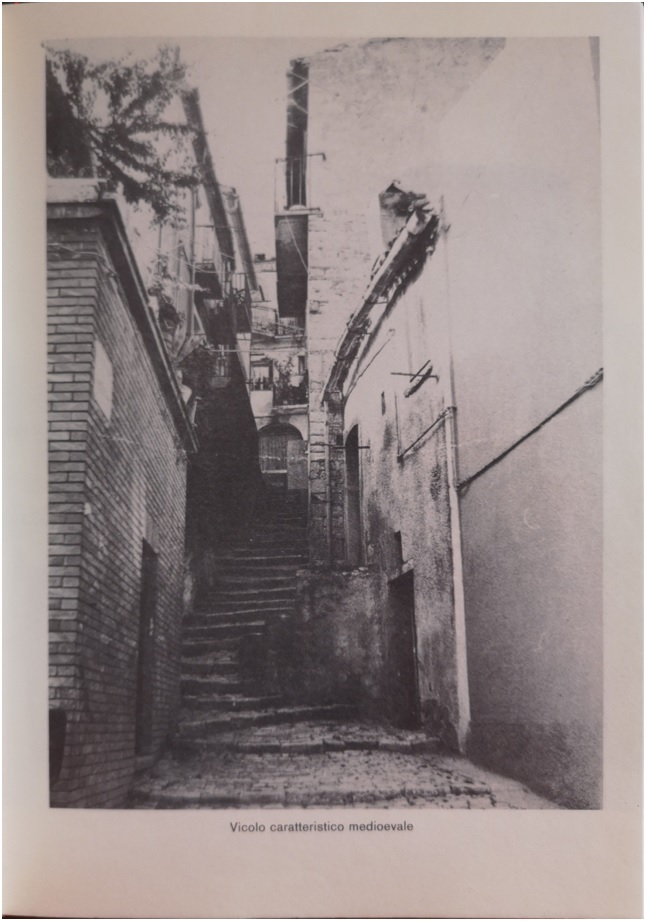
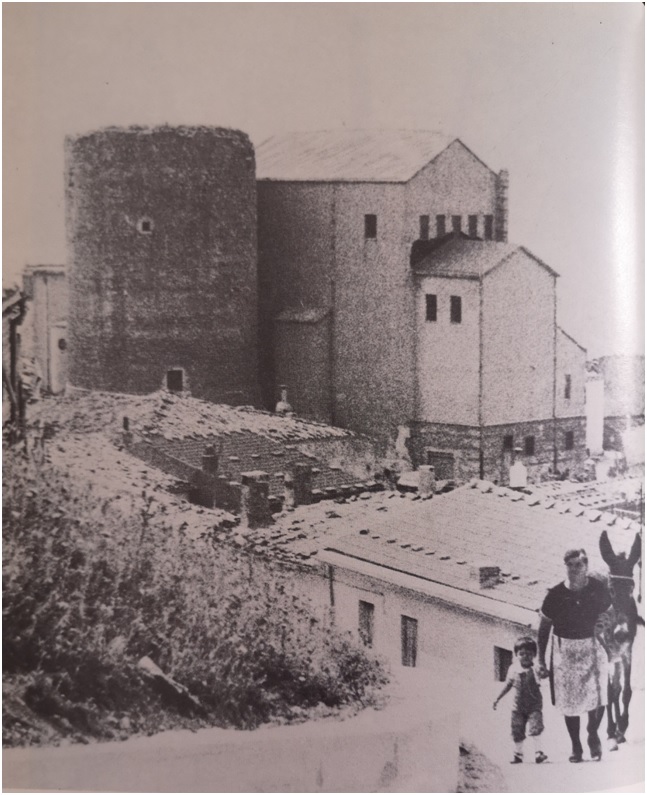
Credo che le adotte ragioni provino largamente che il diritto del Clero di Castelluccio su quelle chiese fosse canonicamente legale.
Oltre questo diritto di pura giurisdizione Parrocchiale, pare ne tenesse altro, quasi di gius patronato.
Non mi è dato spiegare perché e come avvenne, ma e non fosse esistito, il Vescovo Diocesano non avrebbe incontrato serio ostacolo nel decretare la separazione delle Parrocchie, attribuzione naturale del Vescovile uffizio. Eppure niuno de’ Vescovi che in Troja si succedettero, osò neanche tentarlo. Il Cardinale Rebiba, quando pel timore di veder ripiombate quelle popolazioni nella Luterana credenza, stimò prudente e necessario effettuarla, dovè rivolgersi alla S. Sede;
ed il S. Pontefice Pio V nell’approvare la proposta dell’esimio Porporato, volle che gli antichi diritti giurisdizionali del Clero fossero permutati in una prestazione annua di riconoscimento: ut recognoscant.
XXVII
Ritornate alla Cattolica credenza le popolazioni de’ due comuni Provenzali, l’ideata separazione delle Parrocchie, non venne immediatamente effettuata, ed i Rettori annuali, per varii altri anni proseguirono ad amministrare quelle chiese. Il Cardinale Rebiba, per delicata deferenza verso il vecchio Arciprete di Castelluccio, volle ritardarla fino alla morte del medesimo, che avvenne nel 1565. Per obitorium, dice la Bolla, Berardini de Cristofaro, olim ipsius Ecclesiae Archipresbiter, extra Romanam curiam defunti etc. (1) ed alla separazione fè seguire immediatamente, e con l’istessa Bolla, la nomina de’ nuovi titolari alle tre parrocchie.
Il concilio di Trento avea già posto termine al lavora di riforma, in ordine all’uffizio parrocchiale (2), ma non ancora riusciva possibile metterne in esecuzione i canoni, e la collazione della parrocchie proseguiva a conferirsi con le antiche norme, cioè senza concorso o esame. Il Cardinale, nella qualità di amministratore perpetuo della diocesi, avvalendosi di tale diritto, nominò Arciprete, per Castelluccio il partecipante D. Nicola Grassi; e Parroci, che il Cardinale prosiegue a chiamare rettori, per Faeto D. Berardino Patella, e per Celle D. Pasquale de Gilio: anche essi appartenenti alla nostra Ricettizia, come rilevasi da un piccolo Cabreo, redatto per mano di Notaro nel 1562 (3).
L’elevazione delle due Chiese di Faeto e Celle a Parrocchie autonome, non altra innovazione produsse, che dichiarare Parroci a vita i Rettori amovibili, e renderli di nomina Vescovile: ma i Sacerdoti del Clero di Castelluccio, per lungo altro spazio di tempo, proseguirono ad amministrare quelle chiese, fortificati da un titolo più stabile ed onorevole.
A confermare il già detto, perché non possa credersi che l’amor di patria faccia velo alla serenità del mio giudizio, sarebbe necessarioprodurre minuta cronaca di tutti i Parroci, che di tempo in tempo succedettero, ne’ tre comuni, ai primi nominati. Opera vuota di risultanze, e d’interesse storico; e, se non impossibile, di difficile esecuzione, almeno per le mie deboli forze; mi limiterò perciò agli anni che chiusero il secolo decimosesto. I pochi esempi che verrò citando, credo basteranno a raffermare il vero, che tutti già conoscono e ritengono fermamente. Berardino Patella sostenne la cura Parocchiale di Faeto per 10 anni, cioè fino al 1576. Vecchio ed affralito dalla continua fatica, rinunciò, ritirandosi in patria, ove riprese, unitamente agli altri partecipanti, gli uffizii della Ricettizia (4). Ad esso succedette D. Giovanni Jannese, anche Sacerdote del nostro Clero.
Per Celle: morto de Gilio, non so precisamente in qual anno, la cura di quella Parrocchia fu affidata all’altro sacerdote di Castelluccio, D. Domenico de Silvestro, che nel 1594 venne traslocato a Faeto, in luogo del testè defunto Jannese.
Per Castelluccio dopo la morte di Grassi avvenuta nel 1579, D. Antonio Manebola, rinunciando all’arcipretura di Montefalcone, che da varii anni reggeva, accettò la cura delle anime in patria, da Economo curato, fino al 1582, indi da Arciprete, fino all’anno 1605, in cui morì.
È ben noto a tutti che i due comuni di Faeto e Celle non incominciarono mai ad emanciparsi, che molto tempo dopo, quando, aumentata la popolazione, ed immegliata la condizione economica di vita, i cittadini si trovarono in facoltà d’incamminare i figli allo stato sacerdotale. Ho detto, incominciarono, perché fino al secolo passato, quasi mai si trovavano in questa posizione. Nel secolo XVIII D. Francesco Lubisco, D. Secondino Checchia ed altri del nostro Clero, furono Parroci di Faeto. L’istesso avvenne per Celle, anzi, quest’ultimo comune, anche oggi, è ben raro che tenga sacerdoti proprii.
(1) Bolla del Cardinale Rebiba – (2) Sessione XXIV – De reformatione Cap. 18 – (3) Documento esistente nell’archivio capitolare – (4) Documenti esistenti nell’archivio parrochiale
XXVIII
Che in Castelluccio eravi Clero sufficiente a tre Parrocchie, ed alle volte ad altre fuori Diocesi, si rileva da’ libri Parrocchiali del secolo XVI (1).
In essi trovansi notati, nel ristretto spazio di un quarto di secolo, oltre i gi nomati precedentemente, altri molti; come Antonio Chierico, Cesare Patella, Giuliano Limata, Giovanni de Berardo, Orfeo Manzella, Salvatore Ranieri, Scipione Moffa, Antonio Margherita, Aloisio de Aloisio, Giovanni Lombardi, Camillo Rinucci, Luzio Balzano, Nicola D’Anziano, De Angeli. Tutti appartenenti a famiglie riguardevoli, che, ne’ due secoli seguenti, in gran parte, con i Paparella, Lignelli, Parente, Favella, ed altri molti che rimangono non ricordati, trasferirono in paesi più liberi la loro attività e domicilio, che col volgere degli anni, addiveniva sempre più odioso e tirannico.
Mentre la nostra popolazione veniva ricolmando i moltissimi vuoti prodotti dalla falce inesorabile della pestilenza crudelissima del XVII, come narrerò in prosieguo, sopravvenne la detta spiacevole emigrazione di famiglie assai ragguardevoli per intelligenza e proprietà; ed il Comune depauperato dell’elemento vitale, rimase stremato di utili braccia; tanto che, in sul finire del secolo XVIII, non noverava che poco più di 1600 anime (2); il Clero però mantenne numeroso e contava in quei giorni 15 sacerdoti (3). Non so dar termine a questa disamina senza far notare che, in quei tempi, i Parroci non aveano, come oggi, sufficiente stabilità: passavano facilmente da uno in altro comune, e molte fiate si dimetteano. L’ufficio Parrocchiale era, come è tuttora, di grave obbligo, risponsabilità di coscienza, e di non lieve travaglio corporale; senza proporzionata ricompensa e vantaggio. Le congrue quasi dovunque non esistevano, o per la loro tenuità, non bastavano al sostentamento della vita. In molti luoghi i Parroci doveano contentarsi di poche decime Sacramentali, incerte e di difficile esazione. Il Concilio di Trento teoricamente avea elevata e nobilitata la dignità Parrocchiale; ma in pratica, mancando il corrispettivo appannaggio, la posizione perdurava invariata, e stazionaria (4).
Molti e molti altri anni doveano ancora trascorrere per giungere all’ideale del concilio. Nel Regno di Napoli appena fu possibile dopo il Concordato del 1818. Con l’articolo VII venne migliorata la condizione economica de’ Parroci, con la stabilità della congrua; e con l’art. XI furono richiamati in vigore ed osservanza i canoni del Tridentino (5).
Mi sono dilungato più del dovere nel rammentare ed esporre alcuni principii di giure Ecclesiastico, non per vanità, ma perché essi mi porgeano propizia occasione per isciogliere un tributo di commiserazione e compianto per quei miseri sacerdoti del nostro Clero, che, accettando la cura delle anime in quei comuni, immolavano sull’altare del proprio ministero, famiglia, comodi di casa, patria; e dopo laboriosa vita di sacrifizii, chiudevano il corso di loro mortale carriera, quasi spregiati, lontani dalla terra natale.
(1) Documenti esistenti nell’archivio Parrocchiale. I sacerdoti per turno amministravano i sacramenti. – (2) Censimento del 1795, si conserva nell’archivio del Parroco. – (3) Statuti della Collegiata del 1792 nell’archivio Capitolare. – (4) Nota – i Vicerè di Napoli, trovando la dottrina del Tridentino, Sess. 24, Cap. 13 de Reform., lesiva de’ diritti della Corona, non ne permisero l’attuazione, ed i Vescovi no potettero provvedere alla congrua Parrochiale. – (5) Salzano, Diritto Canonico, Lezione 22 e 24.
XXIX
La Chiesa Parrocchiale anticamente veniva ufficiata da un Clero Ricettizio innumerato. È fuor di dubbio che esso trovavasi stabilmente costituito, ed apertamente riconosciuto dalle autorità Ecclesiastiche, verso la metà del secolo XVI. Le menzionate Bolle de’ due Rebibia ne somministrano la più evidente testimonianza. Anzi, sembra certo lo fosse fin dal secolo XIII, dal perché al medesimo potè affidarsi il mandato di reggere la cura delle anime ne’ nascenti comuni provenzali, Faeto e Celle.
Le surriferite date riflettono la pienezza della vita, non già la vera genesi della Ricettizia, che completamente s’ ignora. Né è possibile, per la mancanza di documenti, accertare se ne avesse ottenuta formale approvazione dalle autorità Ecclesiastiche. Le presenti note, se fossero state compilate prima della legge di soppressione, con gravi sforzi di pazienza e lavora indefesso, riordinando e classificando i documenti esistenti in archivio, forse si sarebbe potuto ottenere un poco di luce: ma ora che i principali e più importanti documenti , specialmente il cabreo, sono passati al fondo pel culto, ogni tentativo rimarrebbe vuoto di effetto. Debbo però dichiarare che ne’ 47 anni che ho prestato il mio servigio alla Chiesa, moltissimi atti, documenti, e scritture ho dovuto consultare, per assicurare, nella qualità di Procuratore, gl’ interessi del clero, ma nulla mai ho rinvenuto da poter giovare al proposto quesito. Per tal motivo ho sempre creduto, come yuttora ritengo, che la Ricettizia si ebbe vita, non per legale atto di fondazione, ma per tacita convenzione; opera di lento lavorio de’ primi secoli del comune. Fortificata dal tacito assentimento dei Vescovi.
Appena la chiesa trovavasi sufficientemente dotata di beni, i Sacerdoti destinati alla cura delle anime , per bisogno, decoro e religione ne associarono altri, per essere coadiuvati nel disimpegno delle sacre funzioni: e come che Qui altari deserviunt cunt altare partecipant (1) avvenne che sessi furono chiamati a condividere col parroco le fatiche, ed i provventi. In tal modo i beni dotalizi della Parrocchia addivennero massa comune di tutto il clero, e così di secolo in secolo, per successione non interrotta, son pervenuti fino a noi. Per questo lungo procedimento i sacerdoti, si trovarono, di fatto, nel possesso pacifico della cura attuale delle anime, dividendo col Parroco la somministrazione de’ sacramenti, e gli altri uffizii del sacro ministero.
Questo mio convincimento, sull’origine e vita della Ricettizia, che chiamasi, se così piace convenzionale o consuetudinario , non derogando alla disciplina ecclesiastica di quei tempi venne in tutte le circostanze circondato da scrupoloso rispetto, ed avvalorato dalle autorità Ecclesiatiche di tacito riconoscimento ed appoggio.
Tal mio convincimento trova certamente sostegno validissimo nella Bolla di Mons. Rebiba per riporto dell’annua prestazione dovuta al nostro clero, da’ parroci di Faeto e Celle. Archipresbiter pro tempore dividere habeat inter servientes in divinis, in Ecclesia S. Joannis Battistae Castelluttii, juxta conseutudinem dictae Ellesiae.
Per dottrina, generalmente ritenuta da’ Canonisti, le porzioni delle Ricettizie non cosstituivano benefici Ecclesiasitci, non avendo canonica approvazione; ma venivano designate come assegni puramente civici e patrimoniali, da concedersi ai sacerdoti pel servizio personale che prestavano alla Chiesa, ratione famulatus et servitii. Dottrina fermamente riconosciuta anche a’ giorni nostri, e divisa dal Prlamento Italiano, nel formare la legge di soppressione, promulgata ai 15 agosto 1867.
Per molti secoli le Ricettizie vissero a se, senza una legislazione speciale emanata dalla potestà ecclesiastica o civile. Ciascuna dettavasi gli obblighi creduti gli obblighi creduti necessarii al retto servizio della propria chiesa, al decoro del religioso, ed ai bisogni della popolazione,
Molte con l’andare del tempo, se ne formarono regolari statuti, e ne ottennero dalla Regia potestà la debita sanzione. La nostra visse con la consuetudine fino al 1792.
La prima legge generale, se non erro, venne emanata dalla regia potestà, con la circolare dei 20 agosto 1797, comunque in forma generica, pure in modo speciale riguardava le ricettizie numerate, disponendo che, nella collazione delle partecipazioni, il merito dovesse preferirsi all’anzianità, principio non applicabile alla nostra Chiesa con Clero innumerato. Per essere ascritto ad essa bastava che l’individuo fosse ordinato sacerdote, e volesse prestare il suo personale servizio.
Questa legge del 1797 non visse lungamente: ai 7 settembre 1819 il Sovrano decretò, che le disposizioni in essa contenute rimanessero surrogate da quelle del Breve Pontificio Impensa. Dopo questo tempo vennero molte alte disposizioni, di non lieve portata, che modificarono interamente la disciplina Ecclesiastica delle Ricettizie.
È fuor di dubbio, generalmente parlando, che il patrimonio delle Ricettizie si fosse venuto formando con donazioni di più uomini, per accrescere decoro al Cattolico Culto. La sopra citata circolare del 1791, lo ritiene per positivo: in particolare poi pel nostro Clero, e forse per altri consimili con cura di anime, sembra a me che la primitiva dotazione avvenne con i beni parrocchiali come ho già detto innanzi. Nell’archivio Capitolare non trovo donazioni direttamente fatte al corpo Ricettizio anteriori al secolo XVI, mentre, tralasciando l’ignoto del precedente tempo, è verissimo che esso esisteva, ed onorevolmente funzionava fin dal secolo XIII. Fatto eloquente che prova la giustezza del mio apprezzamento, e spiega l’origine della cura attuale delle anime, trasmessa a tutti i partecipanti. L’Arciprete, in quel tempo nominato dal Vescovo, non avea per speciale attribuzione che il posto di capo autorevole, come era necessario, affinché non venisse a disgregarsi la compagine del Corpo Ricettizio, con danno irreparabile del ministero Parrochiale, e delle anime; ma, nel compimento degli ufficii della cura, era eguale agli altri partecipanti.
Se, per questo ben definito ed acclarato fatto, la Ricettizia si fosse trovata in possesso di titoli autentici, comprovanti risedere il totum jus Parochiale, per primitiva fondazione, in tutto il Corpo Ricettizio, i frati della messa comune de’ beni dotalizii Parrocchiali avrebbero formato un solo beneficio curato, esente da soppressione, a mente dell’art. 1° della Legge 15 agosto 1867. Ritengo che questa realmente era la condizione del nostro clero; ma mancando legali documenti a comprovarla, non ha potuto evitare lo scoglio della soppressione. Ed ora, questo Clero, che pur avea nel civile consorzio qualche titolo di benemerenza, ridotto a pochi vecchi, quattro di numero, insufficienti al disimpegno esatto delle funzioni di Culto, è piombato in miserevole sconforto.
XXXIII
Il fervore religioso che aleggiava fra noi, dopo la metà del secolo XVIII, quando e dottrine Volteriane non ancora si erano diffuse tra gli abitatori dei nostri monti avea resa la condizione della Ricettizia molto onorevole e dignitosa. L’ufficiatura corale, ed i rimanenti servizii di culto, venivano disimpegnati con tanta solennità ed ardente zelo, da gareggiare con le migliori e ben costituite Collegiate del Reame. Tal fatto fece sorgere desiderio di vederne nobilitato l’ordinamento con titolo più decoroso, cioè di collegiata di onore; fermi però ritenendo gli antichi obblighi, dell’assistenza personale, e di coadiuvare il Parroco nella cura delle anime. Insomma volevasi mutare l asola parte decorativa ed onorifica. Divisamento lungamente meditato, e ridotto in atto nel 1792. Redatti i novelli Statuti, consenziente l’autorità ecclesiastica diocesana, con domanda sottoscrittadal clero, municipio, e nobiltà cittadine, furono presentati al Re del Regio assenso, che si ottenne a’ 20 settembre 1792. (1) Quae quidem Ecclesia, dice, dice il diploma, quoad honores tantum collegiata haberi et reputari debeat ….. ac ex gratia speciali praeinserta Statua, juxta eorum tenorem acceptamus, approobamus et convalidamus, nostroque munimine, et preasidio roboramus, ac omnibus in eisdem contentis, et preanarratis assentimus, et consentimus, nostrumque super eis assensum Regalem preastamus, ecc.
I quindici partecipanti che in quel tempo servivano la chiesa furono tutti dichiarati canonici, da ridursi di mano in mano che succedeano le vacanze, a 12, numero organico del novello Collegio.
Pria ancora che la Ricettizia si fosse trasformata in collegiata, trovavasi il Clero già nel possesso delle insegne corali. Il Vescovo Diocesano D. Pietro Faccolli, intervenuto nel maggio del 1729 al Sinodo Provinciale di Benevento preseduto, se non erro, personalmente da sommo Pontefice Benedetto VIII, (nella bolla si legge , in concilio Beneventano), implorò ed ottenne da S. Padre facoltà di concedere le insegne corali, a’ cleri di sua Diocesi, che per assiduo e zelante servizio religiosone fossero degni: e difatti, ritornato in diocesi, le concedette al clero di Orsara, e di Castelluccio. Il vescovile provvedimento, diretto a decoro maggiore de’ cleri secondarii della diocesi, venne malamente compreso, e sinistramente giudicato dai Canonici della Cattedrale di Troja, ravvisando in esso formale offesa a’ proprii diritti, e prerogative, come se le onorificenze a noi concesse avessero, in qualche modo, menomato il prestigio della loro chiesa, Collegio principe della Diocesi. Sospinti da apprezzamenti non veri, irriverentemente si ostinarono a disconoscere e oppugnare la Vescovile autorità, e per principio il deluso orgoglio, effettivamente avvilirono se stessi, ricorrendo alla S. Congregazione de’ Vescovi. Non potea il degno prelato rimanere sotto il grave peso dell’accusa di esercizio abusivo di prerogative pontificie, senza offendere se stesso, la propria onorabilità, e la santità del Vescovile ministero. Costretto, per necessità di difesa, a respingere l’accusa, dovè dimostrare la legalità del suo operato; e per vie maggiormente ottenere lo scopo, e sradicare l’insorto dissidio, dando pace a’ cleri ingiustamente oppugnati, appena fu possibile, personalmente recossi in Roma, ed a’ piedi del Sommo Gerarca Benedetto XIV, allora regnante, espose sue ragioni; e quel degno ed illuminato Pontefice, in udienza de’ 7 febbraio1749 gli rese piena e formale giustizia, riconfermandogli la grazia ottenuta dal predecessore Benedetto XIII. Ritornato in residenza, con nuova bolla degli 8 settembre dell’istesso anno, riconoscette a’ due cleri le insegne che già possedeano. Pria che finisse l’anno, dal Re Carlo III se ne ottenne l’exequatur. (2) Le insegne Corali concesse da Mons. Facolli, erano Cappa con pelle cinerizia per l’inverno, Almuzia e Mozzetta Violacea per le altre stagioni. (3)
(1) Il Diploma e Statuti, si conservano nell’archivio Capitolare – (2) Documenti esistenti nell’Archivio Capitolare – (3) Da quest’epoca il nostro Clero, in tutti gli atti, venne sempre qualificato di Presbiteri insigniti.
XXXIV
Elevata la ricettizia a Collegiata di onore nel 1792, come innanzi si è detto, i novelli canonici erroneamente si credettero autorizzati ad immutare essi stessi le insegne Corali, sostituendo a quelle che legalmente possedevano, le abusive; cioè Cappa con pelle bianca, Almuzia e Mozzetta cremisi, e l’anello canonicale. L’arbitraria, ma non innocente innovazione, per la seconda volta, eccitò il risentimento de’ Canonici della Cattedrale, e per non arrendersi senza combattere, ricorsero a Roma con moltissime e replicate istanze, che pei moti politici di quell’epoca nefasta, rimasero inascoltate. Con costanza degna della miglior causa, attesero la pace generale, ed il del pontefice in Roma, per ripresentare con maggiore insistenza le loro querele: ma anche questa volta rimasero deluse le loro speranze. Il Cardinale Arcivescovo di Benevento, al quale la S. Congregazione aveva delegato l’esame della vertenza, mostrossi, oltre ogni dire, favorevolissimo al nostro Clero. Con questo mezzo se ne ottenne il pacifico possesso. Non mi era possibile, per l’integrità della narrazione, sorvolare su questo degradante pettegolezzo; mi son limitato però a cennarlo laconicamente, e credo che possa bastare, specialmente ora che il nostro Clero non più esiste, e le antiche piaghe sono già rimarginate. Eletto vescovo di Troja nel 1824 D. Antonino M Monforte, ricominciò pel nostro Clero nuovo periodo d’incertezza, e seguirono travagli non pochi. Dotato di un nuovo prelato di ardente zelo, ed ispirandosi ad ideali elevati, per ravvivare lo spirito religioso e morale degli Ecclesiastici, bastantemente scosso da’ principii della rivoluzione Francese dell’89, rivolse il suo impegno a rimenare a Ricettizie le Collegiate d’onore della Diocesi, sorretta dalla Bolla Pontificia Impensa dei 13 agosto 1819; richiamata in osservanza con real decreto de’ 7 settembre dell’istesso anno. A questa legge dovè sottomettersi, con gli altri Cleri, anche il nostro. I nuovi statuti compilati dal Vescovo, senza l’assentimento del Clero interessato, e parmi che questa sia la sola parte censurabile, vennero livellati su quelli generali, trasmessi a’ Vescovi con circolare Ministeriale de’ 18 settembre 1832, non ostante l’inosservanza al 3° capoverso della enunciata Ministeriale. Per questa colpa di origine, essi né furono accettati formalmente dal Clero , né il Vescovo osò dargliene legale comunicazione. Ciò non toglie che in poco per volta, se non degli speciali obblighi, almeno de’ generali se ne dovettero ritenere le principali conseguenze.
Col ritorno a Ricettizia, bisogna confessarlo ad onore del vero, se il clero perdette qi alche poco del suo prestigio, le popolazioni ne risentirono grandissimo giovamento. Molti padri di famiglia, nel dedicare i figli al Sacerdozio, non avendo proprietà fondiaria adequata alla dotazione dell’intera prole, si arrabbattavano a formare titoli fittizi di Sacro Patrimonio; espediente vituperevole, tante volte dannato da’ Sacri Canoni. Le Partecipazioni poi, potendo servire di titolo di sostentazione, giusta il parere della Commissione de’ Vescovi, approvato con Reali Rescritti de’ 18 e 24 febbraio 1824, eliminarono molti mali, e censure Ecclesiastiche; e la strada al sacerdozio addivenne più facile ed onesta a’ figli del popolo.
Con questo nuovo ordinamento il Clero venne dichiarati Ricettizio numerato, con sei Partecipazioni Maggiori, compreso l’Arciprete, e sette Minori. Era desiderabile che qui si fosse arrestata l’azione novatrice del Vescovo, ma non fu così. Trasformata la Collegiata in Ricettizia, sperava il Prelato benanche rimaneggiare, con proprio criterio, l’uso della insegne Corali, senza tener conto delle precedenti concessioni, e de’ diritti acquisiti pel lungo pacifico possesso; volea insomma tutto mutare, tutto innovare a suo modo e talento. Il Clero dignitosamente respinse la proposta come indecorosa. Per tale ostacolo , non potendo egli distruggere diritti già consolidati, ma pur fermo nel proponimento di non accettare il passato, escogitò il mezzo sospensivo di far giurare a’ neopartecipanti non far uso delle insegne Corali fino a novella decisione.
Varii anni perdurò il sospensivo provvedimento, ma finalmente, ridotti a miglior consiglio , Vescovo e Clero addivennero a nuoco e razionale accordo, bastantemente dignitoso pel corpo ricettizio. Con questo compromesso, a’ Partecipanti Maggiori furono lasciati gli onori e le insegne della Collegiata, ed a’ Partecipanti minori quelli della Concessione Faccolli. In attestato di sua particolare benevolenza il prelodato Vescovo volle concedere, tenendone da Roma speciale facoltà, a tutti i partecipanti indistintamente, la mozzetta fimbriata d’Armellino; ed a’ soli Partecipanti Maggioril’uso degli extracorali.
Ora la Ricettizia, rimasta soppressa per effetto della legge eversiva de’ 15 agosto 1867, del dignitoso ed onorevole passato non sopravvive che la memoria e uno sterile rimpianto.
Che i Sacerdoti debbano sostenere i pesi dello Stato, come ogni altro cittadino, è giusto atto di eguaglianza, ma ridurli alla miseria con tasse oppressive ed eccezionali, urta con la morale, e coi principii stessi della libertà. Pure questa crudeltà non bastava, e Ministri e Parlamento spinsero la legislazione all’estremo limite, e, con in taglio netto e preciso, come si esprime la relazione che precede la legge, si devenne alla soppressione degli enti morali Ecclesiastici. Vero è che lo stato ne ebbe momentaneo giovamento, ma in prosieguo ne risentirà le fatali conseguenze. Dopo questa infausta legge, la carriera ecclesiastica, rimasti fuori strada, e non avendo a che dedicarsi, debbono necessariamente ingrossare il numero de’ socialisti, con jattura della società e della tranquillità del Regno. Materia scottante è questa a’ cultori della libertà, ed è meglio non ripeterne le querimonie. A’ posteri l’ardua sentenza. Passata al Fondo Culto, a’ 28 luglio 1868, la proprietà della Ricettizia, si devenne alla liquidazione dell’assegno, che per le svariate e gravose tasse risultò ben tenue. Attualmente i Partecipanti Maggiori percepiscono annue lire 490,71 ed i Minori lire 384,46.
Per dotazione alla Chiesa, per spese di culto, vennero assegnate, prelevandole nella liquidazione dalla massa Capitolare, lire 500,00 oltre poca altra rendita particolare. Appannaggio appena bastevole a’ bisogni più urgenti e necessarii dell’amministrazione. Per congrua al Parroco fu distaccato un fondo rustico con l’annuo estaglio di lire 637,50 nette. Attualmente non dà che lire 280,00 lorde del contributo fondiario. Per tal fatto la posizione del Parroco riesce insostenibile.
XXXV
La più antica delle attuali chiese del comune, senza dubbio alcuno, è quella di S. Maria della Grazie. La sua origine, ravvolta nella ciligine del passato, si confonde con l’edificazione del paese.
Essa quindi, seconda per grandezza ed importanza, è prima per vetustà. Non so se ascriver debba a fatale ignoranza o principio depravato dei vuoto orgoglio, distruggere in tutte le innovazioni le preesistenti date ed iscrizioni, per porvene delle nuove; uso tuttora dominante nel comune, ne’ restauri i dei privati edifizii, che de’ pubblici. È ben certo, e va nell’ordine naturale, che i fabbricati abbisognano di tempo in tempo di positive rifazioni, per riparare l’opera distruttrice degli anni, e per ornarli secondo l’idea e gusto del secolo in cui si vive; ma pur volendo tramandare a’ posteri l’ultimo fatto, è sempre strano cancellare le prime memorie, degne di maggiore considerazione, e di storico interesse.
Si conosce per positiva tradizione che la Chiesa di S. Maria molte volte venne rinnovata, ma di pochi restauri rimane qualche data, che somministra ben poca luce: e per dippiù tal fatto devesi ascrivere a casuale concorso di circostanze, non a savia previdenza.
In occasione dell’ideato, ed ora eseguito, ingrandimento del fabbricato, che ha quasi trasformata completamente la chiesa, nel demolire i malfermi e screpolati muri di prospetto, si rinvennero sepolte nella vecchia fabbrica due lapide. La prima, con iscrizione, non avea leggibile che la sola data in numeri romani, segnando l’anno MCXIV; né fu possibile, trovandosi l’iscrizione interamente guasta dal martello, e corrosa dal tempo, in modo che appena appena se ne scorgea qualche lettera, interpretare se essa rammentasse l’edificazione del fabbricato, une rinnovazione o altro. La seconda segnava i numeri arabi l’anno 1531, col monogramma S.L. intrecciato, cioè Simone Lippi. Simile a quest’ultima n’esisteva altra all’angolo settentrionale del muro di prospetto della chiesa. Oltre di queste laconiche date a caso rinvenute, ma neanche sapientemente conservate, nella chiesa, e precisamente nell’atrio interno, non v’erano che due memorie epigrafiche, scolpite in lastre lapidee. Quella del lato destro rammentava la rinnovazione dell’atrio e prospetto, fatta eseguire nel 1578da Simone Lippi, con spesa non lieve, multo aere locavit. L’altra del sinistro lato, molto posteriore, segnava l’anno 1786. Pria di far parola di quest’ultima iscrizione, che in prosieguo riporterò integralmente, mi è indispensabile premettere alcuni fatti che diffonderanno maggiore luce su ciò che verrò narrando. Contiguo al lato meridionale della chiesa trovavasi anticamente edificato un piccolo Cenobio, occupato dagli Agostiniani scalzi, Romiti, o Riformati, come venivano appellati. Di esso anche ora rimane qualche parte. Da molti, e con grande probabilità, si è ritenuto che il detto Conventino sia stato edificato da Simone Lippi nel 1531, e che le due lapide sopra menzionate con questa data, rammentino e fermino l’epoca della fondazione.
Che gli Agostiniani Scalzi fossero stati i primi ad occupare il Cenobio pare non si possa dubitare, e la supposizione ottiene maggiore stabilità, giacché questa nuova istituzione monacale non incominciò a propagarsi nelle provincie Napoletane che ne’ primi anni del secolo XVI.
Comunque sia, ancorchè vogliasi negare a Lippi il merito della edificazione, non gli si può contestare quello della dotazione. Da molti documenti di donazione appare evidente che egli e Carlo Giordano furono i principali e più grandi benefattori del Cenobio, al quale legarono, oltre altri beni minori, una cospicua tenuta di terreni di 498 moggia, antica misura Napoletana, pari a circa ettari 136 della nuova, in una località che, dal titolo della Chiesa, venne chiamata S. Maria, denominazione che tuttora conserva.
Il conventino non ebbe che un secolo e mezzo circa di vita. La soppressione avvenne con provvedimento generale, per tutte le case dell’istesso Ordine, in esecuzione della Bolla Instaurandae emanata nel 1652 dal S. Pontefice Innocenzo X.
Nell’archivio Vescovile di Troja rattrovasi, e forse tuttora si conserva, un libro col titolo Matricola seu bona Conventus Cstellutii, firmato dal P. Guardiano F. Lorenzo da Castelluccio nel 1607.
Verso la fine del secolo XVII e principio del seguente, le cellette del monastero, se no in buono stato di conservazione, erano almeno ancora abitabili; tanto che il pio e dotto Vescovo Diocesano Mons. Cavalieri, recandosi in sante visita, vi pernottava. «In Castelluccio Valmaggiore, dice il suo biografo, fu solito starsene in alcune mezzo dirutte cellette di un antico convento soppresso, con somma ed indicibile scomodità.» (1)
Lo stato rattristante della Chiesa e del Conventino commosse l’animo del Santo Prelato, ed a scongiurarne l’estrema ruina, volle mettervi stabile e zelante custode, affinché ne prolungasse l’esistenza. A tal fine chiese ed ottenne un fratello laico della Congregazione di Deliceto, della regola di S. Alfonso de’ Liguori; e per onorarne il merito lo costituì superiore di tutti gli Eremiti della Diocesi. «Mantenne, dice l’istesso biografo, per lungo tempo un molto divoto Romito, nel. Convento soppresso di Castelluccio Valmaggiore, che fu prima degli Agostiniani Riformati, declla Congrega Licetana, acciocchè avesse nella via di Dio, di cui era assai pratico, istradati gli altri Romiti della Diocesi, costituendolo superiore di tutti, ed obbligando quelli ad unirsi, una volta al mese, a riceverne le istruzioni; e qualora questi andava visitando, come ei voleva, le loro Celle, gli avessero ubbidito in qualunque cosa.» (2)
Per l’avvenuta soppressione del Conventino, nel tempo e modo innanzi narrato, tutti i beni del medesimo passarono al Seminario Diocesano di Troja, o a dir meglio, il Vescovo pro tempore se ne impossessò destinandone l’usufrutto all’educazione dei giovani Chierici, autorizzato dalle disposizioni del Tridentino. (3)
Ma si dirà che tal atto costituiva un deplorevole abuso; sia pure: non è questo per discendere ad una larga disquisizione, sostenuta tante volte da scrittori più valenti di me. Solo mi sia permessi osservare che se la Chiesa prendea, conservava però la proprietà, mentre la democrazia, che ora impera, tutto consuma e distrugge, con danno evidente della posterità.
I beni succennati costituivano appannaggio bastantemente rilevante; e se in quell’epoca il reddito non corrispondea pienamente all’estensione de’ fondi, avveniva solo dal perché la coltivazione de’ campi non avea conquistato sviluppo ed incremento tale, da soddisfare le aspirazioni de’ coloni.
Mancavano consumatori e commercio da incoraggiare l’agricoltura; la vendita delle derrate non rimunerava largamente i produttori, ed i fondi si fittavano a villismo prezzo per erbaggi.
Per fatele errore, intrigo o mancanza di fede in un prossimo e più lieto avvenire – non mi è lecito giudicare della causa vera dell’erroneo operato – tutti gli stabili, nel 1741, furono concessi in enfiteusi, a terza generazione con canone mitissimo. Canone che non equiparava neanche gli affitti che si contrattavano in quegl’infelici tempi di strettezza economica.
Sul pregevole e principale fondo S. Maria di oltre moggia 498 ½, fu stipulato l’annuo canone di tomola 19 di grano; vale a dire meno di una misura a moggio. La misura era la ventiquattresima parte del tomolo. L’istessa regola si tenne nella censuazione di altri fondi minori. Il Rev. Seminario, nel mentre quotidianamente protestava contro l’irregolarità dell’atto di enfiteusi, e minacciava farlo annullare, inconsultamente temporeggiava. Si diè vita nel 1802, iniziando giudizio contro gli enfiteuti Mari ed altri, dichiarando la censuazione per fraudolenta, dolosa, e nulla. Portata la causa avanti la Corte della Vicaria fu discussa nel 1808, e quel magistrato, rigettando l’istanza del Seminario, ritenne per legale il contratto enfiteutico.
Riesaminare ora la validità del contratto, e la giustizia del pronunziato, sarebbe arroganza: Res judicata pro veritate habetur. Ma per dovere di storico imparziale, non posso assolvere da colpa il il consiglio di amministrazione del pio luogo, ed i quattro vescovi che tennero la Diocesi in quel tempo; principalmente:
a) per l’acquiescenza viturpevole di oltre sessanta anni, mentre per gravissimi motivi aveano ben ragione a dubitare della legalità ed onestà del contratto.
b) per avere malamente scelto il tempo allo esperimento de’ diritti e ragioni che al Seminario competeano.
Vuolsi che il Vescovo Diocesano, nel prendere possesso della proprietà del soppresso Conventino, avesse promesso all’Università di Castelluccio ritenere annualmente in Seminario, a posto gratuito, un alunno del comune, come compenso di giustizia per i beni occupati. Ne fa chiara menzione il General Catasto del 1754. Il Tridentino, che si larga facoltà concedeva a’ Vescovi di occupare beni non proprii, imponea loro però l’obbligo di mantenere nel Seminario gli alunni poveri a posto gratuito. Ma gli obblighi non si accettano facilmente come i diritti.
Non so da qual tempo la promessa Vescovile è rimasta inosservata, né i motivi che ne promossero la sospensiva; del resto l’obbligazione traendo origine non da legale titolo scritto, ma verbale, il Comune non ha potuto giammai reclamarne l’adempimento. È ben facile che per la notevole diminuzione di rendita, attesa l’inconsulta enfiteusi consumata, il Seminario siasi creduto autorizzato a no tener conto del primitivo impegno. A mio credere la jattura della renditta non poteva distruggere un diritto, specialmente che al danno vi contribuì il Comune, che or paga il fio di colpe non sue.
L’annua rendita che il Seminario attualmente percepisce dai detti fondi, se non erro, poco sorpassa le Lire 250,00, mentre se il dominio utile non si trovasse alienato, se ne otterrebbero almeno L. 2500,00, anche oggigiorno che l’agricoltura è agonizzante.
XXXVI
Con lo zelo dell’eremita provvidesi in certo modo al mantenimento del fabbricato. Cessata la sua opera intelligente ed efficace, Chiesa e Conventino, sgretolati e scalcinati da rempo, e per incuria degli uomini, deperirono a segno che le cellette superiori crollarono tutte, e delle inferiori ne rimasero ben poche. La chiesa poi, ridotta in miserevole stato, veniva adibita per teatro e stalla.
Scossi e perturbati i cittadini per sì indecoroso abbandono, e confortati dallo zelante sacerdote
D. Antonio Giannetta, che se ne rese promotore, fu divisato istituire nella chiesa, per scongiurarne l’estrema ruina, una Congrega laicale che ne prendesse cura e governo. Ottenutosi formale approvazione dell’autorità Ecclesiastica Diocesana nel 1770, fu aperto il Sodalizio sotto il titolo di S. Maria delle Grazie, che durante il tempo di vita come monastero, portaca il titolo di S. Maria della Cintura. La Chiesa, nel miglior modo possibile accomodata, fu ribenedetta per l’esercizio del religioso culto. Il pio fondatore Giannetta, non contento di quanto operato avea a prò del Sodalizio e dei gravi sacrifizii sostenuti, volle benanche accrescerne la venerazione e l’importanza: a tal fine recossi a Roma nel 1772, ed ottenne, con l’Apostolica Benedizione, indulgenze e privilegii moltissimi, per la Chiesa e fratelli congregati.
In ossequio al Real Rescritto de’ 29 giugno 1776, la confraternita implorò il regio assenso sugli statuti formati pel buon governo, che si ebbe a’ 17 luglio 1780.
Gli eseguiti lavori di rifacimento, per la strettezza del tempo e de’ mezzi pecuniarii, provvidero a’ più urgenti bisogni del fabbricato del tempio; ma non bastavano: se ne richiedeano altri che meglio rispondessero al fine del decoro e della stabilità, con spesa di non poco conto, e di maggiore importanza. Non bastando, ad ottenere tale scopo, le annue prestazioni e le volontarie offerte de’ congregati, in gran parte, spontaneamente, vi contribuì l’eminente Vescovo Diocesano Mons. Marco de Simone; e la chiesa risorse più bella e dignitosa, come lo testifica l’iscrizione che riporto, e che innanzi ho detto trovasi incisa nel lato sinistro dell’atrio interno della chiesa.
D.O.M
TEMPLUM HOC DISJECTUM MARCI SIMONE BENIGNUS PRAESULIS, ET FRATRUM, SIC REPARAVIT AMOR.
VITA IGITUR MIHI MORS, MORTI HANC POL DEBEO VITAM QUAM MORS NULLA VALET PERDERE NULLA DIES.
QUALE PRIUS FUORIM MEMENISTI, QUALE RESURGAM INSPICE, CLAMABIS, SIC PERIISSE JUVAT.
A.D. 1786
Comunque mi fossi certo di oltrepassare i limiti segnati alla presente narrazione, anticipando eventi che nel mio proponimento non dovea descrivere, pure non mi regge l’animo chiudere questo articolo, senza sciogliere un tributo di lode a’ promotori , benefattori, e fratelli tutti della detta congrega, nel trasformare radicalmente, ed abbellire pochi anni fa la chiesa. Non declino i nomi per non offendere la loro modestia sarà obbligo del sodalizio tramandare alla generazione futura la ricordanza. Il miglioramento attuato non deve ascriversi a risarcimento più o meno notevole ed importante, ma a vera riedificazione. Dalla vecchia fabbrica appena se ne conservarono le due mura laterali della sola navata, ed a queste si è dovuto soprapporre nuova fabbrica per potervi innalzare la volta. Il rimanente tutto è nuovo, ed eseguito con finezza di ornato, e gusto architettonico, di bella ed armonica corrispondenza. Solo vi osservo la poca stabilità, e mi fa pena. È un’opera più di città che di paese di montagna, dove sventuratamente, bene spesso, imperversano venti e temporali gravissimi; e fortemente temo che l’opera non avrà lunga durata.
XXXVII
prive di storico interesse sono le altre due chiese; tuttavia mi è doveroso menzionarle per tramandare ai posteri la memoria. Quella de’ Morti è inerente alla parrocchiale; forma però corpo distinto di fabbrica. Anche la sua origine si perde nella scura nebbia del passato. In essa il solo altare principale è degno di nota, confezionato nel 1788 con belli e pregiati marmi. Presentemente la chiesa vien tenuta dalla congrega omonima, istituita dall’Arciprete D. Francesco Mascia. Gli statuti di fondazione, approvati dal Vescovo nel 1733, ottennero il Regio exequatur a’ 30 marzo 1778.
Il sodalizio, retamente e con speciale cura amministrato, ha non solo ampliata e decorata la chiesa, ma con grossa spesa innalzata nel Camposanto una cappella, con nicchie separate, per la tumulazione de’ trapassati fratelli. Se con pari zelo ed onestà proseguirà a vivere ed amministrarsi, prospererà rigogliosa per lunghi altri anni.
L’ultima chiesa S. Rocco è sita fuori l’abitato, in una località che porta il suo nome. Essa, senza esimii e singolari pregi, è simpatica ed ariosa. La scritta incisa sull’architravato, fa crederla edificata da Berardino Patella nel 1577; la tradizione la ritiene opera più antica; e che Patella, trovandola quasi completamente distrutta, la fece col suo denaro riedificare. Come fabbricato isolato, esposto a tutti i venti, bene spesso è incorso in questo crudo destino, che fatalmente si rinnoverà col volgere degli anni.
La rendita particolare, ben tenue, si amministra dalla Congrega di Carità, che poco prestasi agli annuali bisogni del fabbricato, e nulla pel Culto e servizio religioso.
La popolazione, che venera il Santo con speciale devozione, con volenteroso animo, vi provvede, e nel 1886, in attestato di costante affetto, ed in rendimento di grazia pel superato pericolo del Colera, che appena toccò il Comune, mentre nelle invasioni del 1837 e 54 mietuto ne aveva molte di vittime, con spontanee offerte, ha decorata la Chiesa con altare di marmo.
XXXVIII
Oltre le descritte Chiese, eravi nel Comune la Cappella di S. Caterina, edificata e largamente dotata da Nicola Altieri, che posteriormente la donò al Clero Ricettizio. Passata anche essa al Fondo Culto, con gli altri beni dotalizii del Clero, per effetto della legge di soppressione de’ 15 agosto 1863, vennero a mancare gli annuali accomodi, e la Cappella gi giorno procedeva alla totale disfatta. Un incendio casuale ne accelerò la ruina, distruggendola in gran parte. Riuscite vane tutte le istanze presentate dal fondo Culto pel riaccomodo , il Sindaco del Comune, importunato da’ quotidiani reclami de’ vicini, che pregiudizio enorme ne ricevevano, fece rifabbricarla a spese del municipio, adibendola per uso profano.
Ultimo fra gli edifizii religiosi del Comune è la Cappella del Camposanto: fabbricato de’ tempi nostri. Piccolo e semplice edifizio, ma arioso e decente, bastevole per l’esercizio di Culto in quel modesto soggiorno de’ trapassati. Essa vien mantenuta dal Comune con sufficiente decoro.
XXXIX
Menzionata la cappella, ragion vuole si faccia parola del Camposanto stesso, opera principale, voluta ed ordinata dal dettato legislativo. Le popolazioni, ed in modo speciale quelle dei piccoli comuni, si mostrano sempre tenacemente avvinte alla prische consuetudini; ed il vivere degli avi segna la regola di loro vita. Per essere il quod vetus verum è il solo principio imperante che regger deve la famiglia e la società. Principio che, se giustissimo ne’ misteri essenzialmente immutabili di fede religiosa, addiviene assurdo ed irrazionale negli atti della vita materiale, sottoposta al progresso del tempo e della scienza. Le innovazioni più innocue e di lieve conto, qualora in opposizione, o semplicemente destinate a modificare le antiche abitudini. Fatto doloroso, dominante anche oggi che la civiltà ha fatto largo margine a molti inveterati pregiudizii. Qual dunque dovea essere ne’ passati anni, quando l’istruzione letteraria credeasi un pericolo, un male, ed i provvedimenti sanitarii un lusso ozioso? Ognuno facilmente può immaginarlo. Non deve perciò sorprendere chicchessia se, molti comuni, differissero lungamente a chiudere le sepolture nelle chiese dell’abitato, adottando il savio provvedimento della tumulazione, o inumazione ne’ cimiteri, uniformandosi alla legge degli 11 marzo 1817.
Ad esplicare questo indugio, sconvenevole a popolo civile, fa d’uopo anzitutto notare che, le modifiche, ed eccezioni introdotte col posteriore R. Decreto de’ 12 dicembre 1828, fecero in gran parte oscurare la saggezza della prima legge, e ne sfruttarono la bontà del concetto. Gli articoli 12, 13, 15 di quest’ultimo decreto, creando esenzioni e privilegii, mossero ne’ popoli sentimenti di generale diffidenza, scorgendovi perpetua la disuguaglianza sociale anche dopo la morte. I nobili, i ricchi, i potenti del secolo delle sepolture gentilizie nelle chiese dell’abitato, e gli altri della plebe, agli umili solchi de’ cimiteri: e la legge, che era opera di civiltà e progresso, generò sospetto ed avversione. Molti sindaci, comunque dotati di sano intendimento e buon valore, non potendo sospingere audacemente il popolo all’altezza di questo perfezionamento sanitario, senza temerne risentimento….indugiavano.
A rivendicare però, presso la generazione presente e futura, l’onore de’ nostri amministratori, che in quel tempo ressero il comune, fa d’uopo tener presente, non l’esito finale, ma i fatti che lo precedettero, e da essi risulterà evidente che non si fecero intimidire da’ clamori del popolo, né ricalcitrarono al disposto legislativo. Il camposanto, se non venne con prestezza costruito fu solamente effetto fatale di errore nella scelta di opportuno luogo.
L’altura soprastante il paese, detta Agraria, prima località a tal uopo designata appena promulgata la legge, se rispondea al fine della pubblica igiene, presentava, massimamente nell’inverno, gravissimi ed insormontabili al trasporto ed inumazione de’ cadaveri. Le continuate rimostranze manifestanze a questo scopo da uomini competenti ed imparziali, obbligarono il municipio, comunque i lavori di cinta in muratura si trovassero bastantemente inoltrati, prima ad ordinarne la sospensione, e dopo serio e maturo esame a rinunciare completamente al progetto, con troppa leggerezza antecedentemente adottato. A questo errore deve limitarsi la responsabilità e la colpa degli amministratori.
La qualità del terreno, nelle vicinanze del paese, non offriva molta latitudine per la scelta. Dovunque scoscendimenti e franature; e per la natura impermeabile del sottosuolo argilloso, le acque piovane, o sorgive, rimanevano lungamente nel solco aperto per l’inumazione. Dopo molte perplessità, fu ideato attuare il nuovo camposanto addossato alla chiesa di S. Maria, creandosi, i reggitori del comune, facoltati a ciò operare, dall’articolo 3° de R. Decreto del 1828, che prescriveva «attaccati alle chiese rurali, che servirebbero per cappelle de’ medesimi.»
Incominciarono i nuovi lavori, spreco di altro danaro, e perdita di maggior tempo. Le autorità tutorie della provincia si opposero al proseguimento dell’opera, non ritenendo la Chiesa di S. Maria come rurale, perché non distante dall’abitato 100 passi, e per soprappiù giacente nella pubblica e principale strada d’ingresso del comune. Intanto il denaro erasi non speso, ma inutilmente barattato, e le finanze erano esauste, perciò varii anni trascorsero nell’inazione dell’impotenza.
L’epidemia colerica del 1837, che per la prima volta venne a funestare il comune, imponeva sollecito provvedimento. Era imprudenza vituperevole maggiormente indugiare. Si propose e venne ad esecuxione un cimitero provvisorio cinto di muro a secco, in una località che presentava minori ostacoli, ed in esso furono sepolte le copiose vittime del morbo, in quell’anno di tristissima ricordanza, e nel seguente che il vajuolo arabo fece maggiore strage.
Passata l’epidemia si diè mano al definitivo cimitero, poco lontano dal provvisorio; modificando la qualità del terreno acquitrinoso, con canali di scolo, ed altre opere di prosciugamento, che venne sollecitamente a compimento.
Per controversia, poco onorevole, insorta tra Municipio e Vescovo, in ordine al servizio religioso, la benedizione del cimitero con l’apertura al pubblico esercizio, venne ritardata fino al 1845.
La prima inumazione videsi turbata del popolo che, tumultuosamente, invase il cimitero, cercando con pianti e schiamazzi impedirla. Placato ed a più miti e razionali sentimenti condotto dalle esortazioni delle autorità ecclesiastiche e municipali accorse sopra il luogo, si quietò; né in prosieguo si è più commosso.
Aboliti, poco dappoi, i privilegii de Real Rescritto del 1828, la popolazione incominciò, ed ora continua con maggiore studio ed affetto, a coltivare di religiosa divozione l’ultima dimora de’ cari nostri morti.
La cinta in muratura presenta la figura di un quadrato, misurando ciascun lato palmi 200, cioè metri 52,91. Internamente trovasi diviso in quattro compartimenti, con viali arborati da cipressi, piante da giardino, ed aiuole di fiori. A’ due lati del cancello d’ingresso, parte esterna, sonvi due casette una pel custode, e l’altra pel deposito dei cadaveri. In fondo, parte interna, e di prospetto al cancello, si vede la cappella. Se avesse un ossario ben formato, ed un sistema regolare di numerazione, nulla lascerebbe a desiderare: né sarebbe da meno di quelli delle grandi città.
XL
Fin da’ più remoti tempi eravi nel Comune lo Spedale Civile, destinato a’ poveri infermi. Il Vescovo Diocesano Mons. Cavalieri ne ordinò la chiusura, verso la fine del secolo XVII. Dai reclami, riboccanti acrimonia, presentati al Barone degli amministratori comunali, soli documenti esistenti, non mi è facile rilevare la causa vera della soppressione, né posso peritarmi a sentenziare, col solo mio giudizio in materia sì delicata.
Per la santi del Prelato che ne decise la sorte, è da supporsi che il provvedimento fosse creduto necessario. Il vescovo stesso s’impadronì del locale e delle rendite, che in prosieguo (ignoro l’epoca precisa) vennero rivendicate ed affidate all’amministrazione di Beneficenza, ora Congrega di Carità, che tutt’ora le governa, erogandole in gran parte per medele a’ poveri.
Chiunque, movendo da’ principii che attualmente imperano nella moderna società, volesse riesaminare l’operato di quei Vescovi, molte volte Prelati eminenti per probità, dottrina, e sanità di vita, come il Cavalieri, i quali a loro talento disponeano de’ laicali istituti della Diocesi, dovrebbe severamente giudicarli; eppure i loro atti, almeno ecclesiasticamente parlando, erano incensurabili, perché conformi a’ decreti del Concilio di Trento, ch enel 1563 avea ultimato il lavoro di riforma.
A me Sacerdote non lice chiosare i principii sanzionati da’ PP. Del Concilio: del resto se n’è scritto e declamato pur troppo pro e contra, dai sostenitori del Trono o dell’Altare, da renderne superflua un’ulteriore discussione. Come storico debbo sol far notare che i Canoni del Tridentino non vennero tutti legalmente accettati ne’ dominii Spagnuoli e fra essi trovavasi il regno di Napoli.
Il Re Filippo II, con la solita doppiezza, no volendo apertamente opporsi al S. Pontefice che ne ordinava l’esecuzione, ne permise la promulgazione, senza l’Exequatur, dando in pari tempo segrete e precise istruzioni a’ Ministri, e per le Province Napolitane al Vicerè duca d’Alcalà, di ostacolare, in tutti i modi, quei decreti che potessero ledere la sua autorità, giurisdizione, e regalie, e che fossero in opposizione alla consuetudini locali; ed i Vicerè tennero fermo. Ma la persistente costanza de’ Vescovi non rallentava giammai, ed in prosieguo il freno addivenne meno duro, specialmente dopo la morte del Duca d’Alcalà.
Ciò premesso, per dottrina del Concilio, i Vescovi avean dritto non solo di visitare cotesti ospedali, ma occorrendo, anche di rimuovere gli amministratori, sostituirvi altri, punirli, chiudere lo stabilimento, commutare la volontà degl’ istitutori, ed applicare ad altri usi la rendita. (1)
I Vescovi, chi per sentimento, e chi per ubbidienza, si avvalsero della nuova prerogativa, come già se è veduto pel nostro Spedale. Debbo però credere, che gli Ordinarii Diocesani, non ricorrevano a cotesti rimedii radicali, se non negli estremi bisogni, quando cioè si convincevano che, con i mezzi di mitezza, non poteasi raggiungere lo scopo di moralizzare l’istituto.
(1) Tridentino Ses. 22 e 25 de’ Ref. Cap. 8 – Giannone li. XXXIII. Cap. III
XLI
Non posso trasandare senza ricordanza un altro antico Castello, detto la Torre, sito nel nostro tenimento, a mezzogiorno del Comune, dal quale dista un paio di chilometri; e propriamente edificato al piede del Monte S. Felice, vicinissimo alla via denominata Egnazia.
Mi è doloroso però non poterne produrre, come vorrei, precise notizie e documenti certi che difettano, perciò mi limiterò al generale e probabile.
E da tutti ritenuto essere la Torre un antico Castello, e nei primi tempi del dominio Baronale n’esisteva qualche parte, tanto che i Baroni l’adibivano per riporvi paglia e derrate. Ora non vi rimangono che gl’ informi ruderi ed il nome, appellandosi quella località la Torre.
Da chi, a quel fine, ed in che epoca venne edificato, la storia ci tace, né è facile con altri mezzi assodarlo. Credo sol necessario, affinché i lettori intelligenti, col proprio giudizio, possano colmare il vuoto della storia e della tradizione, far notare che, il detto castello, trovasi sottoposto ad un altro, parimente antichissimo, detto S. Felice, che poggia sul vertice che porta l’istesso nome.
Monte che attualmente fa parte del tenimento di Castelluccio e Celle S. Vito.
Nel castello S. Felice, Federico II fece rinchiudere, per qualche tempo, il ribelle figliuolo Errico, che dopo il primo perdonom nuove congiure ordiva contro il padre. «Ma nuovi raggiri, dice l’istorico Leo, indussero l’Imperatore a farlo prigioniero, poscia fu chiuso nel Castello S. Felice in Puglia, e morì fra lacci a Martinora l’anno 1242» (1).
Da persone pratiche del luogo mi viene assicurato, che fra questi due Castelli, S. Felice e la Torre, dovea anticamente esservi una interna comunicazione. Fra i ruderi del Castello S. Felice si è osservato fino ad ora una specie di pozzo munito di cancello, che facilmente potea discendere nella sottoposta caverna, che fa parte del Castello la Torre, e che molto si addentra nella montagna.
Con questo interno passaggio, facile addiveniva a’ presidii de’ due Fortini, prestarsi vicendevole aiuto ed assistenza; e, nel caso d’impotenza a resistere al nemico, evadere per l’uscita più libera.
Non sarebbe impossibile verificarne il fatto, ma occorrendovi, per sgombrare macerie e franature accumulate da molti secoli, grandissima spesa, e mancando che prodigamente voglia barattare il danaro per semplice curiosità, che non ha neanche vitale importanza storica, non sarà giammai assodato, e rimarrà semplice congettura. In ogni modo, ritenuta per vera questa interna comunicazione o galleria coperta, rimarrebbe assodato che il Castello Torre, era in qui remotissimi tempi fortezza ausiliaria della Città antichissima di Crepacore, da molti secoli completamente distrutta; precisamente come si ritiene per S. Felice. In tal caso i due fortini formavano una sola fortezza con due sbocchi: né potrebbe reggere l’opinione di coloro che sostengono essere anche il Castello Torre opera dei Greci, come Troja, Castelluccio etc. e destinato a prendere il posto di primo propugnacolo della cortina di fortificazioni intorni a Troja. Comunque sia, bastami averne fatto cenno; lascio ad altri la cura di precisarne, se è possibile, i fatti storici che gli potrebbero competere, e che arrecherebbero giovamento alla storia di Castelluccio, nel cui tenimento si rattrova.
La Torre, terreni adiacenti, ed altri beni che costituivano i Burgensatici Baronali, fopo la morte del Conte della Saponara, che ricevuti li avea dal Principe della Riccia, come si è veduto al N. XIX, pervennero per donazione anche essi allo stato, che posteriormente li concedette al celebre Cardinale Ruffo «in remunerazione dei benefizii orestati alla Corona.» Ora si posseggono dal Principe di S. Antimo.
(1) Leo storia del medioevo vol. 1. lib. IV. Cap. VIII pag. 363.
XLII
Non è di lieve importanza rammentare i monumenti antichi che, pei cultori di archeologia, sono oggetto di speciali studii, e profonde mediazioni. Sento però il bisogno, a fine di appagarei voti degli apostoli del passato, far parola di una lapida con iscrizione antichissima. Chi non nutre affetto, o semplice curiosità per tali studii, può sorvolare su questo numero, che del resto darà brevissimo. L’enunciata lapida fu rinvenuta nel 1809, a circa due chilometri dal comune, quali alle ultime falde de’ Sub-Appennini, nel luogo detto Mezzana di Sarni, da agricoltori che divegliavano il terreno per piantarvi vigne. E una lapida ben formata dall’altezza di circa un metro, dalla larghezza di due terzi, grossezza un terzo, bellamente lavorata, e fregiata di cornice e rilievo. Facea partedi un piccolo monumento che, all’epoca della scoprimento, andato in ruina, giaceva sepolto nel terreno, costituendo una massa informe di rottami.
Il Sindaco di quel tempo D. Giuseppe Tango, cultore esimio di scienze e lettere, la reclamò, facendola collocare nel largo che precedeva la Chiesa Parrocchiale, ove attualmente si rattrova. Con l’scrizione, che nella lapidasi leggea ad occhio nudo, si trascrive l’interpretazione data, comunque questa non soddisfi pienamente; e quello che maggiormente ne costituisce il vuoto, non è corredata da alcun cenno illustrativo.
NVMINI Vitale Severo liberio di Cajo
MERCVLIS Uomo chiarissimo della Regione
ACHEVNTI Siritida, liberamente sciolse
NI VITALIS Il Voto al Nume Ercole
CL SEVER CV Acheruntino
SIR REG Napoli 1812
V L S L’Abbate Romanelli
Molti sarcofagi si trovano disseminati nel tenimento del comune, specialmente nella parte montanina settentrionale, contrassegnati da monogrammi, ed alcuni da iscrizionilatine, ma di niuna importanza; non scorgo quindi il bisogno di riportarle.
XLIII
Nel periodo lunghissimo di circa tre secoli, cioè dalla costituzione de’ tre comuni a Baronia, fino al 1734, quando Carlo Borbone, figlio di Filippo V Re di Spagna, conquistò il Reame di Napoli, Casrelluccio visse la stentata vita degli oppressi, per nequizia de’ Baroni, come innanzi si è veduto, e per la Signoria Spagnuola che orgogliosa tiranneggiava lo Stato retto, a Vice-reame. Oltre le notizie qua e la riportare ne’ numeri precedenti, quasi nulla di notabile ne rimane a narrare.
Dovrei rammentare la peste ferocissima, che, importata in Napoli da nave Sarda nel 1657, si propagò prestamente in quasi tutte le province del regno, facendo in ogni luogo crudele esterminio.
Sarebbe una narrazione desolante de opprimere lo spirito dello scrivente e de’ lettori; e neanche facile a farsi, non rattrovandosi di essa nel comune cronaca particolareggiata, o altro documento, ma sol vaga ed incerta tradizione; quindi la narrazione de tale calamità non potrebbe essere addolcita da episodii eroici e commoventi, o da altri sublimi atti di carità, di religione, e di virtù cittadine che, quasi sempre, nelle grandi sventure brillano come luminose meteore, per confortare l’animo dell’afflitta umanità. Il male, per se stesso grandissimo, veniva poi aggravato dall’incuria degli uomini. In quei tempi, se le regole e prescrizioni igieniche non erano tutte e da tutti ignorate, dal popolo però venivano costantemente osteggiate e derise; e la voce de’ buoni e de’ savii rimanea soffogata dalla stolta ed assurda credenza della plebe ignorante.
In nessuno dei comuni infetti dal morbo fu possibile precisare il numero delle vittime. Gli storici si limitarono a proclamarle innumerevoli, e così dovea essere. I decessi della moria non si denunciavano, né si poteano denunziare. Il libro parrocchiale del nostro comune non registrò, per tutto quell’anno, che quattro morti. Mancava chi ne assumesse il penoso ufficio. La gente, come ne parla Giannone, periva ne’ campi, sugli usci delle case, nelle scale, nella pubblica via, nelle Chiese, dovunque, periva di assistenza, ed anche di braccia per seppellirla; e lo sgomento generale, rilasciando i vincoli della carne e del sangue, facea trasgredire i più santi doveri; ed ognuno viveva a se, preoccupato dell’incertezza del dimani. Sorvoliamo dunque su questo nefasto evento del secolo XVII, e passiamo a più lieti argomenti, che rinfrancano l’animo, e giovano alla storia.
Il novello Re Carlo di Borbone (1), nel salire al Trono delle sue Sicilie, benchè giovanissimo, mostrò maturo senno, capacità a regnare, fermezza di carattere, ed amore pel benessere de’ popoli conquistati: ed i sudditi desiderosi di tranquillità da gran tempo sperata, paghi dell’ottenuta autonomia a Regno indipendente, accettarono il Sovrano con piacere, fiducia e riconoscenza, temperando l’irrequietezza del loro animo, col desiderio di miglior sorte.
In una regione ove tutto dovea mutarsi, tutto in miglior forma ordinarsi, necessitava lungo e tranquillo Regno di Principe dotato di mente e di cuore, coadiuvato da Ministri e consiglieri che fossero all’altezza della difficile missione. Re Carlo non difettava di arte di governo, ma non potea da se tutto operare, e per evitare scompigli, bisognava che le riforme procedessero per gradi.
I tempi non erano ancora propizii a larghe concessioni faceva duopo andare innanzi con molta prudenza, e sano accorgimento. Mentre prodigava sue cure a promuovere nel Reame le opere di pubblica utilità pel benessere dei popoli, dovè fermarsi. Avvenuta la morte di Ferdinando VI Re di Spagna, i diritti di successione lo richiamavano a reggere i destini di quello stato.
Non potendo le die Corone di Spagna e di Napoli, pel trattato di Vienna, rimanere giammai unite, dovè quindi rinunciare a quella di Napoli. Per colmo di sventura, non comportando diversamente la posizione di sua crescente famiglia, dovè abdicare in favore del terzo-genito Ferdinando; ragazzo di appena otto anni, che con prammatica de’ 6 ottobre 1759 venne proclamato e riconosciuto Re sotto un Consiglio di reggenza.
(1) Comunemente veniva nominato Carlo III: Clemente XII però, nel concedergli l’investitura del Regno, lo chiamò VII. Ma Carlo, dice Colletta «fosse politica o vaghezza non oppose il numero, e si chiamò negli editti come innanzi della investitura» – Lib 1. N°XXXIV
Il lavoro di riforma trovavasi appena incominciato; se ne richiedea il proseguimento con vedute più vaste, e meglio rispondenti a’ bisogni crescenti dello stato. Il Ministro Jannucci, che facendo parte della reggenza ne era l’anima, avea eminenti, dice lo storico Colletta, due sole passioni, sciotere cioè e prostrare il ceto Ecclesiastico e Baronale. A questo ideale convergeva il suo indirizzo, e la sue energia, lasciando molte altre leggi di maggiore urgenza nello stato di desiderio, senza tener conto degl’interessi di tutti gli orfini componenti il consorzio sociale.
In ogni modo l’istesso Colletta, bastantemente severo contro questo ardito uomo di stato, conviene che qualche cosa di buono da lui venne al reame. Le savie leggi promulgate durante il Regno di a Carlo e della reggenza, alle quali vi avea potentemente contribuito come ministro, con gli anni acquistando maggiore sviluppo ed incremento, arrecarono a’ sudditi benefizio grandissimo. La libera uscita delle derrate dal regno, la viabilità interna migliorata con ponti e strade, i trattati di commercio sottoscritti con le estere nazioni, la magistratura, il sistema ipotecario, e non pochi altri provvedimenti, rimarranno come monumenti imperituri di savia legislazione.
Si potrà giudicare leggera vanità l’aver qui riprodotti eventi di storia generale a tutti ben noti, senza che i miei concittadini, col senno o con le armi, vi abbiano contribuito nel promuoverli e rafforzarli; però non potea dispensarmene, segnando il regno di questo insigne monarca l’era novella dell’economico risorgimento del comune.
Migliorare il proprio stato con l’agiatezza della vita è la naturale tendenza dell’uomo : ma tale imperiosa necessità viene, molte fiate, resa inefficace ed impotente, dalle pubbliche calamità, dal continuo timore, dall’incertezza del dimani, e da tante e tante altre cause, che affievoliscono le forze del più audace; e l’uomo sconfortato, perdendo di vista il fine, ricade nel torpore dell’inerzia.
Tale era la miserevole condizione de’ nostri contadini prima della venuta di Carlo III. Le derrate che, a stento, venivano sottratte alla cupidigia de’ Baroni, ed alla rapacità degli agenti Vicereali, non ottenevano che prezzo vilissimo. A che serviva estendere la seminagione, se il prodotto non riusciva rimuneratore?
I coloni quindi si limitavano a quel tanto, che necessitava ai bisogni della famiglia, bastando a tal uopo i pochi terreni sativi che circondano il paese; oltre non si procedea.
Le riforme introdotte nel reame da questo eminente Monarca ricondussero, in certo modo, il benessere nel popolo, e fecero sorgere in esso nuovi e serii propositi di estendere la semina dei cereali, e slanciarsi ancora in lavori più produttivi, con la trasformazione agricola.
Ben compresero che l’attività, per essere di pratica utilità, deve offrire reali vantaggi, che si ottengono prescegliendo la coltivazione di quei prodotti che mancano, e dei quali si ha maggiore bisogno. Castelluccio difettava di vino e olio; necessitava quindi dedicarsi ad impiantare citi ed olivi, se realmente si aspirava al sopravanzo della richezza.
Nel tenimento non vi erano che poche vigne, con pochissime piante di olivi; ma tanto bastava a convincere anche i più ostinati che tali prodotti prosperavano benissimo sotto questo clima, e su questo suolo; e specialmente nelle collino sottostanti al paese, con propizia esposizione a mezzogiorno.
Gli agricoltori si accinsero perciò all’opera, con la coscienza di bene operare; e le loro fatiche furono largamente rimunerate. Sul principio si procedette lentamente; ma col volgere degli anni, il graduale piantamento ottenne espansione maggiore; in modo che alla fine del secolo XVIII, quasi un terzo de’ terreni coltivabili trovavasi rivestito di questa bella e proficua piantagione.
Contribuì moltissimo a diffondere tale coltura il Clero, ed anche alcuni propietarii secolari, concedendo in enfiteusi a’ poveri agricoltori, con canone tenuissimo, i terreni da trasformare; ed i coloni, dopo non molti anni, raccolsero il frutto de’ loro sudori, con l’aumento della ricchezza locale. Sventura ha voluto che la crittogama abbia devastato gli estesi vigneti; resta almeno ora il ricolto delle olive, a temperare un poco l’amarezza del patito danno.
XLIV
La divisione del reame continentale di Napoli in dodici provincie, col nome di Giustizierati, da molti storici si attribuisce all’Imperatore Federico II. Ma molto bene osserva Giannone, sorretto dall’autorità del Fassone, l’opinione non è strettamente vera; del perché né Federico fu il primo, né in quei tempi i Giustizierati, aveano questo numero. I Re che seguirono, specialmente Carlo I d’Angiò, Alfonso d’Aragona, ed anche Ferdinando il Cattolico, attesero con studio e diligenza grandissima ad ordinare la circoscrizione amministrativa in dodici province, e a delinearne i confini.
Ma anche dopo questo riparto ed assegno esse si manteneano costantemente immutate: molte fiate avveniva che, per accrescerne una, per comodità degli amministrati, o per altro qualunque siasi motivo di ordine pubblico, se ne diminuivano altre limitrofe; ed i Comuni di confine spesso passavano a novella circoscrizione e Provincia.
Nei primi tempi di sua esistenza, a quale Provincia o Giustizierato appartenea Castelluccio?
Non mi è facile accertarlo; né posso soffermarmi con sicurezza alle parole di Giannone, riportate innanzi al N°XXIV «in terra di Basilicata» perché verso la metà del secolo XVI questo comune, da molto tempo, apparteneva alla Capitanata. Se altri argomenti e prove mancassero, e ve ne sono moltissime, basta quella della Baronessa Eemilia Carafa che, nella conferma de’ Capitoli Baronali nel 1576, dice «Baronia sita in Provincia di Capitanata». (1)
Quindi o deve supporsi errore materiale, o che il menzionato autore volesse cennare alla primitiva sua destinazione, antecedente cioè alla formazione della Provincia di Capitanata. Se non si può ritenere la prima, deve ammettersi la seconda parte del dilemma.
È innegabile che Casetlluccio fin da’ tempi di Federico appartenea alla Capitanata, come l’istesso Giannone, nel segnare i limiti, riferisce «La Capitanata col fiume Ofanto nel suo principio si divide dalla Basilicata; e con l’Appennino in Crepacore ed in Sferracavalli ha i suoi confini con Principato Ultra» (2)
Bisogna però notare che a’ tempi di questo Imperatore, comunque la Puglia si trovasse divisa in tre Province, pure il Giustizierato era un solo, residente in Bari, che le governava tutte.
È certissimo benanche che Castelluccio in prosieguo passò alla provincia di Principato Ultra Avellino, e vi rimase ancora dopo la legge 8 dicembre 1808.
Con la riforma amministrativa de’ 20 maggio 1817, defenitivamente ritornò alla Provincia di Foggia; distretto (ora sottoprefettura) di Bovino; Circondario (Mandamento) di Troja, come attualmente si trova. Comunque i popoli mal soffrano l’impero restrittivo delle leggi, aspirando continuamente ad ideali che giammai potranno raggiungere, pure con la legge amministrativa del 1817, non immune da imperfezioni, i comuni, se non ottennero benessere ed autonomia, si ebbero almeno un poco di ordine, e con l’ordine una più regolare amministrazione del patrimonio comunale,
(1) Capitoli Baronali fol. 47 – (2) Giannone Lib. XVII cap. V n. IX – Capitanata
XLV
Nello scrivere le presenti note, mio scopo si era tratteggiare la storia antica del Comune; pure molte volte, a dispetto del proponimento, ho trascorso od oltrepassato il limite che mi era imposto.
Non potendo dispensarmene, per l’interezza della materia narrabile, ne ho limitato l’arbitrio, restringendomi a fatti di non grave importanza, e che da se soli non costituiscono materia essenziale di storia moderna. La storia contemporanea, feconda di estraordinarii, strani, o come vuolsi, portentosi avvenimenti, è ben degna di accurato esame e speciale narrazione, né può farsi inconsultamente, senza seria e matura ponderazione, e senza un corredo di documenti.
Non è cosa facile e di lieve portata descrivere i quattro principali rivolgimenti del 1799, del 1820, del 48 e finalmente del 60, per effetto de’ quali, i principii di libertà e novità, insinuandosi gradatamente nella pubblica opinione, e sconvolgendo le antiche idee di governo nei popoli, son pervenuti a radicalmente trasformare le vecchie istituzioni, immutando completamente l’ordinamento politico e dinastico della penisola Italiana.
Narrare le cause del perturbamento, i mezzi che lo generarono, gli uomini che vi contribuirono, nonché gli effetti che il novelli ordine sociale ha prodotto, non si appartiene essenzialmente alla cronaca di un piccolo comune. Le piccole località, per esser degne di peculiare menzione, dovrebbero operare fatti non ordinarii, e di capitale importanza. Ma come, ed in che potea estollersi Castelluccio? Nel movimento generale ga dovuto prudentemente limitarsi, come tutti i deboli, a seguire la corrente, l’impulso ed il volere dei più forti.
Non voglio con ciò dire, a discapito del decoro ed onore del mio paese, che sia stato puramente passivo, o che l’elemento colto non abbia caldeggiato il progresso, o che non possa vantare fatti degni di nota, operati da uomini rimarchevoli per intelligenza e patriottismo; ma per questa minuta esposizione, che si appartiene più alla storia biografica delle persone, che agli eventi generali della storia, fa duopo, dovendo a ciascuno dare la lode o il biasimo meritato, (trovandosi fatalmente al bene sempre frammisto il male) avere pacatezza di animo, discrezione, ed imparzialità; ed il tempo non è ancora propizio, né chi scrive si crede ben sicuro adempiere tale delicatissima missione, spoglio di pregiudizii ed errori.
I vivi, in qualunque modo trattati, si ribellano facilmente alla voce dello storico, che inesorabile agli umani rispetti, alle affermazioni di parte, a’ vincoli della carne e del sangue, se non vuole avvilire e falsare la propria missione, deve giudicar tutti con l’inflessibile misura del vero. Compito ben difficile; e sapientemente il Conte di Cavour dettava non doversi scrivere la storia contemporanea, se non trascorsa la metà di un secolo.
Si rimandi dunque a miglior tempo la parte sostanziale di questa storia; e mi sia indulgente l’amico lettore, se in brevissimo compendio, senza tema di essere contraddetto, o accusato di esagerato patriottismo, enuncio a sostegno essersi Castelluccio, nel sobollimento generale, de’ quattro cennati politici rivolgimenti, mostrato sempre tenacemente attaccato all’impero dell’ordine e delle leggi: avversando con forza ed energia qualunque siasi atto tendente all’anarchia, alla rapina, al libertinaggio. Se questo no è un merito peregrino, addita però chiaramente che il comune, nella sua maggioranza, non è perverso e corrotto; giacché, al dir di Macchiavelli, «un popolo corrotto non può mantenersi ne’ limiti della libertà, e conservarla».
Né è men vero che tal principio direttivo di ordine non può ascriversi a virtù negativa della popolazione, e i fatti posteriori lo comprovano a sufficienza; ma a deliberato studio di pace, di tranquillità cittadina, e di vivere sociale, nota caratteristica del popol nostro.
Che i veri partiti politici abbiano contribuito efficacemente al retto esplicamento della sana libertà non v’ à chi ne dubiti; ma i partiti procedenti da controversie personali, da interessi particolari, da ambizione, da superbia, insomma dall’amore al trionfo del proprio Io, non essendo coordinati e diretti al pubblico vantaggio, furono sempremai, come tuttora sono, di pregiudizio e ruina a’ popoli: né le amministrazioni potranno reggersi ed avvantaggiarsi con lo spirito sovversivo di partito, orpellato da libertà. Compenetrati da questi savii sentimenti, ed ammaestrati dalla storia, non solo la parte colta e dirigente del Comune, ma gli altri inferiori ordini di cittadini, con esemplare emulazione, e con nobile gara di generosi sacrifizii, affrettaronsi, specialmente nelle due ultime rivoluzioni, ad immolare sull’ara della patria i proprii risentimenti, ed anche i principii politici, per non porgere occasione a’ malevoli, che dovunque non mancano; di profittare delle discordie cittadine, pel trionfo deo criminosi loro disegni.
Questa concordia produsse ubertosi frutti. Il Comune, libero da perturbazioni violenti, non risentì gli scrolli della rivoluzione, e costantemente si mantenne ordinato e pacifico. Ed oh! Di quanto giovamento sarebbe riuscito alla patria amministrazione, ed all’onore del paese, se tale concordia fosse perduta anche dopo cessato il pericolo.
Sventuratamente lo strazio vituperevole che si fa della libertà, degenerata in libertinaggio, ha fatto pullulare e moltiplicare i partiti anche nel pacifico ed ordinato Castelluccio, a discapito della pace dei buoni, e del pubblico interesse. Tal fatto maggiorente è doloroso perché i nostri partiti non si svolgono per vere divergenze politiche, o amministrative, ma pel turpe interesse di abbrancarsi all’albero della cuccagna delle sostanze municipali. Se la mia dura censura, poggiata a’ fatti che gli onesti lamentano, ha forma restrittiva pel solo Castelluccio, non è perché esso solamente sia affetto da questa lue cancerosa, mentre conosco benissimo che è piaga generale, ma perché non mi è lecito sindacare comuni estranei alla nostra storia.
Si sa che il rispetto alle leggi cessa nei periodi delle rivoluzioni e delle sommosse, perciò è sempre gran ventura quando vi subentra l’azione illuminata ed energica degli uomini onesti e stimati, per risparmiare alla popolazioni, con la solerte loro opera, molti mali e molte lagrime.
Siffatto benefico concorso di uomini egregi per virtù cittadine, tenendo ad obbiettivo la tutela della vita, dell’onore, e delle sostanze del popolo, crebbe e si rafforzò, nel nostro comune, nell’ultimo rivolgimento del 1860, in ragione diretta della gravezza del pericolo. In quest’epoca memorabile di tumultuosa effervescenza, non trattavasi di frenare l’audacia de’ soli perturbatori interni del paese, ma strenuamente affrontare e difendersi dall’esterno nemico, combattendo la malefica azione del brigantaggio, che spietatamente desolò la nostra provincia, nel famoso triennio dal 1861 al 1863.
Per fatale concorso di circostanze, il nostro popolo, non potendo fare a fidanza sulla forza pubblica, che spesso mancava, dovè provvedere a tutti gli urgentissimi bisogni col personale proprio, a fin di sostenere con onore nell’interno la tranquillità, e nell’esterno la pugna con le numerose orde brigantesche, che spargevano, su questa misera contrada, desolazione e morte.
La milizia nazionale del comune, non seconda alle più animose ed agguerrite degli altri, si mostrò sempre degna di ammirazione nella difficile missione che sostenea; e fu in tutte le circostanze grandemente elogiata dalle autorità amministrative e militari. Con svariati e molteplici combattimenti, comunque male armata e scarsamente munita, fè soffrire a quei ribaldi, che scorrevano la campagna per predare e uccidere, senza distinzione alcuna di partito politico, delle frequenti e gravi perdite; né mai n’ebbe alcuna.
Ben diretta e comandata da uffiziali appartenenti tutti al ceto civile, che erano i primi all’attacco e gli ultimi alla ritirata, animosamente affrontò i gravissimi pericoli, non mostrando giammai le spalle al nemico, qualunque ne fosse il numero da combattere. Né la storia potrà rammentare le scene di lutto e di sangue, che crudelmente funestarono altre di comuni più popolosi, per fatale debolezza del ceto dirigente.
CONCLUSIONE
Il desiderio ardentissimo di ridare onorata fama al mio comune, mi ha mosso a raccogliere e pubblicare queste poche notizie di Storia Patria, le quali altro pregio non presentano, che la sincerità. Non m’illudo sul valore intrinseco dell’opera, né con sicuro viso mi aspetto il severo giudizio di uomini competenti nella materia. Le mie fatiche però, giova qui ripeterlo per l’ultima volta, non rimarranno tutte prive di frutto, se di forte incitamento e stimolo saranno ad altri migliori di me, per valore intellettuale e forze fisiche, nella ricerca paziente ed accurata di altri avvenimenti affievoliti, ma non spenti completamente nella tradizione locale. Se gli studiosi del paese, associandosi a’ miei principii, e dividendo i sentimenti miei, sapranno illustrando con maggiore precisione di fatti e copia di dottrina, ho raggiunto lo scopo. Poco monta che il mio nome, offuscato da questa novella luce, rimanga sepolto nell’umile avello che racchiuderà le mie ceneri.
Mi satis ampla
Merces, et mihi grande decus, sin ignotus in aevum.
APPENDICE
NOTA APOLOGETICA
Meminisse juvabit – Nell’esporre al N° XXIX il privilegio conservato dal Clero di Castelluccio sulla Chiesetta di S. Vito nell’agro del Comune di Celle, ne ho solaente mostrata la stabilità col possesso continuo da tempo immemorabile, nel fermo convincimento che, ad una prerogativa di pochissima importanza, bastasse questa prova che in tutte le legislazioni forma il punto do partenza della giustizia del diritto. Possessio stat pro titulo. Né potea immaginare che proprio in questo anno 1890, mentre mi disponea a pubblicare le precedenti note storiche, saltasse in testa a’ Signori Faetani turbarlo, risollevando le antiche pretese e le mal ferme aspirazioni. E comechè ad essi non poteano giovare le vie legali, speravano ottenere lo scopo con l’ardimento; e nel giorno 15 giugno, festività del santo, pretesero con la forza imporre al nostro Clero il loro volere.
Ho detto in generale i Signori Faetani, non in particolare il clero, perché stranamente in quel comune di ceto secolare, almeno la parte più irrequieta, s’intramette in tutte le questioni, anche di pura compattezza Ecclesiastica, come la presente, e le generalizza, affogando così la personalità Parrocchiale nel collettivo popolare. Se questo modo di operare sia in omaggio al principio Cavouriano libera Chiesa in libero Stato, lo lascio alla considerazione dell’intelligente lettore. E certo però che esso potrebbe produrre attriti funesti alla pace de’ due Comuni. La storia, per avvalermi dell’apotegma Ciceroniano, maestra della vita, insegna che, per l’eccitabilità della plebe, un nonnulla spesso genera disastrose conseguenze. Una secchia rapita promosse, nel principio del XIV secolo, sanguinosa e fraticida guerra tra Modena e Bologna.
Vogliono essi far credere comportarsi in tal guisa per amor di patria; sia pure: ma lo amor di patria è sempre amore, e l’amore è passione; e qualora esso non viene purificato dalla ragione e sorretto dalla giustizia, rispettando i diritti altrui, cessa di essere una nobile virtù, e si risolve nell’apoteosi dell’arbitrio.
S’illudono poi i nostri vicini nel ritenere che il Clero di Castelluccio non conservi altro diritto se non il solo longevo possesso materiale, che non venne mai né riconosciuto, né legalizzato dalle autorità competenti. Il fatto contrario distrugge l’ingiusta supposizione, ed i moltissimi autentici documenti rimuovono le erronee interpretazioni, con precisione e chiarezza di dottrina. Mi dispiace, non poterli qui riprodurre tutti ed estesamente, perché la presente nota addiverrebbe più voluminosa della scritto principale: mi restringerò quindi a pochi, ma sufficienti ad assicurare il diritto che si vuole oppugnare.
Mi giova innanzi tutto far osservare che il primo documento che si riscontra nel nostro Archivio Capitolare porta la data del 1595, emanato da Mons. Aldobrandini, prelato eminente, rivestito non della sola dignità Vescovile, ma anche di quella di Nunzio Apostolico nelle provincie Napoletane. Esso forma, per così dire, la palingenesia degli antichi diritti conservati al nostro Clero dal Cardinale Rebiba nella Bolla di separazione delle tre Parrocchie con la clausola: Salvis semper juribus et obedentia debitis et debentis, de jure vel consuetudine.
Sorvolando su di altri moltissimi decreti che i Vescovi locali emanarono in opportune circostanze a nostro favore, mi fermo a quello di Mons. Marco de Simone del 1759, non perché fosse il più positivo, ma perché riconferma i precedenti.
Da esso ne distacco la sola dispositiva.
Viso processu exibito, in eoque viso actum S. Visitationis ab anno 1595 sub Episcopo Aldobrantini, visis aliis decretis de manutantione, Episcopi Venetiani sub anno 1646, Episcopi Cavaleris anno 1715, Episcopi Faccolli anno 1728, et denum in anno 1752 Canonici Poppa Vicarii Capitularis, iisque inspectis ac consideratis idem Illmus et Rmus Dom. decrevit, Rev. Capitulum supradictum Castellutii, illiusque Archipresbiterum et presbiteros insignitos, fore et esse manutenendos in possessione, sen juris regendi, administrandi, obventiones percipiendi, animalia benedicendi, aliasque omnia facienda, quemadmodum ab immemorabili, prout in praemissis regere, administrare, percipere, benedicere, et facere idem Rev. Capitulum consuevit, prout presenti decreto manuteneri sub poenis exocomunicationis, aliisque nostro arbitrio incurrendis, contra trasgressores atque perturbatores ejusdem possessionis etc. Salvis semper nostris juribus, nostraeque Mensae Episcopalis Marcus Ep. Trojanus.
Oltre i decreti ricordati da Mons. De Simone, sonvi quelli di Mons. Sacchetti del 1654, di Mons. De Sangro del 1679 e 1690, e di altri Vescovi. Più un regolare giudizio fatto in Curia, nonché un ordine del Cav. Tommaso Verges Regio Consigliere, e Caporota della R. Camera di S. Chiara, e delegato della Regia Giurisdizione, che prescrive al Vescovo di far rispettare il diritto del Clero di Castelluccio sulla Cappella S. Vito.
Debbo ancora aggiungere che la Rev. Curia Vescovile alle censure ecclesiastiche, più volte poste e rinnovate, fè seguire nel 1778 le pene pecuniarie.
Pro quo effectu, dice il decreto, Rev. Archipresbiteri et praesbiteris Faeti et Cellarum, ad dictam Ecclesiam (S. Viti) non uccedant, neque jurisdictionem in ea exerceant, sub poenas ducatorum quinquaginta, piis usibus. Et ita verum intimetur et testatur. Datum etc.
Dopo le riportate disposizioni, che i signori Faetani non dovrebbero ignorare, e mentre è di pubblica ragione che essi mai esercitarono alcuna giurisdizione, non so come osano di tempo in tempo perturbare il legittimo possesso degli altri. Forse hanno prescelto tale espediente come metodo terapuetico per temperare gli ardori della pletora patriottica; facciano a loro modo; credo però il rimedio peggiore al male.
Dall’esercizio di questa prerogativa il Clero nostro mai ne ha conseguito vantaggio alcuno;
anzi più e più volte ha dovuto sobbarcarsi alla spesa de’ restauri dell’edifizio. Nel 1703, sotto il Vescovado di Mons. Cavalieri, per formare la piccola absida dietro l’altare, vi erogò duc. 50,00 – lire 212,50- . Senza diritto non avrebbe mai preteso ottenerne il possesso, né ora commetterebbe la viltà di reclamarlo; perché è pura viltà menare tanto scalpore, far tanto chiasso per una prerogativa di nessun valore. Ma giacché si ha, è doveroso non rinunciarvi, per l’istesso principio che riscalda il petto degli avversari.
Domenico Can. De Palma
FINE
ERRATA CORRIGE
Degli errori tipografici di cui si è accorto l’autore dopo la stampa.
| PAGINA | LINEA | ERRORE | LEGGASI |
| 24 | 3 | Rasilio | Basilio |
| 48 | 15 | Nondimeno | Liberalità |
| 63 | 19 | D’Aneroto | D’Assereto |
| 65 | 15 | 18 ottobre | 18 novembre |
| 121 | 21 | Riporto | Riparto |
| 123 | 17 | Più uomini | Pii uomini |
| 126 | 4 | Quoad honore | Quoad honores |
| 143 | 14 | Al danno vi contrinui | Al danno non vi contribui |
| 149 | 13 | S. Saterina | S. Caterina |
| 149 | 19 | 15 agosto 1863 | 15 agosto 1867 |
| 163 | 14 | MERCULIS | HERCULIS |
| 168 | 4 | Ministro Jannucci | Ministro Tanucci |
| 172 | 3 | Fassone | Tassone |
| 143 | Nota | Precipia | Precipue |
| 143 | Nota | Alantue | Alantur |
| 166 | Nota | Non oppose | Non appose |

